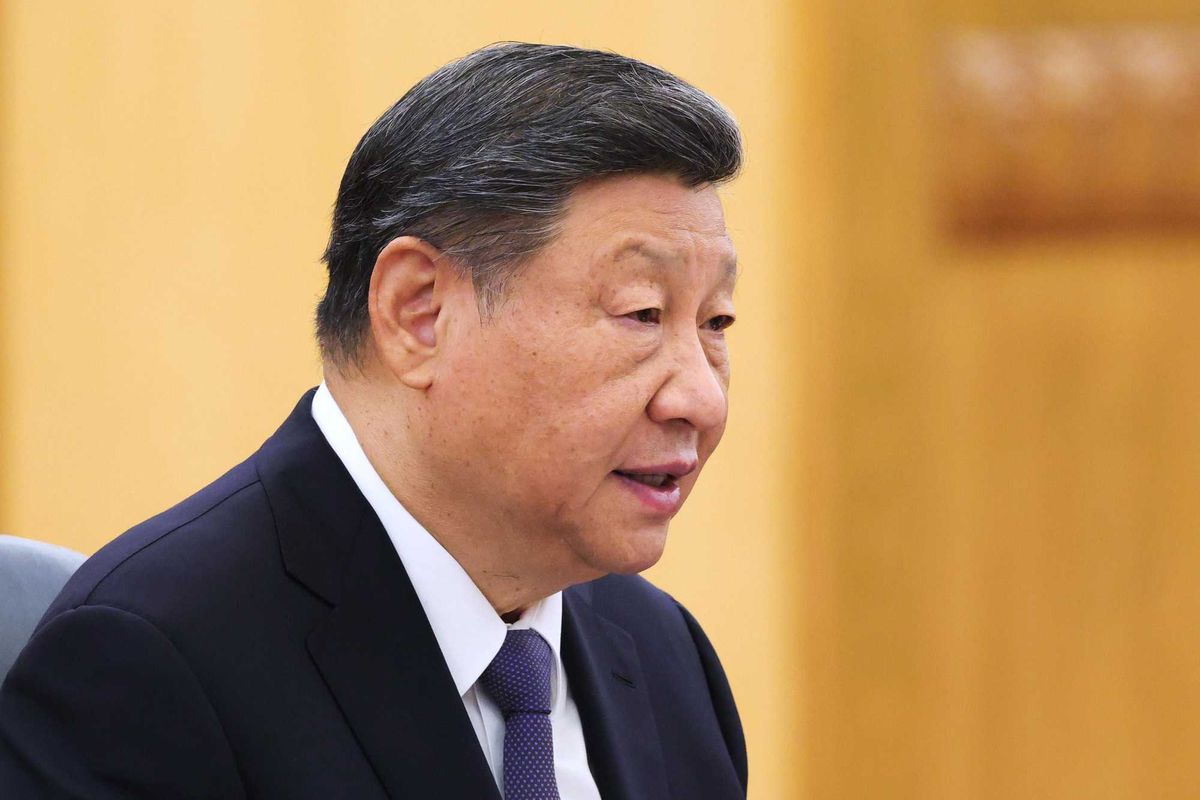Arrivano le prime certezze dalla Svizzera. «Tre delle vittime sono italiane. Le famiglie sono state avvertite»: ad annunciarlo, in tarda serata, è stato l’ambasciatore Gian Domenico Cornado. I dispersi sono, dunque, tre. Sempre ieri, infatti, in serata, è stata diffusa la notizia dell’identificazione ufficiale, da parte delle autorità elvetiche, del primo morto italiano nella strage di Crans-Montana: si tratta di Giovanni Tamburi , 16 anni di Bologna, che si aggiunge alla probabile morte del golfista genovese, Emanuele Galeppini, e quella di Chiara Costanzo, 15 anni. È il padre di quest’ultima a spegnere ogni speranza una volta saputo che i feriti non identificati sono tutti maschi.
Una giornata, quella di ieri, scandita dalla rabbia delle famiglie. Una risposta al dolore, la loro, spiegano gli psicologi che li assistono. «È una rabbia legata all’attesa e permette di non sentire il dolore e la tristezza. Una risposta fisiologica» che va compresa «senza controreagire», spiegano gli esperti. E chi li cura aggiunge: «Hanno bisogno di sapere e lo stato di attesa è peggiore di una certezza anche terribile».
Chiunque abbia figli ha provato a immaginare quel dolore, è impossibile, eppure la rabbia non monta solo tra i diretti coinvolti perché iniziano a farsi largo le domande che tutte puntualmente, restano senza risposte. Come è potuto succedere? Di chi sono le responsabilità? Possibile che non si riesca a capire chi è morto e chi è vivo? E nelle stesse ore un’altra penosa polemica ha preso piede nei dibattiti televisivi e sui social. Alcuni, senza che ancora si sia messo un punto all’emergenza e alle identificazioni, ha pensato di giudicare quei ragazzi che, presi dall’ingenuità, nei primi momenti dell’emergenza riprendevano le fiamme. Quasi fosse loro la colpa della loro disgrazia. Mancano le risposte ma manca anche il rispetto.
«L’operazione non è affatto conclusa fino a quando l’ultimo dei nostri ragazzi sarà tornato a casa», ha detto l’assessore al Welfare lombardo, Guido Bertolaso, che sta gestendo l’emergenza. «In questi giorni abbiamo fatto oltre venti voli verso la Svizzera per andare a prendere i ragazzi, 40 ore di volo in condizioni meteorologiche non ottimali e attraversando le Alpi. È un gioco di squadra italiano di cui siamo orgogliosi, e non ci fermiamo qui».
Non solo Milano, anche il Villa Scassi di Genova accoglierà una paziente ferita a Crans-Montana. Si tratterebbe di una persona adulta, non è certo se italiana o straniera. L’arrivo in elicottero è previsto intorno alle 15 di oggi, l’ospedale ha messo a disposizione ulteriori quattro posti letto. I pazienti trasferiti dalla Svizzera al Niguarda di Milano, intanto, sono diventati nove e sono tutti in «buone condizioni cliniche», come riferito nell’ultimo bollettino. Nella tarda mattinata di ieri è arrivata un’altra quindicenne, Sofia. Era ricoverata all’ospedale di Losanna «sicuramente la paziente in questo momento più grave», ha detto Bertolaso. Almeno fino a quando non c’è stato un altro arrivo precedentemente non previsto. Contrariamente a quanto comunicato al mattino, infatti, nel pomeriggio è arrivata nell’ospedale del capoluogo lombardo una nuova paziente. Ha 16 anni, era proveniente da Zurigo ed era stata definita in precedenza «non trasportabile». Si tratta di Francesca, anche lei milanese, considerata la paziente più grave e già operata due volte in Svizzera.
Francesca e Sofia frequentano il liceo Virgilio, con loro ci sono altri due ragazzi coinvolti nella tragedia del locale svizzero, tutti e quattro frequentavano la terza D del liceo di Milano che in questi giorni vive momenti di angoscia. Gli altri due, Leonardo, promessa del calcio e Kean, sono ricoverati in Svizzera e, per il momento, non possono essere trasportati. Erano tutti ospiti nella casa a Crans dei genitori di Francesca. Insieme a loro dovevano partire per la vacanza altri due studenti del Virgilio, due amici anche loro invitati dalla famiglia di Francesca, ma all’ultimo hanno rinunciato al viaggio, uno perché malato. Lo ha confermato all’Ansa il preside dell’istituto, Roberto Garrone: inizialmente, infatti, «dovevano partire in sei».
«Poi ci sono due ragazzi nostri, sembrano essere nostri perché non sono ancora stati identificati con certezza», ha detto Bertolaso in uno degli ultimi punti stampa, «sono i due casi più gravi e si trovano al centro grandi ustioni in Zurigo. Abbiamo la ragionevole speranza che si tratti di due ragazzi italiani ma dobbiamo ancora fare le prove del Dna. Hanno il volto completamente coperto da tutte le medicazioni perché, avendo avuto ustioni sul volto, il primo intervento che hanno fatto i sanitari elvetici è stato quello di curare la parte della faccia e, quindi, non possiamo sciogliere quelle che sono le medicazioni per andare a vedere se si tratta di uno piuttosto che di un altro. Ovviamente sono intubati, quindi non sono in grado di parlare e per cui bisogna attendere la possibilità di una identificazione certa».
Una tragedia per le famiglie, ma per un’intera comunità. Il 7 gennaio riaprirà il Virgilio, così come le altre scuole italiane, ma quegli studenti dovranno affrontare questo terribile trauma. Per questo è stato già predisposto l’arrivo di una squadra di psicologi ha spiegato il preside: «la sera dello stesso giorno probabilmente ci sarà un incontro di supporto dedicato ai docenti e ai genitori con degli specialisti». Storie di vite spezzate, tra chi è morto, chi è sopravvissuto e chi per affetto è vicino a queste vittime, nulla sarà più lo stesso.
Indagati i titolari del locale-trappola. Erano senza licenza per la discoteca
Sono indagati per «omicidio, lesioni personali e incendio a titolo colposo per negligenza» Jessica e Jacques Moretti, i titolari di Le Constellation, il locale nella via centrale di Crans-Montana che, la notte di Capodanno, si è trasformato in una trappola senza scampo per 40 giovani bruciati vivi e altri 121 gravemente feriti.
A dare, finalmente, la notizia - che a dire il vero per le logiche della giustizia italiana risultava scontata, se non addirittura in ritardo rispetto all’enormità della tragedia - è stata la Procura cantonale del Vallese che, due giorni fa, aveva annunciato con una conferenza stampa l’avvio di un inchiesta sulle cause del rogo, causato - ormai con pochi dubbi - dalle candele scintillanti accese sulle bottiglie di champagne e finite troppo vicine al soffitto, ricoperto con materiale fonoassorbente evidentemente non ignifugo. In ossequio alla prudenza svizzera, tuttavia, le stesse autorità, ci hanno tenuto a puntualizzare che «la presunzione di innocenza si applica fino alla pronuncia della condanna definitiva» e che, per il momento, a carico della coppia non sono previste misure cautelari in carcere, né ai domiciliari.
Mentre le ore trascorrono - lentissime per le tante famiglie colpite dalla tragedia - le domande senza risposta, su come e con quali logiche, quel locale, aperto ai più giovani, fosse realmente gestito dalla coppia di corsi, sono sempre più numerose e inquietanti. Le misure di sicurezza evidentemente non adeguate, una porta di uscita sul retro che alcuni soccorritori sostengono di aver trovato chiusa a chiave, l’abitudine consolidata di utilizzare giochi pirotecnici in un seminterrato e quella schiuma insonorizzante a tappezzare il soffitto che ha preso fuoco in un attimo e che lascia, legittimamente, aperti tutti i dubbi possibili sull’adeguatezza degli spazi alle norme antincendio.
Eppure, la chiave per capire come sia possibile che, nella precisa Svizzera, un locale così pericoloso fosse accessibile e frequentato, potrebbe nascondersi proprio nella destinazione d’uso degli spazi, ricavati nei sotterranei del palazzo di Rue Central 35 a Crans-Montana. Le Constellation, infatti, era stato autorizzato con la funzione di bar e non di discoteca e non sarebbe mai dovuto essere adibito a sala da ballo. E, forse, proprio qui, si nasconde l’inghippo.
A rendere nota l’incongruenza è l’agenzia di stampa Agi che è entrata in possesso della visura camerale del locale, nella quale è riportato chiaramente che la licenza riguarda attività di «ristorazione, vendita di bevande e commercio dei vini in generale», senza alcuna menzione ad attività di discoteca. Effettivamente, anche guardando semplicemente ai claim promozionali di Le Constellation, arriva la conferma: la scritta all’esterno del locale indica «longue bar» e «cocktail bar» e anche le recensioni su Tripadvisor, sospese dopo la tragedia, non nominano mai locali da ballo: «Pranzo, cena, aperto fino a tardi, bevande da asporto e al tavolo» sono i servizi promossi sul sito per turisti, e niente altro. Ed è chiaro che le norme di sicurezza per servire un cocktail ad avventori seduti a tavolino non sono le stesse che si applicano ad una serata scatenata in pista con centinaia di adolescenti.
Sotto accusa - soprattutto per chi conosceva la storia del locale - ci sono i lavori di ristrutturazione realizzati nel 2015, a quanto pare, direttamente da Jacques Moretti nel tempo record di 100 giorni, ovvero tre mesi, nei quali l’uomo - lavorando instancabilmente - aveva trasformato il seminterrato abbandonato in uno spazio con il permesso di ospitare fino a 300 persone. «Sono stati fatti tre controlli in dieci anni ed era sempre tutto a posto», ha dichiarato più volte lo stesso Moretti e mentre si spera che i risultati di quei controlli siano già al vaglio degli inquirenti elvetici, resta da capire per quale finalità d’uso degli spazi quei controlli erano stati predisposti.
Per esempio quella schiuma insonorizzante in materiale plastico nero, che rivestiva il soffitto - ben visibile in diverse immagini diffuse sui social e nei video drammatici delle prime fiamme - era stato validato come rivestimento per un tranquillo cocktail bar o era stato ritenuto idoneo anche a ricoprire le pareti di una discoteca? Molte ricostruzioni dell’accaduto riportate sui social dagli avventori abituali di Le Constellation sottolineano la vetustà dello stabile e alcune ipotizzano addirittura che durante la ristrutturazione, avvenuta nel 2015, il vano scale che collega i due piani - il terra e il seminterrato - sia stato ridotto per il posizionamento degli arredi.
Comunque sia, la piantina degli ambienti sembra evidenziare una carenza di uscite soprattutto in relazione al numero di persone ammesse, almeno secondo gli standard del nostro Paese. In Italia, infatti, è obbligatorio. per ottenere il via libera a qualsiasi inaugurazione di attività aperta al pubblico. presentare il «piano di sicurezza» formulato e sottoscritto da esperti che basano le autorizzazioni proprio sul rapporto tra il numero e l’ampiezza delle vie di fuga, la capienza delle persone e il tipo di attività previste.
«Non sono in grado di fare paragoni con l’Italia ma quello che posso dire è che in Italia esistono servizi di vigilanza interna, c’è del personale e non oso immaginare un locale notturno gestito in questo modo nel nostro Paese dove abbiamo procedure molto severe», ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, interpellato sulla questione.
Truffa e squillo nella vita di Jacques
Lui ex carcerato, finito dentro per sfruttamento della prostituzione, lei imprenditrice rampante, figlia - per beffa del destino - di un vigile del fuoco. Sembrano i protagonisti di un brutto film Jaques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del locale Le Constellation, nel centro di Crans-Monatana, all’interno del quale hanno perso la vita, arsi vivi, 40 giovanissimi che festeggiavano lì la notte di Capodanno e che non sono riusciti a fuggire dalle fiamme mentre Jessica Maric, presente, è uscita praticamente illesa dal rogo.
A rivelare il passato dell’uomo è il quotidiano Le Parisien che spiega come Moretti, soprannominato «il corso» e originario di Ghisonaccia, un piccolo paese dell’isola francese, oggi 49 anni, non sarebbe affatto uno sconosciuto per il sistema giudiziario francese. L’uomo, tra la metà degli anni Novanta e il 2005, sarebbe stato processato e poi condannato a un periodo di carcere, scontato nelle galere della Savoia, per reati non banali: truffa, sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona. Moretti, tuttavia, dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, era uscito dal giro tanto che la polizia francese - sempre secondo Le Parisien - lo ritiene un soggetto ormai «lontano dallo spettro della criminalità organizzata».
Pochi anni dopo, l’incontro con Jessica, allora giovane intraprendente con un curriculum di studi di tutto rispetto. Il profilo di Jessica Maric, oggi 40 anni, è quello di una donna benestante a cui la famiglia ha dato la possibilità di formarsi una solida base culturale. Originaria della Corsica, la donna ha vissuto in Costa Azzurra per molti anni e precisamente a Cannes dove il padre, Jean-Paul Maric, è stato vigile del fuoco nel comparto cittadino e lo zio, Jean-Pierre Maric, presidente del comitato municipale degli incendi forestali ad Auribeau-sur-Siagne.
Dopo gli studi superiori in un istituto di Antibes, Jessica ha frequentato l’Università di Glamorgan, nel Galles meridionale, per poi completare la sua formazione all’Università internazionale di Monaco e alla Montpelier Business School in Francia. Tutte esperienze che dovevano prepararla a un futuro nel commercio e nell’impresa. Oltre che sulla formazione di Jessica, tuttavia, la coppia ha, con ogni probabilità, potuto contare anche su solide basi economiche per arrivare a diventare proprietaria di ben tre locali di livello medio alto, in una delle località sciistiche più rinomate dell’arco alpino. L’idea di investire a Crans Montana sarebbe arrivata proprio dopo una vacanza sulla neve e - detto fatto - da quel momento i due avrebbero intrapreso attività a tal punto efficaci da renderli titolari e gestori in pochi anni, oltre che di Le Constellation, aperto nel 2015, anche del bar ristorante Le Senso e del locale Le vieux Chalet, nel Comune di Lens, specializzato nel servire piatti tipici della Corsica.
La coppia che, a quanto risulta, ha un figlio, la residenza in Corsica e una proprietà immobiliare in Costa Azzurra, a Crans-Montana è molto conosciuta ma non sempre di buona fama. Mentre alcuni ricordano la «cattiva reputazione» di Jaques, altri lo definiscono «un gran lavoratore». Su di lui Le Parisien riporta, tra gli altri, un racconto inquietante. Un anziano del posto, che sostiene di conoscere da tempo Moretti, intervistato dal quotidiano francese ha riferito che l’uomo, in una occasione, gli avrebbe chiesto «di portare dei contanti in Corsica nelle sue valigie quando stava programmando una vacanza lì» e che la stessa proposta sarebbe stata avanzata da parte di Moretti anche ad altri del posto.