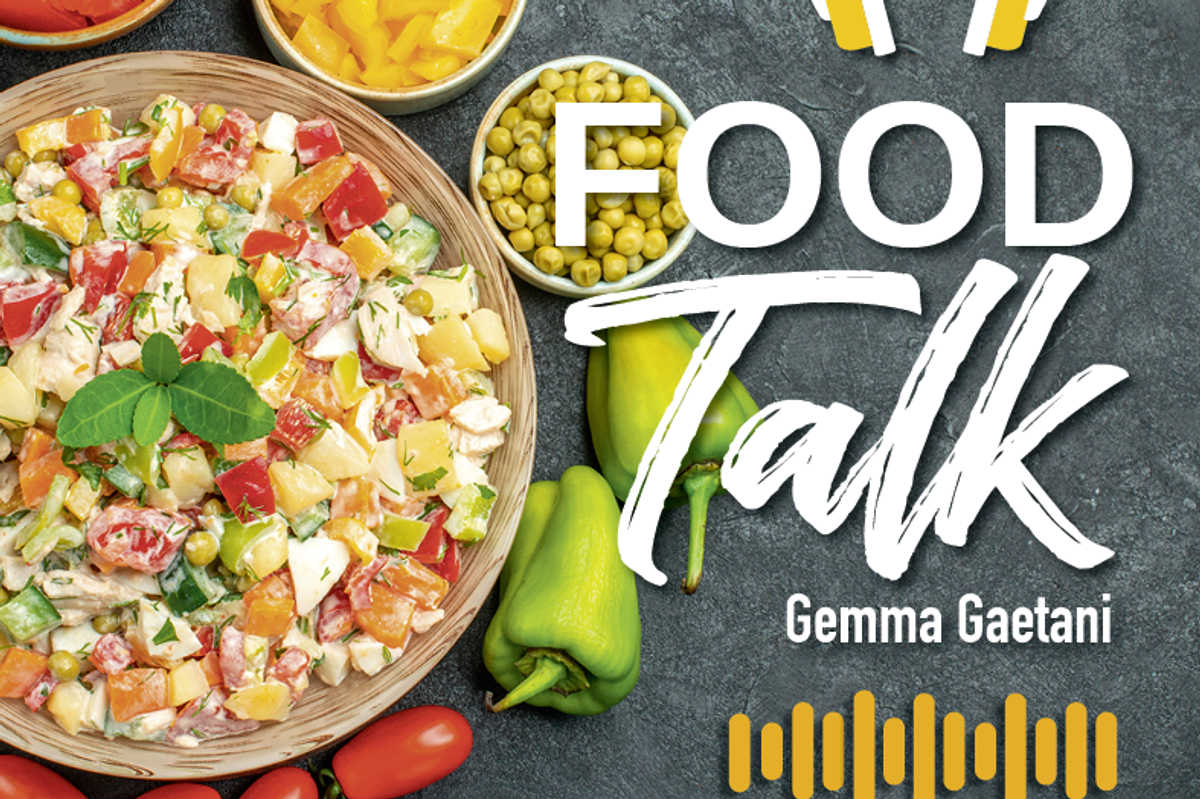2025-01-16
Bentornati insegnanti. Con latino, storia e geografia la scuola riscopre l’eterno
Giuseppe Valditara (Ansa)
La riforma annunciata da Valditara ripudia l’appiattimento sulla tecnologia e rimette al centro la tradizione umanistica e la cultura italiana. Finalmente un buon segnale.Torna la storia, torna la geografia, torna l’Italia, torna il latino nelle scuole italiane. Insomma torna un’idea di civiltà, di cultura e di educazione umanistica nella scuola italiana; non solo istruzione, formazione, tecnologia e attualità. È questo il succo dell’annuncio del ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Valditara, e non possiamo che essere d’accordo con le intenzioni del ministro e dei suoi esperti. E speriamo che i fatti siano all’altezza delle intenzioni. La storia, è verissimo, è necessaria per formare cittadini «consapevoli e responsabili» e la rimozione della memoria storica nel nostro Paese (con la sola eccezione di fascismo, razzismo e antifascismo, come se il mondo fosse nato con la Seconda guerra mondiale) è una perdita incommensurabile per ogni Paese. Ma ancor più per il nostro Paese che sulla grande tradizione civile, umanistica, linguistica e storica ha fondato la sua ricchezza e il suo primato mondiale. Giusto anche il criterio della prossimità territoriale: è giusto che la storia e la cultura italiana vengano prima di quelle internazionali, ed è giusto che la storia europea e occidentale abbia la precedenza sulla storia del mondo e del terzo mondo, verso cui propende una certa ideologia dell’inclusione, dell’accoglienza e dell’amore per il lontano, con l’ignoranza e l’indifferenza per tutto ciò che è a noi più vicino. È un criterio che vale per la storia come per la geografia, per il pensiero come per l’arte e la musica, giustamente potenziata nelle intenzioni della riforma, per un Paese così versato nel canto e nell’opera. Il tema di fondo da affrontare è il ruolo della scuola nella società presente: la scuola non deve andare a rimorchio di quel che fa tendenza oggi; la sua missione e la sua ricchezza è quella di dare ai ragazzi una visione generale, una chiave di lettura, un sapere critico che consenta poi di governare e cavalcare i flussi della nostra vita moderna. Non un sapere contro la società, ma un sapere come contrappeso che bilanci una società interamente schiacciata sulla tecnica, sul web, sull’economia e sulla finanza. La scuola, arrivai a dire in passato, deve seguire la lezione di Dante, che elogiava il suo maestro Brunetto Latini perché «voi m’insegnavate come l’uom s’etterna». Ovvero la scuola, soprattutto i licei, deve fornire al ragazzo le chiavi per abitare altri mondi oltre il presente: il passato, il futuro, la cultura, il senso dell’eterno, ovvero ciò che non passa, è permanente. Deve insegnare cioè a una società interamente presa dalla connessione on line, anche la connessione verticale, con le epoche e le generazioni passate e con quelle che verranno. In una parola, la scuola deve riprendere il senso dell’eredità, il rispetto e la lezione dei maestri, degli autori e delle autorità, il dialogo con le altre epoche, premesse indispensabili anche a dialogare con le altre società e con gli altri mondi presenti. Lo dico anche da autore di un libro, Senza eredi, che è incentrato proprio sulla denuncia di un’epoca che cancella eredità, maestri e memoria storica. A partire dai classici e dallo studio del latino, che si riaffaccia seppure in chiave facoltativa - come era ai miei tempi - anche nella scuola media dell’obbligo. Riconciliamoci con la nostra lingua madre e con la civiltà da cui proveniamo. Verrà incoraggiata, apprendo, anche la lettura della Bibbia, le poesie a memoria, i testi epici della letteratura classica. E di questo dobbiamo esser grati anche ai tanti esperti che hanno sostenuto queste tesi e al ministro che non ha avuto il timore di sostenerle. Non abbiamo risparmiato critiche e perplessità in passato a Valditara, non amiamo i cedimenti, le compiacenze e le piacionerie di chi crede di salvarsi assecondando la demagogia e l’egemonia ancora imperante; ma quando una cosa ci sembra giusta, coraggiosa e pertinente, anzi necessaria, e quando ci pare che giovi alla scuola, agli studenti e anche ai docenti, ripristinando il ruolo, la missione e la dignità della scuola, mi pare che vada sostenuta senza indugi. Poi, certo, quando dovrà calarsi nella realtà vedremo come si riuscirà a farlo, con quale personale, con quali reazioni, con tutti i dubbi che abbiamo su larga parte dei docenti, e nel clima d’epoca con la pressione ideologica e mediatica che scatterà per annacquare, boicottare o avvelenare i propositi. Intanto, siamo soddisfatti per gli annunci, per le intenzioni e per la visione che li ispira. Un tempo gli studenti contestavano la scuola voluta dai governi del centrodestra perché ritenevano che fosse succuba di un’idea «berlusconiana» di succursale dell’impresa, subalterna al commercio e al mercato; ricordate le polemiche contro le fatidiche tre i, impresa, internet e inglese. Anch’io ho più volte detto che i ragazzi lo spirito d’impresa, la capacità di usare il computer e di imparare l’inglese li apprendono più dalla vita, dall’esperienza reale di ogni giorno, insomma imparano più sul campo che nella grottesca, tardiva e impacciata caricatura scolastica, ad opera peraltro di un personale non attrezzato per quei tre compiti. La scuola non deve inseguire il mondo, l’attualità, le utilità più effimere, soprattutto in una società fondata sul commercio, i consumi, le performance tecnologiche; refrattaria al sapere umanistico, che reputa inutile e obsoleto. Ma, vedrete, ora contesteranno a Valditara l’esatto contrario di quel che contestavano ai governi Berlusconi e al ministro Letizia Moratti: di riportare la scuola al passato, a un versione reazionaria, nazionalista, anzi suprematista, tardo-umanistica, provinciale e italocentrica. L’ignoranza avanza, la barbarie corrode ogni giorno pezzi di società, di scuola e di vita, l’incuria prevale e si fa menefreghismo più accidia. I prof diventano istruttori e intrattenitori, a volte le classi sono affollate d’insegnanti di sostegno, come in un suk di avventori, balie e animatori. Cercare di risalire la corrente, avere il coraggio di invertire la discesa, perlomeno provarci, è finalmente un buon segno di vita e di intelligenza. Bentornati maestri, docenti, anzi insegnanti, cioè persone che lasciano un segno.
Intervista con Barbara Agosti, chef di Eggs, la regina delle uova che prepara in ogni modo con immensa creatività
Francesco Saverio Garofani (Imagoeconomica)
Annalisa Cuzzocrea (Ansa)
Elon Musk e Francesco Saverio Garofani (in foto piccola) Ansa