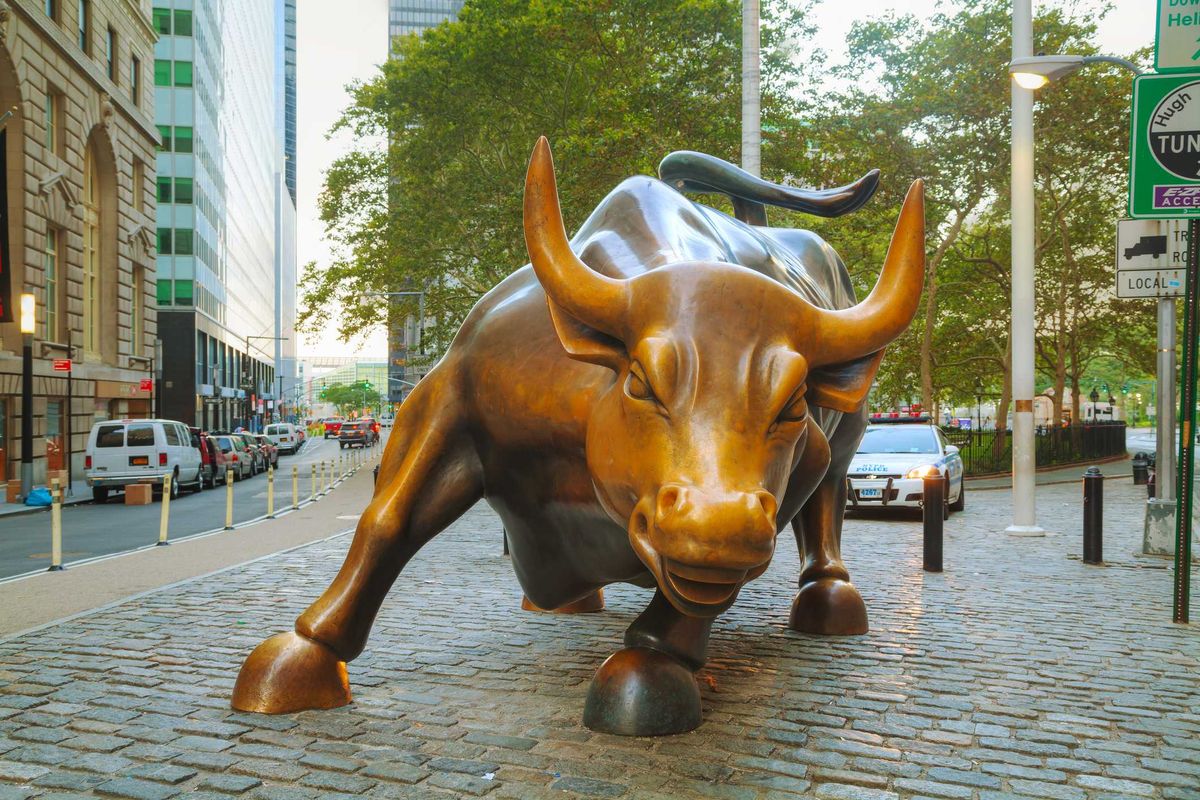2025-06-12
«Viva i referendum», tanto comanda la Corte
Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale (Imagoeconomica)
L’attuale presidente della Consulta difende l’istituto, «espressione diretta della volontà popolare». Quello emerito chiede persino di moltiplicarlo. Le facoltà del Parlamento, invece, sono un «limite» per le toghe. Che gli dettano l’agenda o legiferano al suo posto.Che strana, la democrazia secondo i giudici. All’indomani del fiasco del referendum, il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, difende quell’istituto, che «non è mai un “fallimento”», «quale che sia il suo esito», poiché rimane uno strumento di «espressione diretta della volontà popolare». Pensiero nobile. Certo, la Repubblica italiana poi funziona principalmente secondo i canoni della democrazia rappresentativa: il popolo elegge un Parlamento, il Parlamento legifera. Peccato che, quando si tocca questo tasto, il capo della Consulta sembri cambiare parere: «La discrezionalità del legislatore», osserva sul Corriere della Sera, «costituisce tuttora un limite per la Corte». Non è chiaro se dovremmo rammaricarcene. Fatto sta che le toghe, questo limite, sanno bene come aggirarlo. Ormai, è passata di moda l’idea che quell’organismo di garanzia serva a valutare la conformità delle norme licenziate dalle Camere con la Carta fondamentale del Paese. La tesi dominante - non solo in Italia - è quella sintetizzata giorni fa dal presidente emerito della Corte, Augusto Barbera: la «lettura» della Costituzione «può essere adeguata». I giudici - scrisse un’altra numero uno del collegio, Marta Cartabia - devono «dinamizzare» l’ordinamento. Nella classica dicotomia tra la lettera e lo spirito, è lo spirito della Costituzione ciò che conta di più. E ovviamente, i suoi interpreti sono dei funzionari - per quanto saggi, per quanto dotti, per quanto benintenzionati - che non rispondono agli elettori.La Consulta redige sentenze politicizzate? Amoroso respinge l’accusa. La Corte, di solito, interviene «solo dopo aver invitato il Parlamento a legiferare» sulle materie che le vengono sottoposte. E in genere - ma su questo dettaglio il giurista sorvola - stabilendo già un perimetro e dei contenuti ai quali le Camere dovrebbero attenersi. Eppure, persino l’ex magistrato di Cassazione si rende conto che su alcune questioni, «che hanno una forte portata etica e che sono molto divisive», «non è facile legiferare»; anzi, «è necessaria grande cautela». Giusto. Delle due l’una, però. O il Parlamento dev’essere destinatario degli ultimatum della Consulta e, se non li rispetta, merita che siano le toghe a sostituirsi a esso; oppure si riconosce che - su suicidio assistito, adozioni gay, fecondazione assistita, più che su una legge elettorale - la complessità dei valori in ballo giustifica la lentezza di azione, la difficoltà di un compromesso, persino la scelta di non introdurre alcuna regola generale. Ma se è così, i diktat della Corte sono fuori luogo.Di sicuro, sarebbe fuori luogo pensare a un sistema in cui l’autentica sovranità, cioè la capacità di risolvere le anomie, gli stati d’eccezione, spetti a una casta di tecnici del diritto, i quali si arrogano la prerogativa di sopperire alle mancanze del legislatore, o peggio di sostituirlo, addomesticarlo, dirigerlo. E in cui alla «democrazia limitata», come l’ha efficacemente definita sulla Verità il professor Luca Ricolfi, faccia da controcanto il ricorso alla democrazia diretta. Uno stratagemma un po’ peloso: il referendum è una brillante invenzione in quanto mobilita l’opinione pubblica progressista? Verrebbe elogiato pure se l’appello al popolo diventasse la trincea dei vituperati leader nazionalisti?Barbera, intervistato dalla Stampa, evoca addirittura l’ipotesi di moltiplicarli, i referendum: preventivi, consultivi, promossi dal Parlamento… E spiega che, se i costituenti scelsero solo quelli abrogativi, fu in nome di un «complessivo spirito antimaggioritario». In sostanza, ciascuno degli schieramenti temeva che «la vittoria elettorale» degli avversari «avrebbe potuto svuotare principi e valori» della Carta. «Ne è derivata una continua ricerca di reciproche e ossessive garanzie, tra cui una forma di governo necessariamente “debole”». La diagnosi corretta dal medico da cui meno te l’aspetti: proprio nella Consulta, che l’ex deputato del Pci e del Pds ha guidato, molti intravedono un contropotere che sarebbe tanto più necessario nell’era dei sovranismi, i quali minaccerebbero i diritti delle minoranze fragili, dai migranti agli omosessuali. All’improvviso, le «garanzie reciproche» sono diventate figlie di un’«ossessione» vetusta?Anche qui, delle due l’una: si deve avere tanta fiducia nella democrazia da invocare più referendum, magari con quorum più bassi, senza paura di derive plebiscitarie? Oppure «l’impronta della diffidenza», di cui si scorge traccia nella Costituzione, non è affatto «anacronistica» come ritiene Barbera? E, quindi, bisogna rafforzare organismi, quali la stessa Corte, che per uno dei suoi presidenti, Giuliano Amato, sarebbe «il contraltare della maggioranza», guarda caso quando la maggioranza è di destra?Tertium non datur. A meno che, dietro le altissime argomentazioni dei giudici, non si celi una convinzione ben più pragmatica: che si possono indire tutti i referendum del mondo, tanto, alla fine, comanderanno sempre loro.
Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali.