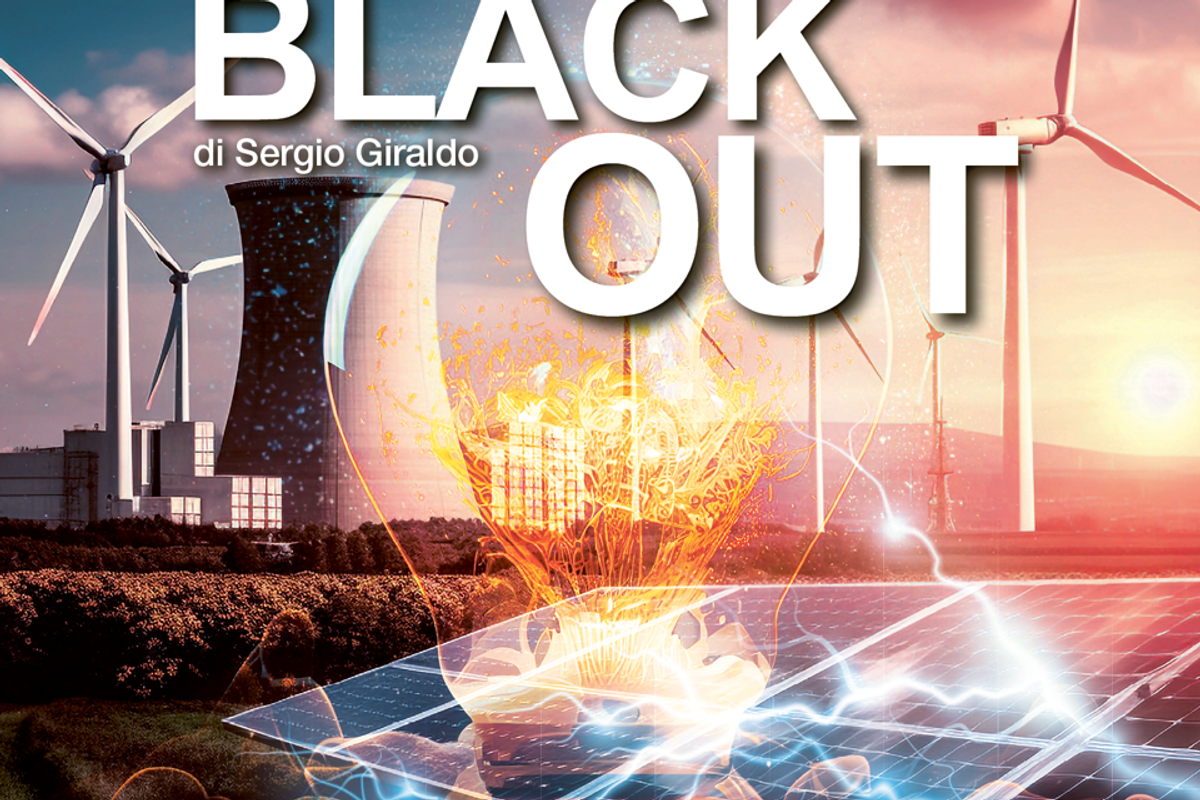2024-09-16
«Quegli italiani impavidi del Far West»
Lo scrittore, autore di un saggio sul ruolo dei nostri connazionali nell’epopea della «frontiera» Eraldo Baldini: «Furono fondamentali, specie i romagnoli. Partirono pure 150 preti. Oggi quello spirito sopravvive nonostante il woke».Eraldo Baldini è uno fra i più appartati scrittori italiani. I suoi interventi pubblici sono rari quanto sono rari - nel senso di originali e preziosi - i suoi romanzi. Scrive bene di tutto: le sue opere che si inseriscono nel filone del gotico rurale gli valgono il titolo di Stephen King italiano, a tratti più smagliante dell’originale. Quando s’avventura fuori dai generi, come nel caso dell’ultimo libro Le lunghe ombre fredde (Rizzoli), i risultati sono altrettanto coinvolgenti. C’è però anche un altro Baldini, oltre a quello dei romanzi: è il Baldini valente antropologo, autore di una montagna di testi sul folklore e le tradizioni, in particolare quelle della sua terra di Romagna (è nato a Russi, provincia di Ravenna). L’ultimo nato è Transatlantica (Romagna&America), edito da Ponte Vecchio e firmato assieme a Alberto Pagani, uno scrigno pieno di incredibili storie così vere da sembrare inventate di italiani finiti Oltreoceano a cercare l’avventura. Che ruolo hanno avuto gli italiani, e i romagnoli in particolare, nella creazione del mito della frontiera americana?«Gli italiani, come è noto, soprattutto con le grandi ondate migratorie dei fine Ottocento e primi del Novecento, sono affluiti in gran numero in America per motivi principalmente economici e la ricerca di migliori condizioni di vita. Ma ancor prima, a partire dal Seicento e con un forte incremento dai primi dell’Ottocento, troviamo una diversa “migrazione”. Di carattere molto diverso, questa, principalmente individuale, motivata non tanto dal bisogno quanto dall’intraprendenza, dallo spirito d’avventura e di scoperta, da istanze ideologiche e intellettuali, dalla ricerca di nuovi spazi non solo fisici».Furono molti questi singoli avventurieri?«Sarebbe lungo l’elenco degli italiani che hanno partecipato all’epopea della “frontiera” e ai suoi antefatti; ne cito alcuni, partendo dal bergamasco Giacomo Costantini Beltrami, nato nel 1779, che esplorò il Mississippi e altri territori e fu guerriero “ad honorem” delle tribù dei nativi Sioux e Chippewa: fu probabilmente lui ad ispirare la figura del protagonista del film Un uomo chiamato cavallo del 1970. Poi i fratelli De Tonti; Enrico nella seconda metà del Seicento fu anch’egli esploratore di ampi territori americani, dall’odierna Chicago al Golfo del Messico, divenendo padre fondatore di Stati quali Illinois, Arkansas, Alabama. Suo fratello Alfonso fu alla scoperta di altre aree degli States ed è annoverato tra i fondatori di Detroit. Venendo a personaggi e vicende forse più celebri, ricordiamo Charles Angelo Siringo, di origini siciliane, uno dei primi scrittori della frontiera, che tra l’altro diede la caccia a Billy the Kid, il giovane bandito che come unica amica aveva… una suora italiana, Rosa Maria Segale. Come dimenticare poi Giovanni Martini, il trombettiere di cavalleria che fu tra i pochissimi superstiti del massacro di Little Big Horn in cui le truppe di Custer, nel 1876, furono sconfitte dai nativi? Insomma, un elenco fitto, che comprende anche i romagnoli». Ci furono anche incredibili figure di sacerdoti fra questi italiani d’America. Ce ne racconta qualcuna?«Dal nostro Paese, militando principalmente tra le fila dei gesuiti, furono almeno 150 i religiosi che operarono nei luoghi più caldi del West. Cito i romani Gregorio Mengarini e Giuseppe Nobili, il pugliese Giuseppe Accolti, il laziale Giuseppe Rosati, il ferrarese Antonio Ravalli. Diversi furono anche i romagnoli, che si formarono nel seminario di Bertinoro (vicino a Forlì) e poi raggiunsero gli angoli più lontani e impervi del “Nuovo Mondo”. Partiamo da Pasquale Tosi, di Santarcangelo di Romagna, che arrivò negli Usa nel 1858 e svolse la propria missione soprattutto in Montana. Parlava le lingue di Piedi Neri, dei Nasi Forati e di altre tribù di nativi del Nord-Ovest. Nel 1886 si spostò da vero pioniere nella selvaggia Alaska, dove imparò le lingue dei Nulato e dei Malamute, per le quali scrisse dizionari; divenne anche cartografo ed esploratore». E poi?«Poi vanno ricordati i fratelli forlivesi Giuseppe e Pietro Bandini e il loro nipote Tito. Giuseppe giunse in America nel 1867; fu prima in California, Oregon, Idaho e infine in Montana. Venne definito “il sacerdote cow-boy” per la facilità con cui si adeguò ai difficili stili di vita del West. Anch’egli fu un eccellente linguista e redasse testi e dizionari sugli idiomi dei nativi. Gli capitò tra l’altro di trovare un orso addormentato dentro il confessionale della sua chiesa; non si spaventò, essendo pure un cacciatore avvezzo all’incontro con la ricca fauna del luogo. Suo fratello Pietro Bandini operò anch’egli, dal 1882, nelle missioni delle Montagne Rocciose, fra i Crow e i Cheyenne; poi fu a New York, e infine realizzò una vera e propria enclave tutta italiana in Arkansas, creando una cittadina a cui diede il nome di Tontitown, in onore di Enrico De Tonti che aveva fondato il primo insediamento di bianchi in quello Stato». Questo mito della frontiera ha un lato oscuro: lo sterminio dei nativi americani. E ancora la volontà di dominio che ha caratterizzato gli Usa nel corso della storia. Ma ha anche un lato luminoso: il coraggio, la sfida, l’incontro/ scontro con la natura. Che cosa abbiamo mantenuto oggi di questo mito, secondo lei?«Certo, sappiamo quanto l’epopea della “frontiera” abbia rappresentato un dramma per i nativi, spinti sempre più ai margini dei territori che erano stati loro, fino a una enorme cancellazione della loro presenza e della loro cultura: una pagina dolorosissima della storia che solo nel tempo è emersa in tutta la sua crudezza. E conosciamo quanto, in seguito, la potenza della nuova coalizione di Stati che si formò nel territorio americano sia stata espressa nei modi che da sempre e ovunque hanno caratterizzato l’operare politico, economico e militare delle grandi potenze, nessuna esclusa. Un operare che nel caso degli Usa non può essere declinato solo in modo negativo, comunque, perché il dipanarsi della storia è un groviglio di istanze, azioni e motivazioni che sarebbe profondamente errato guardare in modo manicheo. Riguardo al “lato luminoso” del movimento della frontiera, virtù quali il coraggio, l’intraprendenza, lo spirito di scoperta, l’approccio a nuovi incredibili spazi e scenari naturali, densi di fascino come di insidie, hanno rappresentato uno dei pilastri della mentalità, della cultura e degli stilemi del way of life americano. E rappresentavano ciò anche nel loro evolversi: restando ai romagnoli, di cui tratto nel libro di cui sono curatore e coautore, voglio tra l’altro ricordare che nella prima metà dell’Ottocento gli Usa furono non solo il luogo a cui approdarono esploratori e avventurieri, ma anche quello in cui si spostarono diversi perseguitati del nostro Risorgimento, ad esempio Pietro Maroncelli e Felice Foresti, che dopo avere scontato una pena nel carcere dello Spielberg ripararono insieme ad altri a New York, dove poterono continuare ad adoperarsi per l’indipendenza e l’unità del nostro Paese attraverso un continuo rapporto con i libertari nostrani. Né va dimenticato che, in un contesto conoscitivo e relazionale molto maggiore di quanto crediamo, non mancarono romagnoli (come il ravennate Giovanni Gordini) che raggiunsero gli Usa per partecipare alla Guerra Civile (1861-1865) tra le file degli Unionisti - o Nordisti che dir si voglia -, spinti da motivazioni ideali». Una cosa mi colpisce: l’eroismo che ha caratterizzato la letteratura della frontiera e i primi grandi autori americani come Whitman, Thoreau eccetera sembra quasi completamente scomparso dalla cultura statunitense, che oggi produce il politicamente corretto e la cultura woke. «Non credo si possa parlare davvero di una tale scomparsa: molto resta stratificato non solo nella storia e nella memoria, ma anche, in modo solido e multiforme, nella cultura e nella mentalità. Neppure la letteratura della frontiera appartiene solo al passato: si possono citare in proposito, ad esempio, la Trilogia della frontiera di Cormac McCarthy, i romanzi di Elmore Leonard, di Larry McMurtry, di Michael Punke, eccetera, così come nascono nuovi e notevoli film di genere western, oggi fortunatamente privi della superficialità e dell’enfasi distorta che il filone presentava intorno alla metà del Novecento; e va sottolineato che generi musicali come il country hanno ancora un grande spazio negli Usa. Inoltre, lo “spirito della frontiera” si è allargato e spostato in altri contesti, come la conquista dello spazio o altro ancora». Il wokismo tuttavia è una realtà piuttosto ingombrante...«Riguardo alla cultura woke, occorre tenere conto che gli Usa di oggi sono un grande - e complicato - crogiolo di etnie, lingue, religioni, culture, e una “regola del rispetto” era indispensabile. Poi la cosa è in qualche modo sfuggita di mano, per approdare a iperboliche e cervellotiche esagerazioni che, se continuano a manifestarsi, vedono nel contempo alzarsi diverse voci che mettono in guardia dagli eccessi del politicamente corretto e della cancel culture, fenomeni che possono limitare lo spazio del libero confronto. Lo stesso New York Times non ha mancato di sottolineare come il dibattito pubblico rischi di impoverirsi proprio per la paura di molti di “dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato”. E la reazione a tale rischio è ben rappresentata in diversi modi nella cultura statunitense contemporanea: pensiamo all’occhio critico - e solo in apparenza “futile” - di un cartoon come South Park…».
La gentrificazione - cioè l’esproprio degli spazi identitari, relazionali e storici - quelli che Marc Augé ci consegna come i luoghi in opposizione ai non luoghi ha fatto sì che i ristoranti assumano sempre di più desolatamente le sembianze dello spaccio di calorie non obbedendo più a quella cucina urbana che è stata grandissima anche nelle case borghesi dall’Artusi in avanti.