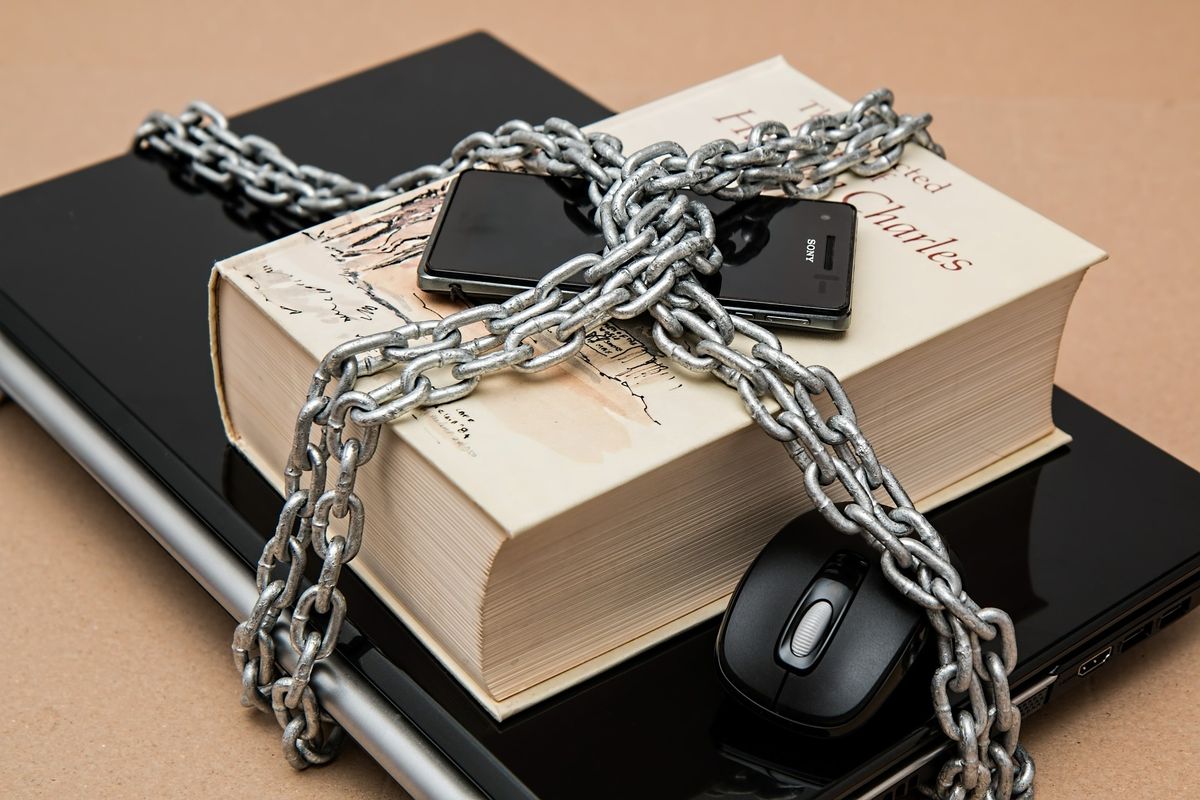
Per stare tranquilli, possiamo pure raccontarci (come recita la prima di ben 54 pagine di malloppo) che è solo il «rapporto tecnico di un tavolo tecnico». Tecnica al quadrato. Ma c'è ben poco di tecnico quando è in gioco il bene più sacro di tutti: la libertà d'espressione. Una robina a cui la Costituzione dedica l'articolo 21: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
Ecco, gli altri «mezzi di diffusione». È arrivata Internet, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la stessa che spesso - a parere di molti - dorme o riposa davanti a macroscopiche faziosità dell'informazione radiotelevisiva, ha pensato bene di occuparsi della «garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali». Insomma, vogliono che clicchiamo sicuri. E così alcuni scienziati hanno redatto un rapporto dal titolo: La strategia della disinformazione online e la filiera dei contenuti fake.
Molta fuffa già letta e già sentita, una riproposizione burocratica di una saggistica ormai vasta sulle fake news, sulla post verità (post truth) in rete, molta lagna tipica di certo progressismo. Hanno perso su Brexit, contro Trump, in Brasile, e ovviamente in Europa a causa dei «cattivi populisti»? Sono stati stracciati nonostante controllassero giornali, radio e tv? Elementare, Watson: allora è colpa della rete, dove quei birbaccioni degli elettori trovano informazioni alternative. Nasce così la tentazione inconfessabile di passare al setaccio l'informazione online, e di distribuire patenti e pagelle. Andate a pagina 10 del rapporto e, con tanto di tabellina, troverete i tre gironi dell'inferno secondo i «tecnici» (dicono loro: sono categorie «note e accreditate da anni nella letteratura scientifica internazionale»). Il girone più maledetto di tutti è quello della «disinformazione online»: si tratta delle situazioni in cui la notizia è falsa. Ma agli scienziati non basta la falsità del contenuto. A riprova della perversione del nemico, individuano altri due peccati: la «contagiosità» (cioè la facilità di circolazione in rete) e il «dolo» (cioè il falso è stato costruito volontariamente). E comunque su questo punto nulla da eccepire: una notizia falsa è indifendibile. Punto e basta.
Il girone più leggero è quello della «misinformazione online» (che in romanesco si potrebbe tradurre «so' ragazzi»). Insomma, scrivono i tecnici, anche qui i contenuti sono «non veritieri» o «riportati in modo non accurato», magari perfino «suscettibili di essere recepiti come reali», ma «non creati con un intento doloso». E quindi, calcisticamente parlando, basta che l'arbitro redarguisca a voce l'autore del fallo, senza cartellini né gialli né rossi.
Ma occhio alla categoria intermedia, la «malainformazione online». Tenetevi forte, perché si sale sulla giostra. Si tratta di una «categoria di contenuti informativi fondati su fatti reali (avete letto bene: fatti reali), anche a carattere privato, divulgati su Internet e contestualizzati in modo da poter essere anche virali e veicolare un messaggio con il preciso intento di danneggiare una persona, un'organizzazione o un Paese, o affermare/screditare una tesi».
Vi siete spaventati? Ne avete tutte le ragioni. Secondo questi scienziati, non andrebbe bene nemmeno dire cose vere, se l'intenzione è quella di affermare o screditare una tesi (ma tutti scrivono per sostenere un'opinione o per attaccarne un'altra: è la libertà di parola!) o per danneggiare qualcuno (pure un Paese!). Ipotizziamo: se dico una cosa vera su Renzi, ma qualcuno pensa che io voglia danneggiarlo, devo forse essere sanzionato? Se dico una cosa vera sulla Germania, ma qualcuno immagina che sia dannosa per Berlino, non la posso più scrivere?
Era inevitabile che, venuto fuori il documento, si scatenasse un pandemonio online. Ad accendere (giustamente) il fuoco è stato Benedetto Ponti, docente all'Università di Perugia di Diritto amministrativo. Ha provato a replicargli, con dubbia efficacia, uno dei commissari Agcom, Antonio Nicita: «Il suo equivoco (questo l'esordio non felicissimo del tweet di Nicita) nasce dal fatto che lei confonde la pacifica libera espressione o opinione rispetto al contenuto della definizione, che evidenzia il preciso intento di rendere virale e screditare con manipolazioni o rivelazioni fuori contesto. Su questo si può precisare». E con ciò Nicita ammette che qualcosa non funziona, e preannuncia future consultazioni per «evitare equivoci indesiderati» visto che «i lavori sono appena iniziati». Ma la frittata è fatta, e Ponti è implacabile: «Sarebbe il caso di rimediare, non di cercare giustificazioni».
Ferocemente sarcastico anche il sottosegretario Luciano Barra Caracciolo, che si è chiesto: «L'articolo 21 della Costituzione è stato abrogato in via amministrativa?». E in effetti il tema è proprio che l'Agcom sembra essersi allargata: a notarlo è un fulminante tweet di Alberto Bagnai, presidente della Commissione Finanze del Senato: «Cose che capitano quando non sei previsto dalla Costituzione». Insomma, presa in castagna, l'Agcom arretra, smussa, abbraccia i contestatori. Ma sarebbe troppo comodo derubricare tutto a un caso, a un incidente, a un documento da emendare. È fin troppo chiara (non solo in Italia) la tentazione statalista e autoritaria, di censura morbida ma implacabile, che il politically correct porta con sé. I commissari Agcom possono twittare quanto vogliono per cercare di rassicurare. Ma è roba da dittature, da vecchia Germania Est, far prevalere l'analisi della «intenzione» dello scrivente sulla veridicità della cosa scritta. E chi stabilisce quali siano le mie intenzioni? Uno psichiatra? Una commissione parlamentare? Il ministro pro tempore? Un tavolo tecnico? Un sinedrio di editorialisti «perbene»?
I precedenti da «psicopolizia», da polizia del pensiero, non mancano. Già Facebook (e il fondatore Mark Zuckerberg fu giustamente massacrato dai repubblicani nella sua audizione davanti al Parlamento Usa) ha una politica molto discutibile tra «blocchi», storie conservatrici e di destra «tenute basse», e un sospetto di politicizzazione nell'esame dei post. Per non parlare della criticatissima «task force» europea contro le fake news, messa in piedi dalla Commissione Ue. Insomma, quello dell'Agcom di ieri è solo l'ultimo tentativo di una lunga e inquietante serie.
Contro questa follia, occorre una rivendicazione di libertà. Non tocca allo Stato (o al superstato Ue) stabilire ciò che è vero. Per carità: se qualcuno si ritiene diffamato, è giusto che usi gli strumenti legali a sua tutela. Ma da qui a dare una definizione di ciò che «si può» e «non si può» dire, addirittura con tanto di processo alle intenzioni, ce ne corre. È solo il lettore a dover essere sovrano: andando o no in edicola, premendo o no i tasti del telecomando, cliccando o non cliccando. Fuori i burocrati dal tempio della libertà.





