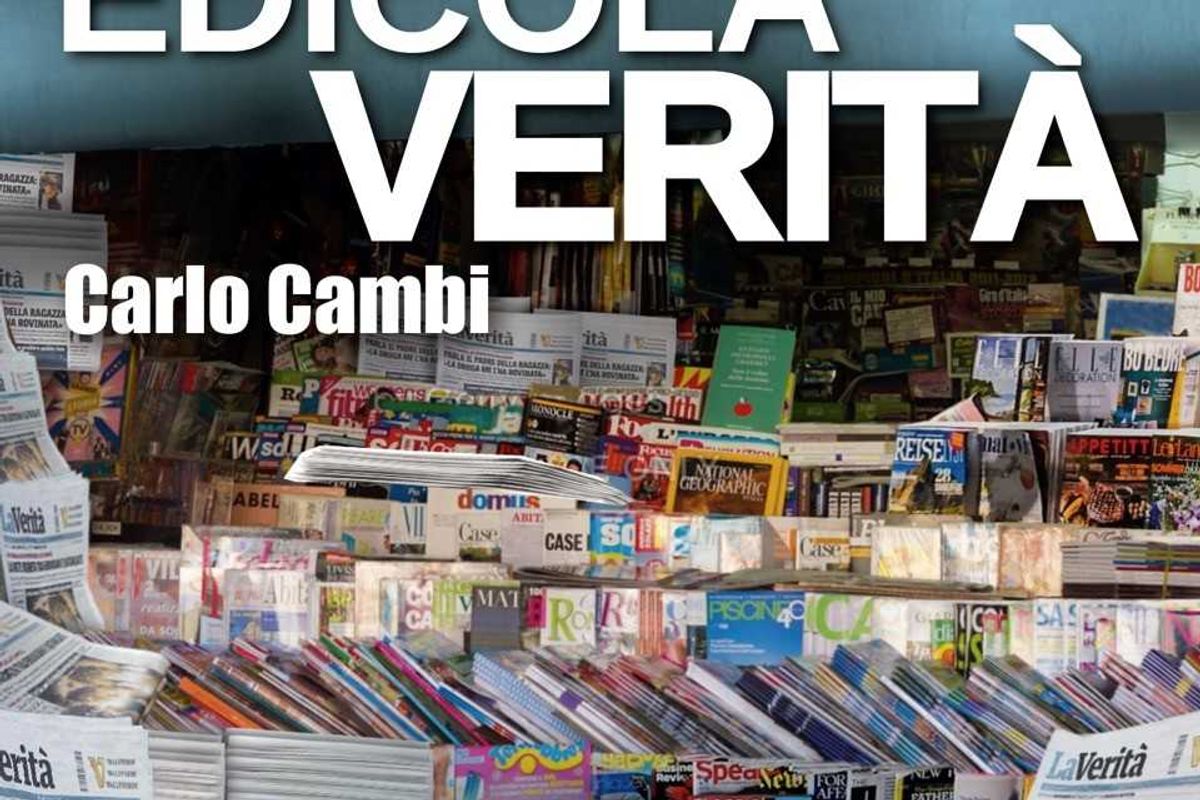Il governo si affida alla Cassazione. Si tratta dell’ultimo salvagente per evitare il pagamento di un maxi-risarcimento da 1 miliardo a Tim. Il versamento vista l’ampiezza imporrà la revisione della Finanziaria. Proprio per questo Giorgetti ha preso tempo. Per pagare c’è sempre tempo. Tanto più che la Corte d’Appello di Roma, nel disporre l’ordine di pagamento non ha imposto garanzie. La mancanza di obblighi vincolanti darà un po’ di respiro al debitore. Ma sarà solo un modo di prendere tempo. L’eventualità per il Tesoro di evitare il salasso sono piuttosto scarse: sia perché il governo ha perso la causa in primo e in secondo grado sia perché quattro anni fa (7 settembre 2020), affrontando un caso simile la Suprema Corte aveva pronunciato una condanna definitiva a carico del governo. A vincere era stata la vecchia Omnitel (nel frattempo incorporata da Vodafone) ma il danno per lo Stato in quel caso era stato piuttosto limitato: appena 49 milioni.
Stavolta, in gioco ci sono grandezze ben più consistenti visto che l’originario rimborso dagli iniziali 529 milioni si è gonfiato di sanzioni e interessi fino a un miliardo. Se il Tesoro dovesse aspettare la sentenza della Cassazione, prevista nel 2026, il conto crescerebbe di altri 25 milioni.
Naturale a questo punto chiedersi: chi è il vero colpevole di questa debacle giuridica ed economica che si protrae da ventisei anni?
Spoiler: non certo l’attuale ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che nel 1998, all’epoca dei fatti (come usa dire visto che stiamo parlando di un lungo contenziosi giudiziario) aveva appena ventidue anni e studiava alla Bocconi. Tanto meno Giorgia Meloni che in quel momento faceva i primi passi in politica come consigliere provinciale a Roma.
La paternità del danno va attribuita nientemeno che a Romano Prodi. Era il Presidente del Consiglio in carica e con il suo governo mise in atto una serie di decisioni che oggi, dopo quasi tre decadi, pesano come un macigno sulle casse dello Stato.
Nel 1998 l’Italia si preparava a fare il salto nella tanto attesa «liberalizzazione» del mercato delle telecomunicazioni. A favorirlo era stato lo stesso Professore come presidente dell’Iri avviando la vendita di Telecom Italia. Fu definita la «madre di tutte le privatizzazioni» visto l’incasso record di circa 26.000 miliardi di lire. In realtà un’operazione sgangherata i cui effetti negativi, come si vede, non sono ancora cessati.
Finalmente, scrivevano le liriche di quei giorni, il monopolio statale stava per cedere il passo a un panorama competitivo, nel quale le compagnie telefoniche avrebbero potuto operare senza le catene di una concessione statale. La rivoluzione del telefono nel nome dei cellulari.
Peccato che, tra le tante leggi, decreti e regolamenti che dovevano accompagnare questa «rivoluzione», il governo Prodi decise di mantenere il canone di concessione nonostante Bruxelles ne avesse sancito l’abolizione a partire dal 31 dicembre 1997. La scomparsa dell’autorizzazione pubblica serviva proprio ad aprire il mercato e favorire la concorrenza.
Al governo Prodi, però i 529 milioni servivano assolutamente perché bisognava lucidare i conti pubblici in vista dell’ingresso nell’euro ormai imminente. Per raggiungere questo traguardo, già nei mesi precedenti, il Professore aveva cercato tutte le scorciatoie. A cominciare dalla famosa Eurotassa che fruttò 4.300 miliardi e la promessa di tempestiva restituzione. In realtà si trattò di una semplice partita di giro perché il rimborso al 60% fu coperto da nuove tasse.
Un gioco contabile ma in quel momento valeva tutto perché la priorità assoluta era l’ingresso dell’Italia nella moneta unica attraverso la porta principale. E siccome in politica il fine giustifica i mezzi il governo Prodi fece un’eccezione anche alle sue convinzioni. Per anni ci siamo sentiti dire che bisognava adeguarsi «perché ce lo chiede l’Europa», in quel caso ci fu un’eccezione: l’Europa ordinava all’Italia di rinunciare al canone. Ma siccome l’obolo imposto alle compagnie telefoniche era necessario per lucidare i conti pubblici venne ignorato. Incasso immediato e poi si vede. L’eventuale problema sarebbe finito in capo a qualche altro governo. Come puntualmente accaduto.
Sì, perché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, qualche anno dopo, avrebbe sancito che il canone era non solo ingiusto, ma proprio illegittimo secondo le normative comunitarie. Come se non bastasse, la sentenza che ha portato alla restituzione dei 529 milioni di euro più gli interessi ha ripreso la stessa posizione dell’Europa, dando ragione a Vodafone Omnitel, anch’essa coinvolta nella stessa storia di canoni non dovuti.
Adesso la partita è arrivata in vista del fischio finale: lo Stato può pagare subito un miliardo evitando l’ulteriore aggravio di 25 milioni vincolandoli all’eventuale restituzione in caso di vittoria in Cassazione. Oppure cercare una transazione. Una sola certezza: a pagare l’azzardo di Prodi del 1998 saranno i contribuenti italiani.