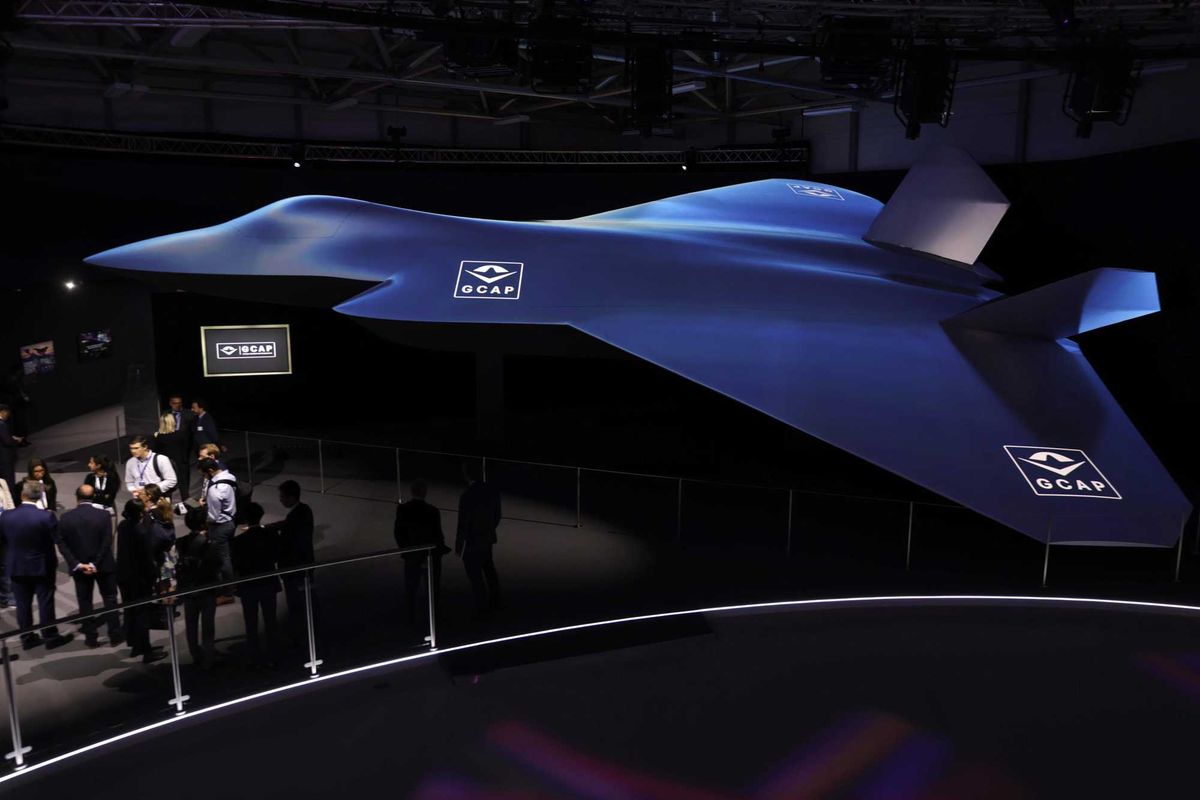È un piccolo scrigno di bellezze diverse. Tesori che spaziano tra storia, arte e paesaggio, con nicchie golose che manco ti immagini su di una superficie di quattro chilometri quadrati, sedici se consideriamo il perimetro di coste e insenature. Poco più di diecimila abitanti mobilitati per raccontare il meglio di Procida, la prima isola ad essere nominata Capitale italiana della cultura. Un 2022 che si presenta con una programmazione tesa a valorizzare «la più piccola e riservata delle isole del golfo di Napoli, un luogo vero che non si è mai travestito per il turista». Forse ha contribuito anche la lunga presenza del carcere di sicurezza presso il palazzo d'Avalos, in precedenza sede del potere temporale isolano.
Tutti ricordano Il Postino, dove Massimo Troisi incrociò la bellezza di Maria Grazia Cucinotta, ma l'isola divenne la piccola enclave senza tempo di Elsa Morante e Alberto Moravia che le dedicarono brani scolpiti sulla pietra. L'autrice de L'Isola di Arturo, che le valse il premio Strega 1957, così la descrive «la mia isola ha straducce solitarie chiuse tra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano giardini imperiali». Rincara la dose Alberto Moravia, osservandola dal mare, per un articolo su Le Vie d'Italia. «Procida ha l'incanto di una verginità omerica, con la spiaggia deserta e i pochi pescatori accovacciati a rammendare in silenzio le reti stese sulla sabbia. Le case specie di alveari dai colori teneri con le terrazze dai panni di tutti i colori appesi a mezz'aria». Un'isola nata dai vulcani, tanto che Moravia stesso lo conferma «con quelle insenature semicircolari che si ha l'impressione di navigare nella bocca allagata di un vulcano».
Pesca e orti, quindi, a dare identità alla tavola. Ma anche una pregiata produzione vinicola, sin dai tempi dei romani, tanto che «è una distesa a perdita d'occhio di pali di castagno - i ciaravoni - l'elemento dominante del paesaggio». Corricella lo storico borgo di pescatori, di una bellezza tale che «è come una pin-up che fa da copertina per siti e opuscoli turistici anche di altre isole». La flotta piscatoria composta dalle piccole zaccalee, ideali per la pesca delle alici. In procidano recitano saccaleva, proprio per la tecnica usata: si immergeva una sacca in mare e quando era colma di alici la si issava e chiudeva, come un sacco. Poi le paranze, altre piccole e scenografiche barchette che tiravano a sé quanto offriva Nettuno tra insenature e calette. Il pesce più pregiato prendeva la via del mercato di Pozzuoli, il resto andava a comporre fritture assortite, ovvero «la mazzamma», il pasto quotidiano delle famiglie. Non mancava la tonnara, attiva tra marzo e ottobre, gestita dal rais, l'ultimo ad ammainare la bandiera, negli anni Cinquanta, Vincenzo Carlo Intartaglia. Poi vi erano i lanzaturi, i solisti dell'arpione, «i tratti somatici tipici di chi ha la pelle impressa di sale e sole» che, dalla prua della loro barchetta, scrutavano i fondali marini, pronti a colpire, conoscitori di ogni segreto di polipi e seppie.
In ogni famiglia la zuppa di pesce fujut rappresentava il rito dell'attesa. Le madri di famiglia, con i mariti al largo, preparavano una zuppa di verdure… ma se dalle reti non giungeva niente ai fornelli, per il «pesce fuggito», ecco che si integrava il tutto con uova e fette di pane a dare sostanza. Autentica leccornia il calamaro ripieno. Di tutto un po': pane, formaggio, ma anche uova, uva passa e pinoli. Rosolato con antica sapienza e servito con passata di pomodoro. Alle lumache di mare (gli scuncilli) si attribuivano effetti afrodisiaci. A seconda di come le si sognava nelle notti di luna piena, i migliori auspici per gli incontri del giorno dopo. Culto per eccellenza gli spaghetti ai ricci di mare. Un tempo già sacrificati appena emersi dalle acque su adeguate fette di pane. Ora la loro raccolta è molto limitata, ma c'è chi si adopera, come Michele Trapanese, per un allevamento sicuro e protetto.
Dal mare all'orto il passo breve. Le parule sono i campi dove si coltivano gli ortaggi, saporiti con quel tocco in più perché irrigati dall'acqua salmastra tirata su dai pozzi profondi, «portati alle cisterne da asinelli pazienti». Non solo pomodori, ma uno dei prodotti identitari dell'isola, i carciofi mammarella, parenti di quelli romani. Gli abitanti della vicina Chiaiolella venivano chiamati anche «turzi», termine dialettale per indicare i gambi dei carciofi. Piatto d'artista la parmigiana di primavera. Una sorta di tortino dove i carciofi vanno in abbinamento goloso con uova, formaggio, pomodoro. Una piccola scultura edibile. Sulla parmigiana classica non si scherza, tanto che qui, alle melanzane, si riserva un trattamento particolare. Formaggio grattugiato (e non mozzarella) e poi, dopo l'infornata d'ordinanza, non le si taglia a fette, ma vengono «sfogliate» uno strato alla volta. Altro protagonista delle primizie primaverili il cavolo cappuccio, magari abbinato in zuppa con le fave. Un rinvio alle usanze rinascimentali le fave con l'agresta, l'ultimo raccolto, piatto simbolo della vigilia di san Giovanni, il 23 giugno, abbinate con il succo dell'uva acerba.
Isola di pescatori dove la carne è il piatto della festa. Il coniglio alla procidana nasce dalle battute di caccia dei Borbone nella loro tenuta di Vivara. A differenza di quello di Ischia il coniglio procidano è di pezzatura più piccola, circa un chilo, e aromatizzato solo con rosmarino. Stufato lunghe ore nella teglia di terracotta pura goduria poi farne la scarpetta del fondo di cottura. Quando il coniglio scappa di corsa dalla dispensa arriva il maiale. Una piccola antologia isolana. Un rito il tianello, vari ritagli, di cotiche e frattaglie, preparate a mo' di polpette e abbinate a involtini di manzo. Il sugo a condire i paccheri. Per palati palestrati la zuppa forte: frattaglie, guanciale, conserva di pomodoro, con grattugiata finale e assassina di bucce d'arancia e limone. Impossibile negarsi la mandragula, un sanguinaccio reso piccante dal peperoncino tritato e servito poi a fette con soffritto di cipolle.
Siamo in un'isola con vista Vesuvio, e quindi la tradizione va rispettata, anche se la pizza qui va in deroga. Niente forno, ma cotta in padella, ad esempio con le scarole, arricchite di uva passa, pinoli, capperi e acciughe, con grattata finale di limoni. Quelli procidani hanno un'identità propria, detti anche limone pane, considerato l'importante ruolo dell'albedo, la sottobuccia di polpa bianca. Simili ad un cedro, possono arrivare a pezzature importanti, anche di mezzo chilo. Un frutto dal sapore più dolce e meno aspro del limone comune. Ideale in insalata, con olio, menta, sale, vuoi mai un succo d'arancia e qualche acciuga. Ogni famiglia i suoi piccoli segreti, raccolti scrupolosamente da Giovanni e Maria Iovine, ambasciatori della miglior cucina locale.
Non può mancare lo street food alla procidana. Il colurcio è un mezzo panino imbottito con il cozzetto (la chiusura) nella parte finale, giusto che non scappi niente. Si toglie la mollica e si pressano i pomodorini all'interno, così che vadano ad impregnare il tutto, dopo averli arricchiti con basilico, cipolla e peperoncino. Si chiude con la mollica avanzata e si abbellisce il tutto con un filo d'olio e qualche fogliolina di basilico.
Procida è un'isola dove non ci si nega nulla, e quindi anche la dolciaria è ben radicata nella tradizione. Qui il casatiello è una ciambella pasquale fatta con il «criscito», il lievito madre del pane ma, dagli anni Cinquanta, la star è una sola, le lingue dolci. Doppio strato di sfoglia farcito di crema pasticcera o al limone. Inventata da Pasquale Mazziotti, un pasticcere arrivato da Napoli che così si è guadagnato a futura memoria la cittadinanza isolana. Il segreto è sgranocchiarne la crosta zuccherata croccante. Tutto il resto conseguente.