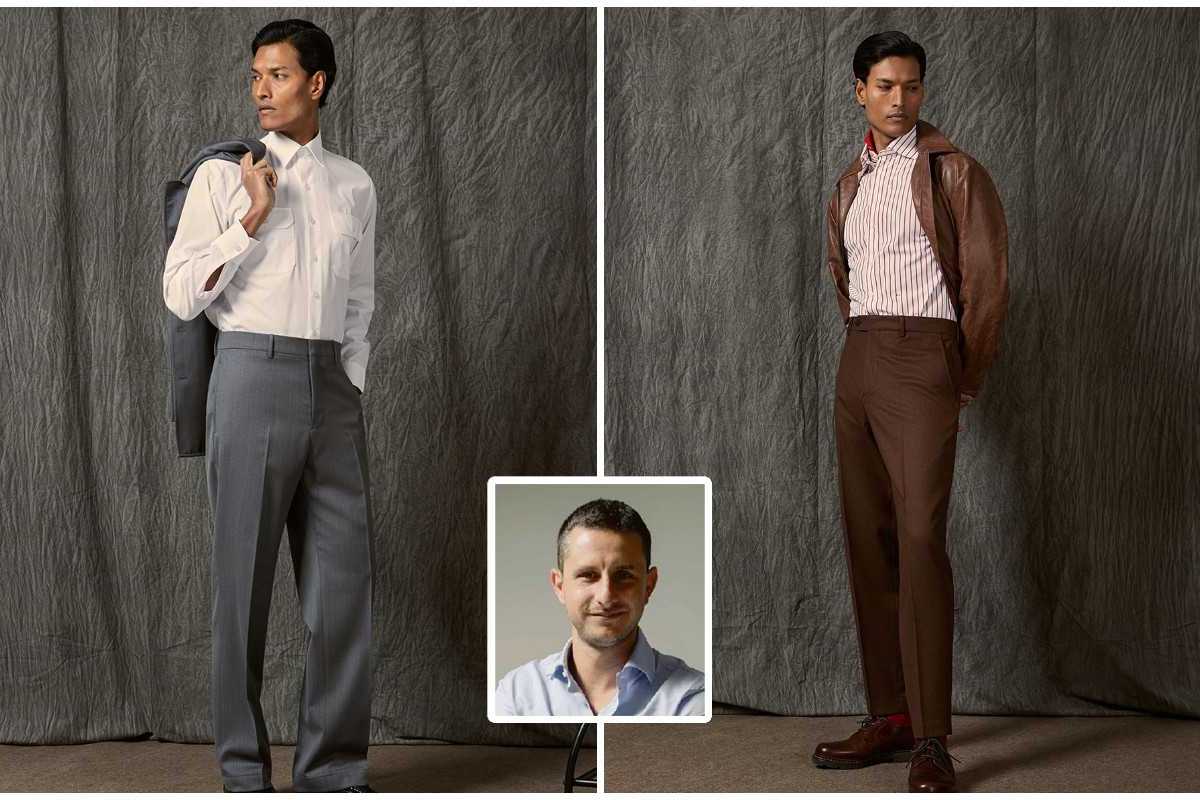Il primato europeo è un’anomalia. Va cambiata la Carta per porvi rimedio
Presidente di sezione a riposo
della Corte di Cassazione
Una delle più pericolose, tra le varie mine vaganti disseminate nella nostra Costituzione, è certamente quella contenuta nell’articolo 117 che, nel testo sciaguratamente sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni sia esercitata nel rispetto non solo (come sarebbe ovvio) della Costituzione, ma anche «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò comporta che l’efficacia di tali vincoli viene a essere formalmente equiparata a quella delle norme costituzionali, per cui, in caso di contrasto con le norme interne, queste ultime debbono essere dichiarate incostituzionali, salvo solo il caso - come più volte affermato dalla stessa Corte - che operi il cosiddetto «controlimite», costituito dalla salvaguardia, in ogni caso, dei «principi fondamentali» della nostra Costituzione. L’eventuale incostituzionalità si profila, in particolare, nel caso di contrasto tra norme interne e direttive europee, le quali non hanno, di regola, diretta efficacia nell’ordinamento di ogni singolo Stato ma impegnano quest’ultimo a recepirle con propri provvedimenti che, in Italia, hanno forma, in genere, di decreti legislativi. Sono, quindi, questi ultimi, al pari di ogni altra norma interna, preesistente o successiva, a correre il rischio dell’incostituzionalità qualora si ravvisi un contrasto con le direttive.
L’anomalia di tale disciplina consiste nel fatto che essa deroga al fondamentale e da sempre indiscusso principio secondo cui, essendo lo Stato e non ogni singolo cittadino il contraente dell’obbligo derivante da un accordo internazionale (quale è anche quello di adesione all’Unione europea), solo allo Stato - e per esso all’autorità politica che di volta in volta lo rappresenta - spetta di stabilire se, a seconda delle circostanze, l’osservanza di quell’obbligo sia o meno politicamente conveniente. E la convenienza va valutata con riguardo alle conseguenze, positive o negative, di qualsivoglia natura, che, a seconda della scelta, si produrrebbero tanto sul piano internazionale quanto su quello interno. Va da sé, naturalmente, che, trattandosi di scelta affidata all’autorità politica, sarà poi questa a risponderne, politicamente, ai suoi cittadini, in tutti i modi possibili e immaginabili, a seconda del tipo di ordinamento vigente nello Stato.
L’abnorme risultato, invece, della «costituzionalizzazione» delle direttive - cui si accompagna quella delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea che ne indichi la corretta interpretazione - è quello che viene a scomparire il potere, proprio dell’autorità politica, di compiere la suddetta valutazione. Infatti, anche quando l’attuazione di una direttiva sia da ritenere in radicale e grave contrasto con gli interessi nazionali, questi vengono necessariamente a soccombere a fronte della eventuale constatazione, nel giudizio di costituzionalità, che la norma interna con la quale si è inteso salvaguardarli non è conforme alla direttiva, per cui non può che essere soppressa. E non varrebbe osservare in contrario che l’inosservanza di una direttiva europea, comportando la possibilità di una procedura d’infrazione da parte dell’Unione a carico dello Stato inadempiente, si tradurrebbe, per quest’ultimo, in un danno che sarebbe sempre e comunque suo interesse evitare. Lo Stato che sia ritenuto colpevole dell’infrazione, infatti, ai sensi dell’articolo 260 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), può essere soltanto condannato, dalla Corte di giustizia, al pagamento di una non meglio precisata «somma forfettaria» o «penalità»; e non è detto che ciò non dia luogo, per esso, a un danno minore di quello che, nella sua valutazione, potrebbe derivargli dalla puntuale attuazione della direttiva. Vero è che, nei rapporti internazionali, dovrebbe sempre valere il principio del pacta sunt servanda (i patti vanno osservati). Altrettanto vero è, però, che non è certo il giudice nazionale ad aver titolo per imporre alla legittima autorità politica del proprio Paese di attenersi al detto principio, pur quando essa ritenga, presumibilmente a ragion veduta, che, nell’interesse pubblico, sia meglio derogarvi, assumendosene (come si è detto) la relativa responsabilità.
Ed è il caso di osservare, a questo punto, per venire all’attualità, che proprio a causa della «costituzionalizzazione» delle direttive europee in materia di immigrazione, per effetto dell’articolo 117 della Costituzione, la magistratura si è ritenuta legittimata, in alcuni casi, a disapplicare direttamente le norme interne ritenute con esse in contrasto e, in altri casi, a sospenderne l’applicazione in attesa della risposta della Corte di giustizia europea al quesito sul come quelle direttive debbano essere interpretate, per poi verificarne la compatibilità o meno con le norme interne. Iniziative, queste, la prima delle quali è, peraltro, da ritenere assolutamente illegittima, giacché alla disapplicazione delle norme interne ritenute in contrasto con quelle europee può darsi luogo, in virtù del noto e pacifico principio della prevalenza di queste ultime sulle prime, soltanto quando le norme europee siano dotate di diretta efficacia nell’ordinamento interno; il che si verifica, ai sensi dell’articolo 288 del Tfue, per i regolamenti, ma non per le direttive. Nel caso, quindi, di ritenuto contrasto delle norme interne con queste ultime, il giudice non può disapplicarle, ma solo sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, così come farebbe in qualsiasi altro caso di ritenuto contrasto tra una legge ordinaria e la Costituzione. E solo in vista di tale eventualità trova giustificazione l’altra iniziativa costituita dalla proposizione del quesito alla Corte di giustizia europea, giacché proprio dalla risposta a tale quesito potrebbe dipendere la riconoscibilità o meno del contrasto tra direttive e norme interne.
Ben si comprende, quindi - e può condividersi - la ragione per la quale la Lega ha proposto, in Senato, che l’articolo 117 della Costituzione venga nuovamente modificato nel senso di rendere obbligatoria, per il legislatore ordinario, soltanto l’osservanza della Costituzione e non dei vincoli europei o internazionali. Il che, contrariamente a quanto sostenuto da taluni frettolosi e scandalizzati critici, lascerebbe intatto il principio di prevalenza del diritto dell’Unione su quello interno, attesa la sua già ricordata applicabilità soltanto nel caso in cui le norme europee abbiano - come continuerebbero ad avere - diretta efficacia nell’ordinamento interno. La proposta della Lega è stata, per ora, bloccata in commissione (a quanto è dato sapere) per la sua ritenuta eterogeneità rispetto al contenuto del disegno di legge sulla separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, in cui avrebbe dovuto essere inserita. Ma questo non impedisce di sperare che sia ripresa al più presto, in altro modo e con miglior fortuna.