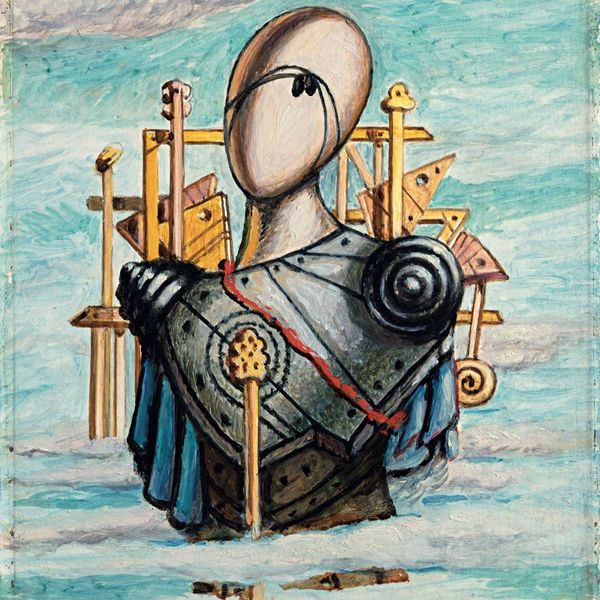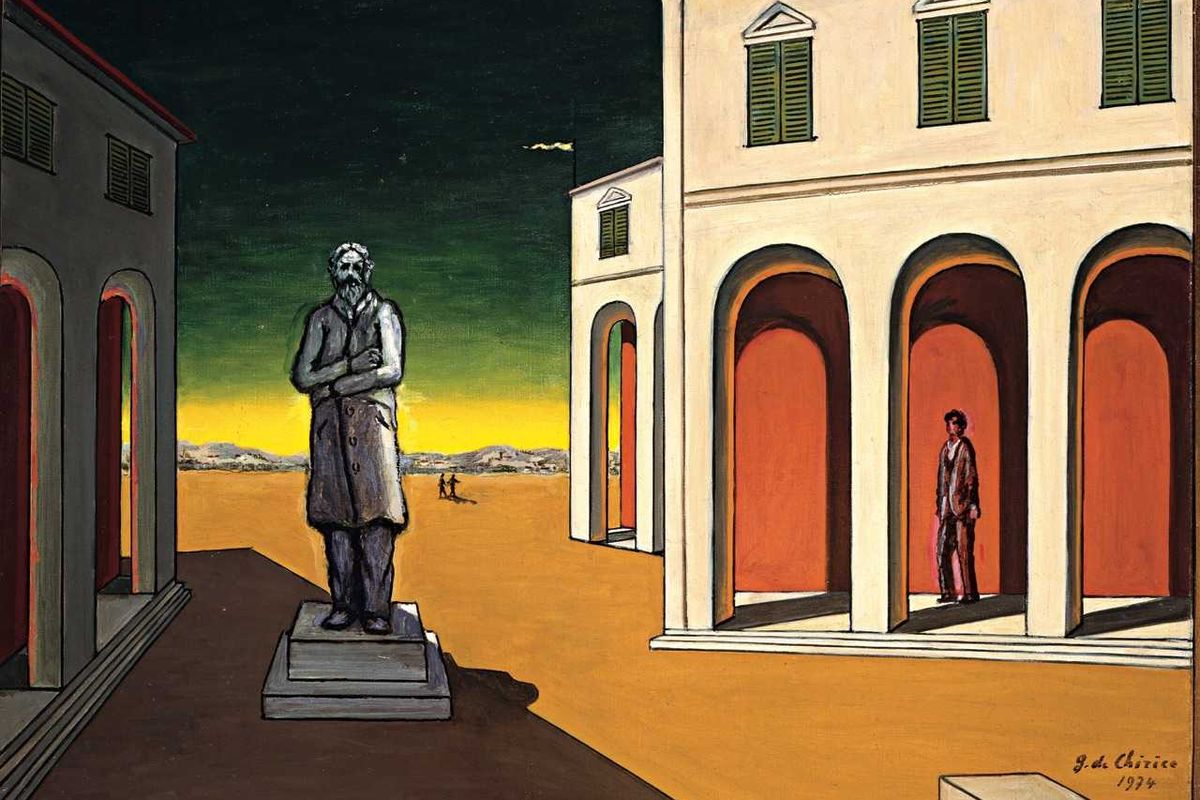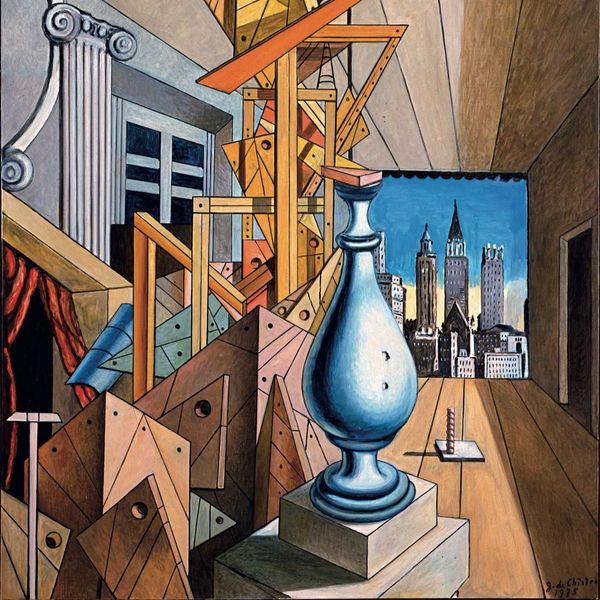Prima o poi arriva il momento - solitamente tragico - di fare i conti con la realtà. E di solito non si tratta di un momento piacevole: più si è alienati, più l’impatto con il muro del reale è distruttivo. Negli ultimi giorni stiamo purtroppo assistendo a schianti di diversa gradazione. Il più violento è senz’altro quello che ha coinvolto la povera Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata morta nel Lambro domenica scorsa. Probabile si sia tolta la vita, forse anche perché schiacciata dal peso degli attacchi ricevuti via social network dopo aver pubblicato un post di dubbia veridicità. In fondo non importa poi molto di chi sia la responsabilità di questa atrocità, ammesso che vi sia un responsabile preciso.
Il punto è che sono davvero in pochi a rendersi conto di quanto possano lacerare insulti e critiche martellanti ricevuti online. Si sputa veleno a cuor leggero, si pensa di avere il diritto di giudicare chiunque, di entrare a piedi pari nella vita altrui. E ci si illude che tutto questo non abbia conseguenze visto che avviene nel mondo etereo del Web. Allo stesso modo, è diffusa la convinzione che essere celebri, «seguiti», sia meraviglioso, che esporre la vita privata o anche solo il volto al pubblico sia divertente e leggero. Solo che, se ti fai vedere, ti esponi, e gli altri ti guardano. E troppo di frequente non hanno occhi buoni e si sentono autorizzati a commentare senza compassione alcuna. La vacuità digitale è fumo, ma quando si dirada compare all’improvviso una parete di roccia, che può anche stroncare.
Se il caso di Lodi è sicuramente il più estremo e terribile, decisamente meno angosciante è quello riguardante gli studenti del prestigioso liceo romano Tasso. Tempo fa hanno occupato la scuola per una settimana, e ora i vertici dell’istituto hanno deciso di sanzionarli: cinque in condotta e dieci giorni di sospensione, di cui due a casa, ai 170 occupanti. Pare, riferisce Repubblica, che i genitori del «liceo bene» siano ferocemente divisi sul provvedimento disciplinare: chi lo ritiene sensato, chi grida all’ingiustizia.
Tra i difensori d’ufficio si sono manifestati alcuni parlamentari del Pd, tra cui la sempre brillante Michela Di Biase in Franceschini (che ultimamente ha avuto a sua volta qualche guaio assieme ad Alessandro Zan), e poi qualche commentatore politico (l’autorevole Luciana Castellina) e qualche vippetto.
Il preside del liceo e 32 insegnanti, per tutta risposta, hanno firmato una lettera aperta in cui descrivono una occupazione animata da «musica, balli, birra e spritz», e stigmatizzano la decisione di protestare «presa nell’ambito dei collettivi politici da un manipolo di studenti che impone la scelta a tutti gli altri e nottetempo entra a scuola bloccando la didattica curricolare a vantaggio di lezioni tenute da ospiti più o meno famosi e corsi su fumetti, fotografia, burraco tenuti da sedicenti rivoluzionari».
A colpire più di ogni altra, tuttavia, è l’uscita pubblica degli studenti dei collettivi che - ovviamente via Instagram - hanno rampognato non poco: «Ciò che ha attirato l’attenzione della stampa, del ministero e dell’opinione pubblica non sono state le nostre richieste e il nostro dissenso, bensì il modo in cui è stato represso, non educativo ma punitivo». Cinque in condotta (recuperabile) e sospensione (prevista dal regolamento) sarebbero punizione e non educazione? E per educare, che cosa dovrebbero fare i dirigenti scolastici? Premiare gli occupanti?
Di nuovo, ai baldi giovani tocca fare i conti con la realtà rasposa: se vuoi «combattere il potere», quello reagisce. È facile farsi coccolare dalle belle parole dei rivoluzionari da divano e dei sobillatori mediatici che tirano per tutti i ribelli in erba da Ultima generazione in giù. Poi i nodi vengono al pettine, e allora sono dolori: il colpo di frusta misura la separazione tra la fantasia e i fatti, e può in effetti rivelarsi estremamente educativo, molto più di certi corsi di affettività attualmente in gran voga.
Certo, non si può dire che le giovani generazioni possano contare su radiosi esempi. Basti pensare ai nostri politici che, da un paio d’anni, si atteggiano sui social a guerrieri normanni invitando a combattere per questa o quella causa, salvo poi che a crepare davvero ci vanno i poveri cristi sbattuti al fronte e non gli artiglieri da tinello gonfi della loro sicumera. Anche questo è un clamoroso caso di alienazione, di autoreclusione in una bolla, un universo artificiale. Che può sembrare paradisiaco quando lo si evoca, ma si rivela brutale quando collassa.