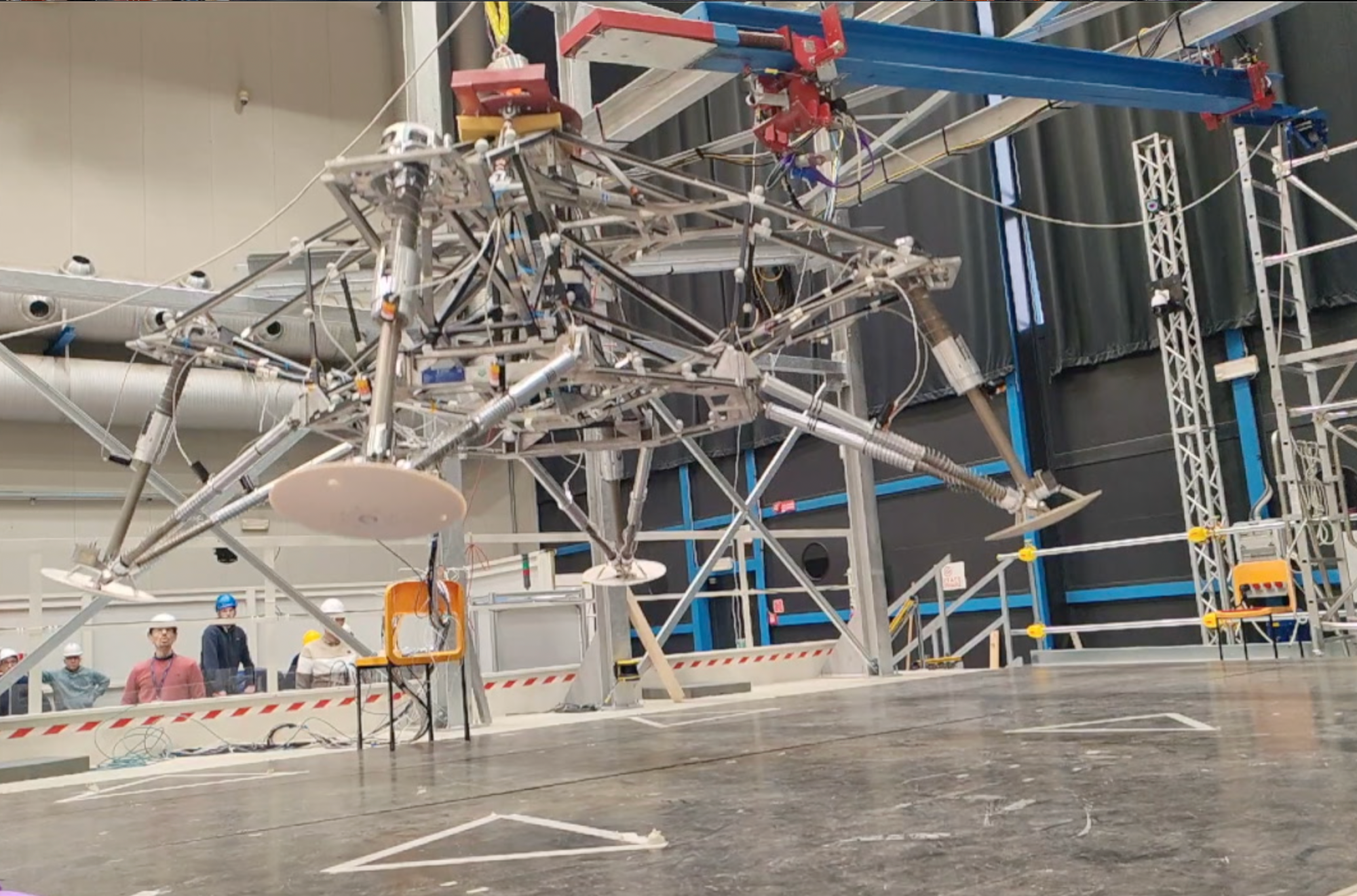Prestiti alle aziende, Italia fanalino di coda. La Bce svela il flop del decreto Liquidità
Sono passati solo pochi giorni da quando la Bce ha annunciato, nel proprio bollettino di fine mese, la crescita dei prestiti alle imprese nell'Eurozona. Tutte le agenzie hanno battuto trionfanti un incremento del 7,4%, ancora superiore al già robusto tasso di crescita del 6,6% registrato in aprile. Insomma, un segnale confortante circa il ruolo del sistema bancario nel finanziare milioni di imprese rimaste ferme a causa del blocco delle attività.Forti delle promesse dei decreti Cura Italia di marzo e Liquidità di aprile, siamo andati subito a scrutare il dettaglio Paese per Paese, abbastanza fiduciosi di trovare l'Italia nel gruppo di testa dei Paesi con il più alto tasso di crescita dei prestiti. In fondo la «potenza di fuoco» dei 400 miliardi schierata a reti unificate la sera del 6 aprile dal premier Giuseppe Conte doveva pur leggersi prima o poi nelle statistiche, giusto?
Mai delusione fu più cocente. Le statistiche dell'Eurozona si avvicinano sempre più alla definizione del poeta romano Trilussa: è vero che in media ci tocca un pollo all'anno, ma noi restiamo a digiuno e qualcun altro ne mangia due. Tra i 19 Paesi aderenti, siamo regolarmente quelli sotto la media e, soprattutto se confrontiamo i dati a livello internazionale, in particolare con Francia, Germania e Spagna, le altre tre maggiori economie dell'Eurozona, il raffronto è impietoso. Tanto che Conte, stizzito, giovedì dopo aver parlato con alcuni ristoratori è sbottato contro le banche: «Faccio appello ai direttori delle agenzie, è possibile che con una garanzia dello Stato poco inferiore al 100% non riescano a erogare un prestito? Questi signori torneranno nelle vostre agenzie, esaminate le loro pratiche. Io tornerò per capire che succede».
La crescita dei prestiti in Italia si attesta al 2,2% di maggio contro il 2,1% di aprile. In Germania la crescita è pari al 6,9%, quasi stazionaria rispetto al 7% di aprile. In Francia, a maggio registrano un +11,4%, contro un +9,2% di aprile. Perfino la Spagna, tuttora sotto programma di aggiustamento del sistema bancario per via del prestito ottenuto dal Mes qualche anno fa, sfoggia un sontuoso +9,5%, contro un già robusto +6,6% di aprile. Un divario enorme. Tradotto in cifre assolute, significa decine di miliardi in meno di prestiti.
Infatti, Germania, Spagna, Francia aumentano lo stock dei prestiti rispetto a fine febbraio, rispettivamente di 45 (+4%), 48 (+9,8%) e 91 (+8%) miliardi. L'Italia è fanalino di coda con soli 23 miliardi (+3%). Un numero che si commenta da solo e solo in apparente difformità con quelli snocciolati con enfasi ogni mercoledì nel comunicato congiunto di Mef, Mise, Banca d'Italia, Abi, Mcc e Sace Simest.
Numeri mirabolanti che però vanno letti con attenzione, per capire come mai la realtà offra un quadro diverso.
La differenza sta tutta nella coniugazione di alcuni verbi. Se la Banca d'Italia parla di richieste di finanziamento «pervenute» alle banche per l'accesso al Fondo di garanzia per le Pmi (946.000 per un importo di finanziamenti di oltre 63 miliardi), significa che l'istruttoria, l'invio al Fondo per la concessione della garanzia e l'erogazione all'impresa affidata non sono necessariamente avvenute. Anzi, l'erogato si ferma all'80% delle domande relative ai prestiti garantiti al 100% che, pur essendo ben 659.000, rappresentano un importo finanziato di soli 13 miliardi. Ma il dato ancora più significativo è quello delle domande pervenute al Fondo di garanzia presso il Mcc a opera delle banche, in altre parole cosa esce dall'imbuto delle banche diretto verso il Fondo per la concessione della garanzia. Apprendiamo che delle 742.000 domande (per finanziamenti pari a circa 43 miliardi) giunte al Fondo sono state accolte circa 733.000. Ma quanto è effettivamente erogato? È dato sapere solo che 13 miliardi con garanzia al 100% possono essere erogati dalle banche senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del Mcc. E gli altri 30? Viaggiano ancora raminghi tra il Fondo di garanzia e le banche che erogheranno quei prestiti solo quando sarà stata controllata anche l'ultima virgola di tutti i passaggi burocratici. Ecco come domande per ben 63 miliardi, a causa del necessario e duplice passaggio da banche e Fondo di garanzia, si riducono a un erogato molto più basso, sintetizzato dai 23 miliardi che abbiamo letto nelle statistiche Bce.
Le banche sono state chiamate in poche settimane a lavorare quasi un milione di pratiche di fido, dopo anni in cui la parola d'ordine proveniente da Francoforte era stata una sola: ridurre i rischi. L'impatto sulle organizzazioni non poteva che essere devastante, ulteriormente amplificato dagli effetti del rallentamento dell'attività a causa del Covid-19. «Non è facile istruire un fido seduto al tavolo in cucina», così si sfogò un bancario durante il lockdown, «soprattutto quando, se il Fondo trovasse una virgola fuori posto, la banca si vedrebbe negata l'escussione della garanzia e si ritroverebbe direttamente esposta verso il cliente insolvente. Quindi massima cautela».
C'è da chiedersi come sia stato possibile che al governo abbiano ritenuto di affidarsi a un sistema così farraginoso per fornire il sostegno più urgente, la liquidità necessaria per sopravvivere, che altri Paesi (come gli Usa) hanno erogato molto più speditamente. Da ultimo, a testimoniare che la macchina del credito stenta a esprimere la necessaria potenza, arrivano i dati Bce relativi ai finanziamenti erogati, per 564 miliardi netti, alle banche lo scorso 24 giugno al tasso negativo del 1%. Tutti si aspetterebbero che tali somme siano state prontamente erogate alle imprese. Al 26 giugno, invece, erano ancora depositate in Bce per ben 545 miliardi. D'altronde, così è facile fare il banchiere: ti prestano denaro pagandoti l'1% e puoi depositarlo in Bce pagando lo 0,5% o (fino a una certa soglia) lo 0%. Cosa potrebbe mai andare storto?