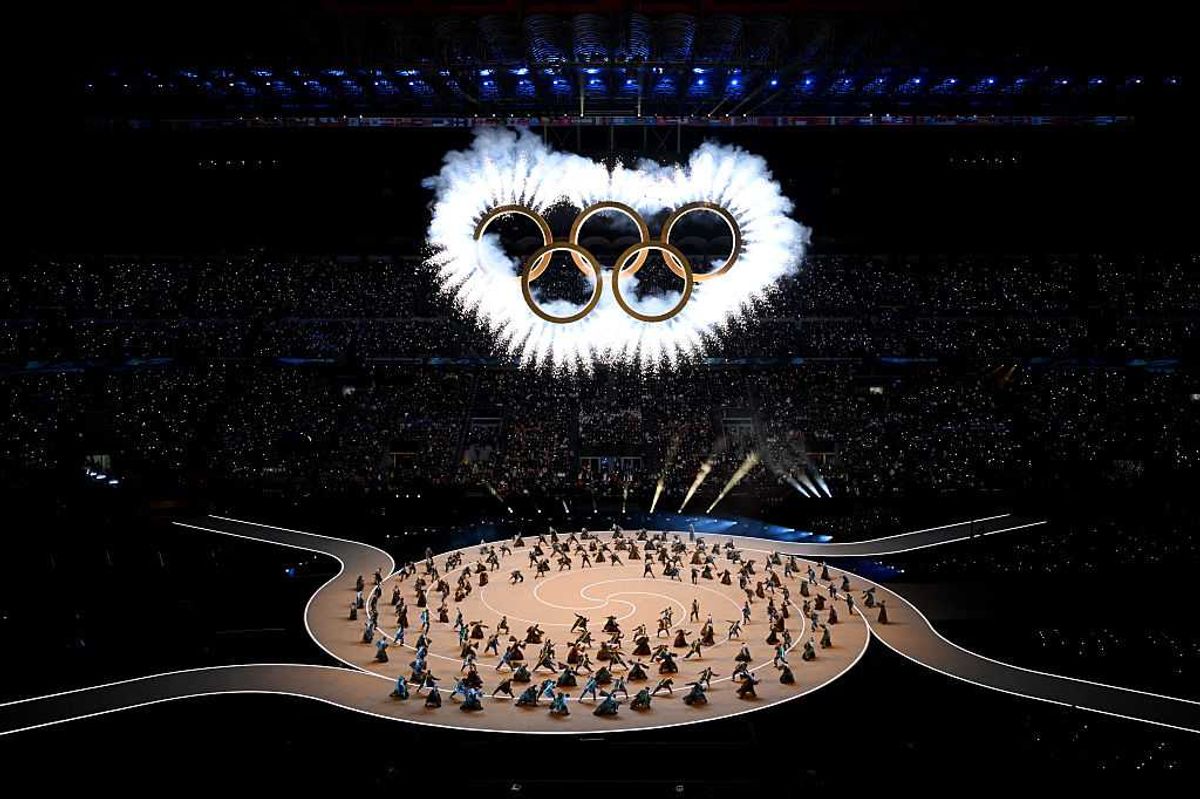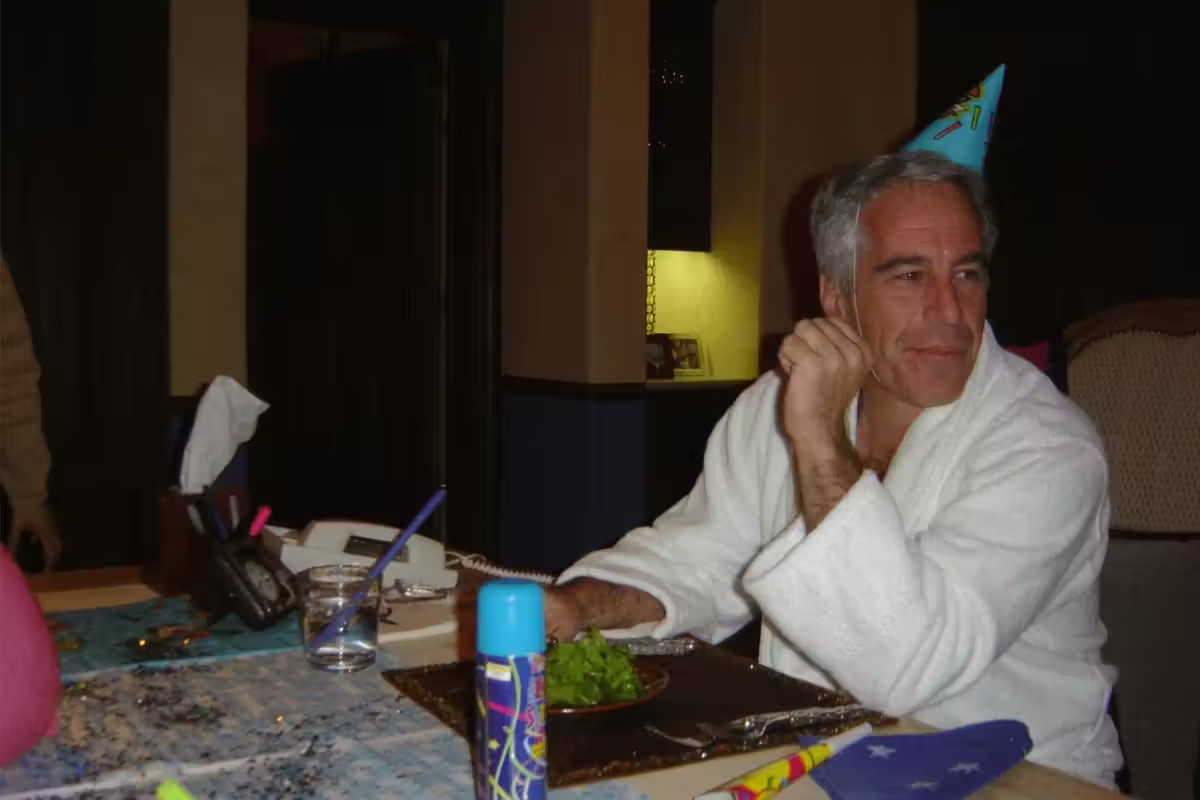Pensavamo di vivere in società libere. Ma abbiamo perso il freno del potere
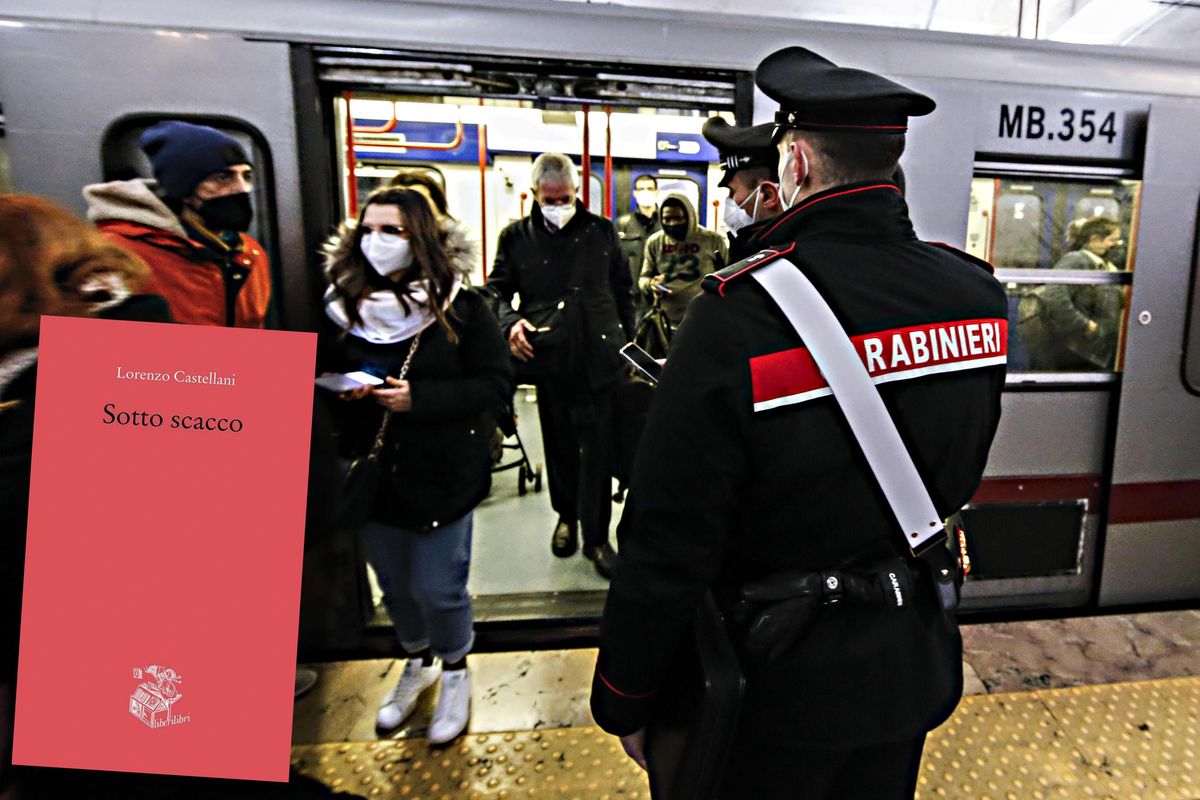
L’affannosa corsa emergenziale, accelerata dall’epidemia, spinge le istituzioni verso una nuova pianificazione che pretende di essere iper-razionale. La politica regredisce a mera regolazione dei rischi. Pretende di annullare l’errore, di minimizzare il danno, di controllare l’incontrollabile, di avere risposte dalla scienza che spesso la stessa scienza non può dare. Ma la coperta è sempre corta: se si cerca di ridurre il danno sanitario ci si espone a quello economico e viceversa, se si contiene il rischio pandemico ci si espone a quello sociale; se si persegue una politica scientifica ci si ritrova spogliati dai tecnici, mentre se si segue l’istinto politico puro ci si pone come navigatori dilettanti esposti alla tempesta. In ogni scenario, una legittimazione politica già da lungo tempo precaria, interna a quel regime che ancora chiamiamo democrazia, si indebolisce ulteriormente. Si rivolgono le proprie preghiere al tecnico, alla scienza, all’amministratore, al militare.
Questo nuovo potere indurito, su cui la classe politica non ha potuto far altro che mettere le mani con indecisione per affrontare l’emergenza, ha rotto le illusioni di un ipotetico ritorno del politico. [...] I regimi politici del prossimo futuro si fonderanno sempre più sulla amministrazione, sull’apparato scientifico-tecnologico, sull’intreccio tra capitalismo pubblico e privato, sui centri di fabbricazione della competenza e sempre meno sulla rappresentanza politica per come è stata concepita e vissuta nei decenni passati. In questo senso, la pandemia ha soltanto accelerato e reso evidente una tendenza di lungo periodo, ha divelto una maschera già precaria.
Difatti, nella concretezza del potere quotidiano, regimi all’apice del proprio autocompiacimento liberale e democratico hanno avanzato la più grande operazione di disciplinamento della popolazione che ci sia stata dalla fine della Seconda guerra mondiale. È in nome dell’emergenza che si è attivato il torchio della Banca centrale, liberati i bilanci dalla disciplina economica, avviato il complesso scientifico-industriale, fermate le attività economiche, classificate informazioni personali, ristrette le libertà, sovvertito il modo di vivere comune. [...] L’uomo occidentale credeva di vivere in sistemi liquidi e flessibili, ma con il cigno nero della pandemia ha compreso di vivere in regimi solidi e molto rigidi. E fragili come il cristallo.
Il prezzo per fronteggiare l’emergenza resta la inevitabile coercizione dello Stato sull’individuo. E oramai nessuno ignora che «trasformare il mondo» significa burocratizzare l’uomo. Dunque, qual è il confine del potere nell’emergenza? E quanto a lungo uno stato di emergenza si può giustificare prima di trasformarsi in qualcosa di più preoccupante? Questa appare la domanda fondamentale quando si guarda in faccia il nuovo volto del potere. Fino a due anni fa si credeva a ragione di vivere in società libere. [...] Davanti alla malattia e alla morte vi sono stati colpevolizzazione, controllo reciproco, responsabilizzazione individuale anche quando l’organizzazione sanitaria e della sfera pubblica lasciavano a desiderare. Impaurita dal ritorno del contagio, la stragrande maggioranza della popolazione ha diligentemente fatto la fila per i vaccini e ha mantenuto distanze e precauzioni. La preoccupazione nei confronti di frange minoritarie di indisciplinati, spaventati e paranoici ha portato ad accogliere il codice digitale, il certificato, il controllo esercitato da soggetti pubblici e privati. Le libertà e i diritti costituzionali sono stati compressi o, se si vuole essere meno drammatici, pesantemente riequilibrati tra loro. Lo Stato, soprattutto in Europa, ha esercitato di fatto un potere costituente, riscrivendo un precario contratto sociale. Tutto questo ha trovato la sua legittimazione in nome di uno stato d’eccezione leggero e apparentemente momentaneo. Ma fino a quando? Fino a che punto? Non c’è essere umano abituato all’utilizzo del dubbio e della ragione che non sia assillato da questa domanda al giorno d’oggi. Tutto tornerà «normale» come «prima»? Ma è quasi impossibile riavvolgere il tempo una volta che il normale è stato scavalcato dagli eventi.
Si è discusso molto delle trasformazioni di lunga durata dell’economia a seguito della pandemia. Molto meno si è riflettuto sulle potenziali trasformazioni della politica. Sembra quasi che l’attuale classe dirigente occidentale abbia scelto di ignorare, forse per esorcizzare il possibile caos o le potenziali derive dispotiche, le conseguenze politiche che il nuovo volto del potere potrà produrre. Si invoca spesso la rinascita del post-pandemia guardando al fiorire economico e sociale del dopoguerra. Ma allora, dopo anni di morte e devastazione ben peggiori, interi regimi politici e assetti sociali consolidati vennero abbattuti. [...] Lo scenario post-pandemico, se si escludono la variazione di paradigma economico e le restrizioni temporanee della libertà, appare assai meno innovativo. Non si scorgono all’orizzonte nuovi contratti né nuovi patti sociali né una costituzione europea.
Sul piano sociale, chi prima della pandemia aveva un curriculum, un reddito e una posizione solida uscirà ancor più rafforzato da questo tempo eccezionale. L’impressione è che il distacco crescente tra gruppi sociali sia stata forse accelerato più che ridotto dalla pandemia e dalle soluzioni politiche da essa scaturite. I sussidi non basteranno a rendere più giuste o meno inquiete le nostre società. Tuttavia, se lo Stato è, per dirla con Nietzsche, di tutti i gelidi mostri il più gelido, di ancor più tacita freddezza è l’apparato tecnico-produttivo, il «capitalismo immateriale» dei tempi nostri. Una totalità, in cui si dispongono e ordinano le singole competenze, sicché neppure la specializzazione del sapere salva l’individuo, ma lo conduce e racchiude all’interno di quella unità. Lo smart working, accelerato dall’espansione virale, risponde alla logica della più rigida funzionalità: la lontananza fisica esalta l’oggettività dell’apparato, che non ha bisogno di alcun luogo, poiché è capace di raggiungerci in tutti i luoghi, o, meglio, di sovrapporre il reale e il virtuale.
Mentre lo Stato pandemico disegna più angusti confini fisici, l’apparato tecnico-produttivo sfrutta l’emergenza per abolire la dimensione materiale dello spazio. Uno si mostra e delimita, l’altro scompare e penetra. Mentre l’espansione virale ci stringeva nelle nostre case, il senso della proprietà privata sembrava rafforzarsi. La vita esterna poteva restare sospesa, ma almeno le nostre mura non erano a rischio di limitazioni, espropri o danni, al contrario di quanto, ad esempio, può accadere durante le guerre o altre calamità naturali. Tuttavia, mentre la proprietà ci difendeva dalla malattia e offriva riparo dalle restrizioni, fuori l’economia si predisponeva in modo da erodere il futuro della proprietà; il capitalismo tecnologico sfruttava la pandemia per far avanzare a grandi passi la sharing economy. A cosa serve comprare un’auto o un monopattino o una bici quando è possibile affittarla per brevissimi periodi, ridurre i costi ed eludere il problema del parcheggio? Perché rischiare il contagio sui mezzi pubblici quando si può sfruttare il servizio di una app? Perché prelevare contanti quando si può pagare dallo smartphone? Mentre eravamo chiusi in casa per l’emergenza sanitaria, le nostre strade fiorivano di mezzi a noleggio. Le applicazioni per comunicare, informarsi, intrattenersi, acquistare, ricevere, spostarsi si moltiplicavano. I governi, poi, scorgevano e sfruttavano una nuova emergenza all’orizzonte, quella ambientale, e destinavano i denari pubblici verso politiche green che miravano a minori consumi e maggiore efficienza. Poche cose sembrano più convenienti di un noleggio verde, ecologico. Tuttavia, nuove regole e incentivi dall’alto orientano le persone verso una determinata tipologia di consumi: ci sono nuove possibilità, ma di fatto anche nuove limitazioni delle nostre azioni.
In questa fase, essere proprietari di beni materiali è sempre meno incentivato dal sistema politico ed economico. Persino possedere una casa, se si considerano la crescente tassazione e i costi di manutenzione, è diventato poco conveniente. La proprietà da elemento duraturo, tradizionale, dinastico si è trasformata in consumo transitorio, esclusività momentanea. Le vecchie libertà - come pagare con i contanti chi, dove e come si vuole o comprare un’automobile potente o semplicemente non cambiare quella che si è invecchiata - e il vecchio ordine - la proprietà materiale che passa attraverso le generazioni o la soddisfazione dell’acquisto di un bene a tempo indeterminato e a nostra esclusiva disposizione - lasciano spazio a un mondo in cui tutti possono spendere e consumare sempre di più, ma riescono ad essere sempre di meno proprietari di qualcosa. Un mondo in cui, in definitiva, concorriamo per l’usufrutto momentaneo sulla proprietà collettiva o oligopolistica. Ma l’uomo senza proprietà è svestito di fronte al potere tanto quanto quello bene intrattenuto e soddisfatto è pigro nella vigilanza.
Il mondo nuovo di Huxley ci spinge a riflettere sui rischi e le illusioni di tanta accondiscendenza verso il progresso. Mustapha Mond si rivolge a John il selvaggio, cercando di convincerlo ad abbandonare la sua vita bucolica per tornare alle comodità del mondo civile. Il profetico selvaggio ribalta l’invito: «Ma non voglio comodità. Voglio Dio, voglio la poesia, voglio il vero pericolo, libertà, bontà. Voglio il peccato». «E dunque», dice Mustapha Mond, «stai reclamando il diritto all’infelicità ». «Così sia», dichiara il selvaggio con tono di sfida, «sto reclamando il diritto all’infelicità».