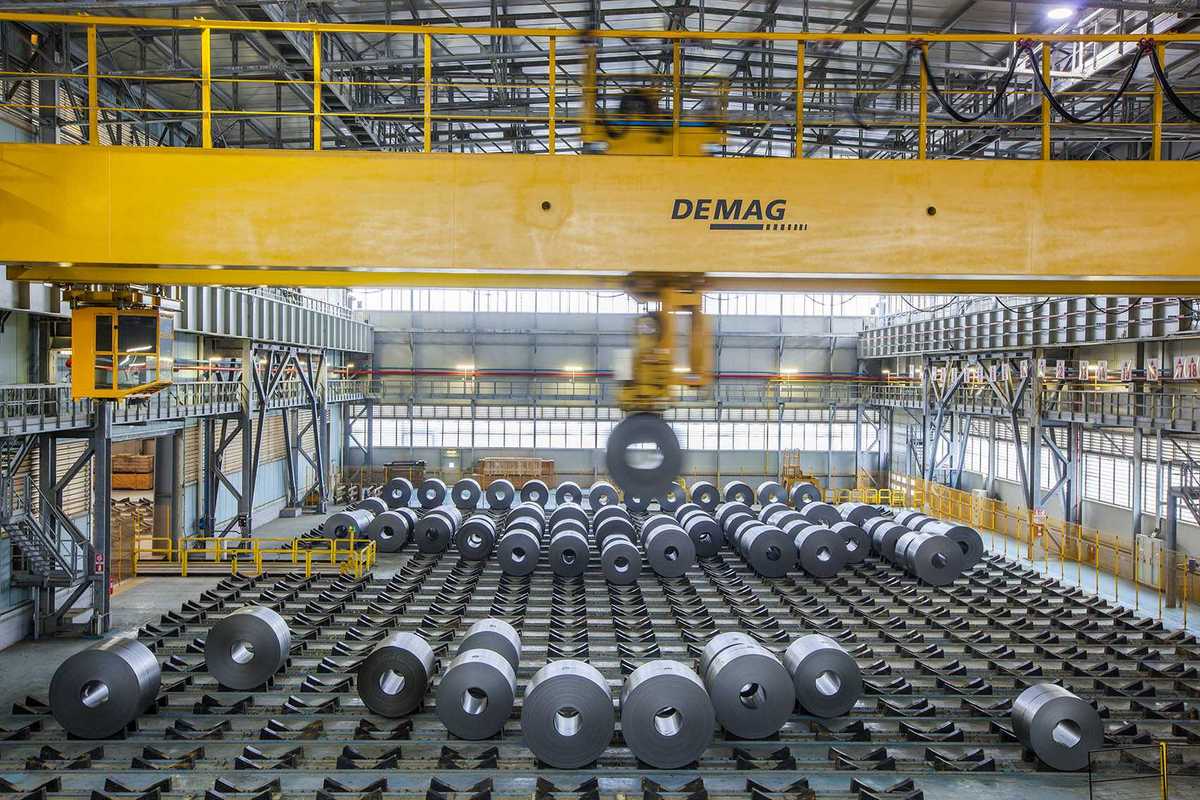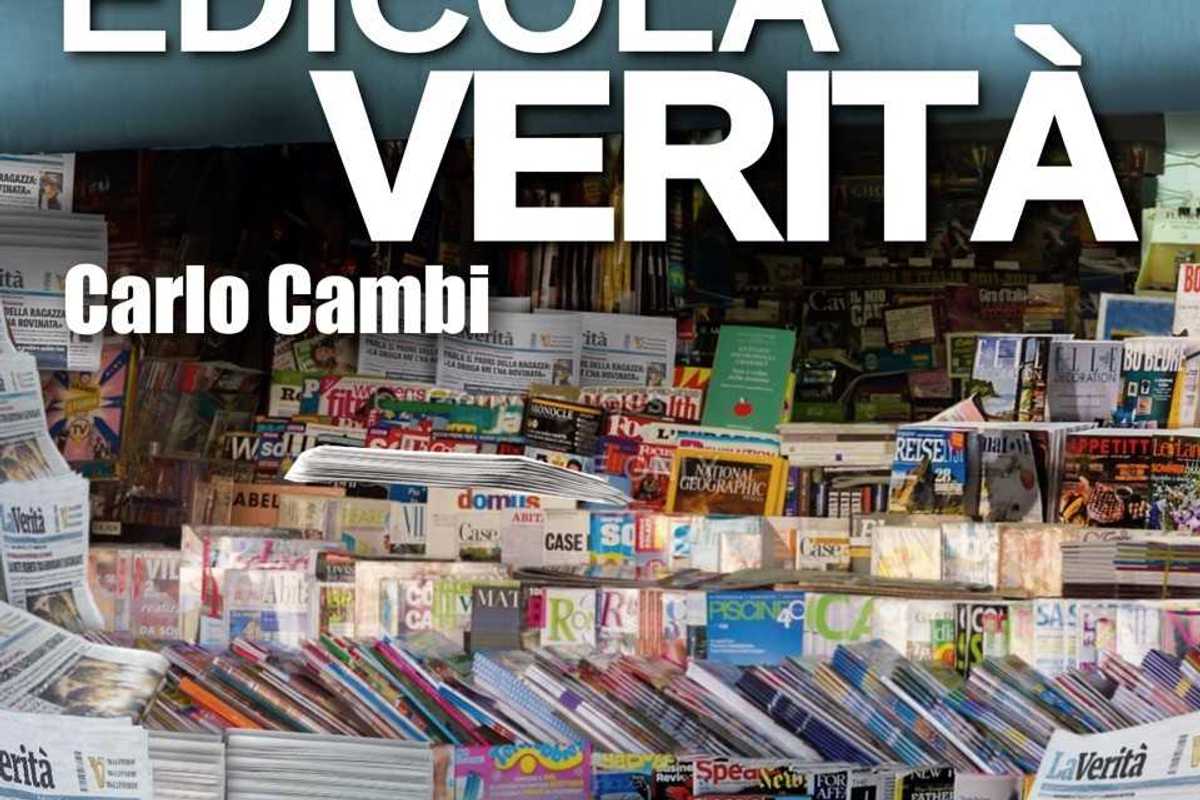Pasta tricolore. Ecco quello che ancora non sapete sul piatto simbolo dell’Italia

Spaghetti al pomodoro: esiste un italiano che non li abbia mangiati almeno una volta in vita sua, un ristorante tipico italiano che non li serva, da carta o su richiesta, una cucina domestica che non li abbia mai ospitati? No. Se dobbiamo indicare il piatto italiano più basico, un piatto «iconico» come si usa dire, non ce n'è uno migliore di questo. Non lo è nemmeno la pizza. E non è più emblematico dell'italianità perché lo è allo stesso modo: a ben guardare, la pizza margherita è una versione in forma di pane - anziché di pasta - degli spaghetti al pomodoro, con la mozzarella al posto del parmigiano grattugiato. Gli spaghetti al pomodoro sono, quindi, a tutti gli effetti, un piatto identitario che ha molte altre peculiarità positive. Caratteristiche di salubrità intrinseca che, però, la continua messa in discussione della tradizione da parte di quel progressismo che detesta tutto ciò che è identitario rischia di farci dimenticare, presentandoci come più affascinante e magari salutare il cibo non italiano. Per «sovranismo alimentare» non si deve intendere il murarsi vivi nella propria tradizione, ma considerarla regola e il resto eccezione. Dunque, mangiamo pure il sushi, concediamoci un poké, «masticabeviamo» una ciotola di ramen, proviamo la pasta di legumi (che di pasta ha quasi soltanto l'aspetto), ma non rimuoviamo dalla nostra quotidianità la pasta e ricordiamo i motivi per cui ci fa bene.
Il piatto di spaghetti al pomodoro è, innanzitutto, un pasto completo. Recentemente, si sono molto diffuse le diete low carb o addirittura no carb che, rispettivamente, riducono drasticamente o eliminano del tutto i carboidrati. La credenza che la pasta ingrassi in quanto tale è sempre più diffusa e questo contribuisce a mettere in discussione la dieta mediterranea in toto, con la sua classica strutturazione in primo piatto glucidico e secondo piatto proteico. In realtà, ciò che fa ingrassare non sono i carboidrati in sé, se assunti con buonsenso, ma le complessive calorie in eccesso. Secondo i nuovi Larn (Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia) della dieta equilibrata elaborati nel 2014 dalla Società italiana di nutrizione umana, dobbiamo trarre il 45-60% delle calorie giornaliere totali dai glucidi, a loro volta suddivisi in un quarto di zuccheri e tre quarti di carboidrati complessi (oltre a fibra per 30-35 grammi al giorno). Qual è la differenza? I carboidrati semplici sono detti anche «zuccheri» e hanno una struttura formata da 1 o 2 unità base. Sono il glucosio (base di quasi tutti gli altri carboidrati), il fruttosio presente nella frutta, il lattosio (formato da un'unità di glucosio e una di galattosio) presente nel latte, il saccarosio formato da un'unità di glucosio e una di fruttosio (è lo zucchero da cucina estratto da canna o barbabietola) e hanno un indice glicemico più alto di quelli complessi. I carboidrati complessi sono formati da decine o centinaia di unità base connesse. Sono l'amido, composto da catene di glucosio e presente in cereali, legumi e tuberi, il glicogeno cioè catene di glucosio presenti nei tessuti muscolari animali, la fibra ossia catene di zuccheri ramificati con altre sostanze, che troviamo nei cereali integrali, nella frutta e nella verdura. I carboidrati della pasta, ricordiamocelo, sono complessi. Il nostro organismo li digerisce recidendo le catene che li costituiscono e liberando man mano le unità di glucosio, che vengono poi assorbite ed entrano nel circolo sanguigno (un passaggio misurato dal valore della glicemia). Poiché la digestione dei carboidrati complessi è più lenta e impegnativa di quelli semplici, questi presentano un indice glicemico più basso, cioè un minore innalzamento della glicemia (quello della pasta è tra 36 e 51) rispetto a quello indotto dalla digestione dei carboidrati semplici, e determinano una sazietà più prolungata. Il glucosio presente nel sangue viene gradualmente passato ai tessuti che, con questo, producono energia (i tessuti nervosi, per esempio, non sono capaci di sfruttare i grassi). Il glucosio in eccesso passa al fegato dove viene riassemblato come riserva (è il glicogeno). Il glucosio è un'importante fonte energetica, l'unica utilizzabile dal cervello: per questo, i carboidrati rappresentano il 45-60% del fabbisogno calorico giornaliero a fronte delle percentuali ben più basse di proteine (indicate in 15-20%) e di grassi (25-30%). Non criminalizziamo, quindi, i carboidrati ma assumiamoli secondo l'equilibrio delle linee guida e ricordiamoci che i cibi ad alto indice glicemico non causano una preoccupante iperglicemia, se assunti in minime quantità come, per esempio, un cucchiaino di zucchero. Altrettanto accade agli alimenti ad indice glicemico medio e basso, come la pasta: l'indice glicemico non viene alzato in modo eccessivo con una modica quantità (ovviamente, se mangio un chilo di pasta travalico nell'iperglicemia). Nonostante si continui a spiegare quanto l'assunzione di carboidrati sia indispensabile, di recente in molti si è radicata una vera e propria «carbofobia», che non va bene perché se si eliminano del tutto i carboidrati si rischia la chetosi, che può creare grossi problemi a fegato e reni. Con un apporto calorico basato solo sulle proteine, poi, aumentano i rischi cardiovascolari e tumorali e si incorre anche nella stitichezza per l'assenza di fibre. Dall'altra parte, c'è chi non ha eliminato tutti i carboidrati ma ha sviluppato solo una «pastafobia», per cui i noti spaghetti al pomodoro e i loro simili diventano tabù mentre i cereali di altre identità culinarie, dal riso al couscous, vengono percepiti come più dietetici. In realtà, l'indice glicemico del riso, per esempio, è di ben 100 e se è vero che, a parità di peso secco, il riso in cottura assorbe più acqua della pasta dando luogo a un piatto finale più abbondante, è anche vero che l'amido del riso è composto da particelle più piccole rispetto all'amido del grano duro della pasta e questo determina una digestione del riso in metà tempo rispetto alla pasta. Più «leggero», quindi, da un certo punto di vista, ma riaffama prima. La pasta, invece, demonizzata e ripudiata, presenta un indice glicemico più basso anche del pane bianco (pari a 72) o delle banane, che lo hanno di 62.
Ma quale è la porzione perfetta in base alle calorie? Una premessa. Solitamente ragioniamo sulle calorie dei cibi crudi ma la cottura può togliere acqua, aumentando le calorie, oppure aggiungerne, diminuendole. Lo stesso peso è diverso se calcolato con o senza acqua. Per esempio, 100 grammi di fagioli freschi hanno 105 calorie, ma 100 grammi di fagioli secchi ne hanno 289. E così, 100 grammi di pasta cruda forniscono 350 calorie, ma bollendola aggiungeremo acqua (che non ha calorie ma peso): 100 grammi di pasta cruda diventano circa 250 grammi bollita. Quindi, un etto finale di pasta bollita apporterà 140 calorie. Essendo il dato di partenza che a 100 grammi di pasta cruda corrispondono 350 calorie, i 100 grammi di pasta bollita che apporteranno 140 calorie sono appena 40 grammi di pasta cruda. Quante calorie ha un piatto di spaghetti al pomodoro? Gli 80 grammi canonici di un piatto di pasta apportano 280 calorie mentre 100 grammi di salsa di pomodoro ne hanno circa 29. Poi, abbiamo un cucchiaio di olio extravergine di oliva (circa 90 calorie) e un cucchiaio di parmigiano grattugiato (circa 43) mentre il basilico, ed eventualmente aglio o cipolla, nella salsa apportano calorie talmente minime che non le contiamo. In totale, abbiamo 442 calorie che poi è il fabbisogno calorico di un pranzo o di una cena in un regime calorico di 1.200 calorie giornaliere. Per questo, abbiamo definito il piatto di spaghetti al pomodoro un pasto completo. E se volete diminuire l'apporto calorico, basta cuocere meno pasta: non è necessario rinunciarvi. La porzione classica, lo ribadiamo, è di 80 grammi di pasta cruda a persona, mentre quella dei ristoranti gourmet è di circa 40 grammi. Perfino la dieta a zona all'italiana prevede la pasta, considerando gli 80 grammi di una porzione indicata ma come pasta cotta, quindi sono solo 20 grammi di pasta cruda.
Ci sono altri benefici nel piatto di spaghetti al pomodoro? In questi tempi, nei quali si eleggono continuamente comfort food, attribuendo a qualsiasi pietanza - preferibilmente non italiana - la caratteristica di confortare, ricordiamoci che la pasta al pomodoro per un italiano su due è il cibo della memoria. Secondo una ricerca realizzata da Doxa per Aidepi (l'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) su un campione di mille italiani dai 15 anni in su, un italiano su due ricorda proprio la pasta al pomodoro come «pasta dell'infanzia». Un incanto emotivo, quindi, che tuttavia deriva da un'alchimia chimica. Il mix di questa ricetta, infatti, ha qualcosa di perfetto. Se i carboidrati complessi della pasta (migliori se utilizziamo quella integrale) ci danno il carburante primario, la salsa al pomodoro rappresenta il condimento elettivo: la cottura aumenta la biodisponibilità del licopene, prezioso antiossidante contenuto nei pomodori, mentre l'olio extravergine di oliva apporta gli acidi grassi essenziali che tengono a bada la glicemia. Infine, il parmigiano aggiunge grassi e proteine ma anche vitamine, fosforo e calcio.
Dopo il mito negativo sul fattore ingrassante della pasta, dobbiamo sfatare quello secondo il quale il primo piatto non va mangiato di sera. Premesso che nessuno ha niente da dire se di sera si va a mangiare una pizza e non si capisce perché per la pasta - che è la stessa cosa con minore indice glicemico - non dovrebbe essere così, assumere pasta di sera è consigliato anche dal mondo scientifico. L'Istituto superiore di sanità ha smontato vari falsi miti dell'alimentazione tra cui questo, spiegando che la convinzione che i carboidrati si debbano escludere dalla dieta o consumare ma non di sera è priva di fondamento. A parte il fatto che la pasta contiene anche proteine (5 grammi di proteine accanto a 25 grammi di carboidrati), mangiare di sera questo cibo a prevalenza glucidica complessa aiuta il rilassamento, contrasta la sindrome premestruale e la dismenorrea grazie al triptofano, al magnesio e alle vitamine del gruppo B. Gli spaghetti al pomodoro fanno bene anche al cuore: un consumo di 80 grammi di cereali integrali al giorno riduce il rischio di infarto del 21%.
Colpiscono, quindi, i dati emersi in occasione del World Pasta Day appena celebrato (si festeggia il 25 ottobre dal 1995, anno nel quale fu inaugurato come appuntamento del World Pasta Congress). Ebbene, abbiamo appreso che negli ultimi dieci anni il consumo di spaghetti e, in generale, di pasta nel mondo è quasi raddoppiato, passando da circa 9 a 15 milioni di tonnellate annue consumate. Di queste, 23 chili annui pro-capite sono mangiati da noi italiani (precediamo la Tunisia con 16 chili, il Venezuela con 12 e la Grecia con 11,2). Dall'altra parte, però, proprio l'Italia, patria assoluta della pasta con la sua dieta mediterranea, si sta pian piano distaccando dal modello alimentare mediterraneo: la propaganda globalista fa effetto e snatura anche l'alimentazione. Solo il 41% della popolazione del Nord Italia si nutre seguendo il modello mediterraneo, addirittura nel Centro lo segue solo il 16,8%. E pensare che proprio in Un americano a Roma Alberto Sordi ha cristallizzato per l'eternità un elogio dei famosi maccheroni, altro nome degli spaghetti e dei bucatini, che lo «provocavano» e lui se li «magnava». Ma poi torniamo al 42,1% di seguaci della dieta mediterranea nel Sud del paese. Se la nostra tradizione fosse intonsa, i risultati di questo sondaggio (fonte: European Journal of Public Health) dovrebbero essere 100, 100 e 100. Perciò, la nostra riflessione sugli spaghetti al pomodoro riguarda anche aspetti di sovranismo alimentare. In un'epoca nella quale la tradizione alimentare viene presa continuamente a picconate da un'ideologia politica che poi si fa politica economica (nazionale come europea) e prassi, ribadire che si dà priorità alla propria identità e si considera il resto un'eccezione diventa una forma di resistenza contro l'estinzione.