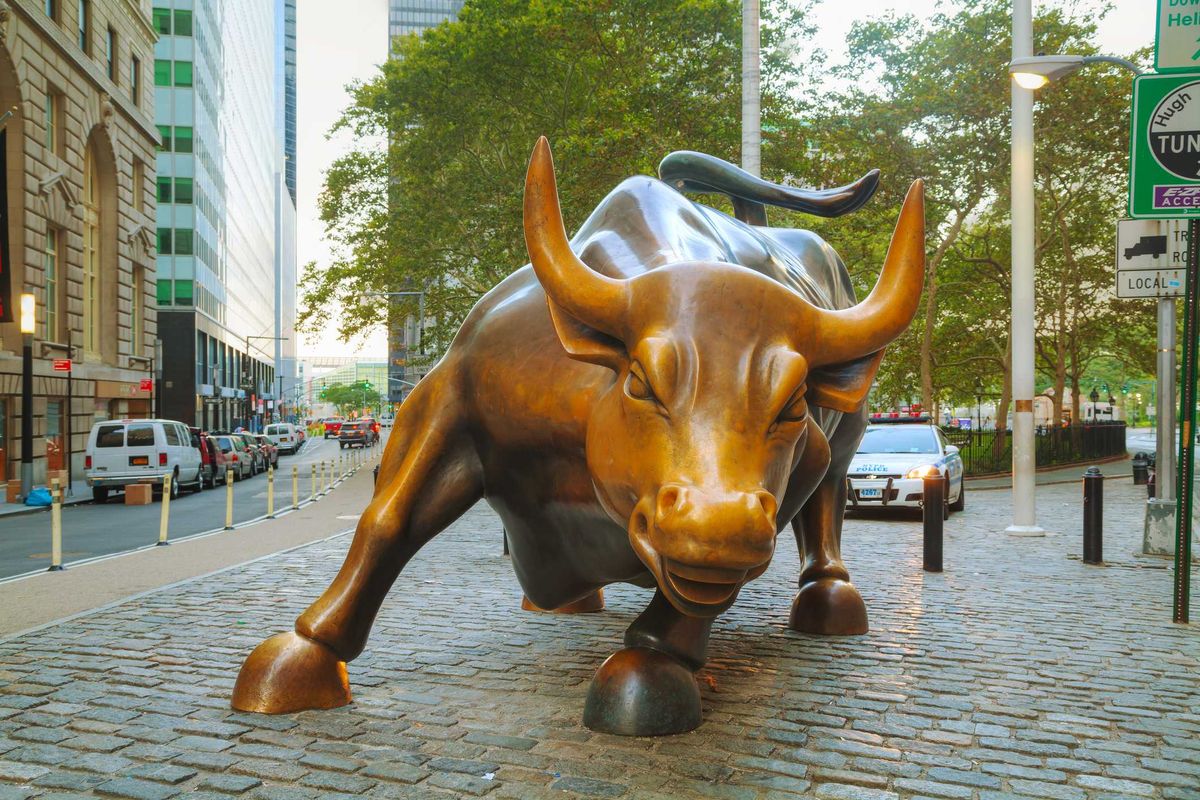2021-10-01
Il pass ferma un camion su tre: «A rischio cibo, benzina, aziende»
Alessandro Laghezza, presidente Confetra Liguria (Getty Images)
Alessandro Laghezza, presidente di Confetra Liguria: «Dal 15 ottobre, con il certificato obbligatorio, un autotrasportatore su tre mancherà all'appello. Gente soprattutto dell'Est Europa. Lunghe soste di merci in banchina e costi più alti».Il settore dei trasporti su gomma in Italia era già al collasso prima della pandemia. Ora ci si è messo pure il green pass a peggiorare la situazione. Secondo le stime citate da Alessandro Laghezza, presidente di Confetra Liguria, dal 15 ottobre l'obbligo della certificazione verde farà stare a casa almeno un altro 15% di camionisti, numero che si somma al 20% di personale che già manca. In poche parole, dal 15 ottobre prossimo un terzo dei lavoratori degli autotrasporti mancherà all'appello.Quali sono le norme green pass per gli autotrasportatori?«Gli autisti sono lavoratori come gli altri e, dal 15 ottobre, devono essere provvisti di green pass per poter lavorare». Anche se viaggiano da soli, dunque?«Assolutamente, perché devono entrare in contatto con altre persone durante le fasi di carico e scarico. Hanno contatti con il mondo esterno, soprattutto di natura documentale». L'obbligo vale sia per i dipendenti che per i padroncini?«Non c'è distinzione, tutti i tipi di autotrasportatori, assunti o lavoratori autonomi, devono avere la certificazione verde». Fatte queste premesse, quindi, qual è la situazione italiana del trasporto su gomma?«La situazione, già prima dell'obbligo del green pass, è già molto difficile. Ad oggi, oltre al problema di trasporto marittimo, si fa fatica a smaltire la merce quando arriva nei porti e ad alimentare i porti per i prodotti in partenza. La domanda di trasporto, insomma, supera l'offerta. Per fornire qualche numero posso dire che un container oggi sta sulle banchine almeno 4 o 5 giorni nei porti. Questo si traduce, senza l'obbligo del green pass, in una carenza di circa 20.000 autisti per l'Italia. C'è anche un problema di mezzi. In Italia c'è un mercato frazionato e molte aziende per andare avanti si sono trovate ad accontentarsi del prezzo di costo o quasi o anche inferiore ai costi. Così in moltissimi hanno chiuso e quasi nessuno ha fatto investimenti in nuovi mezzi. Io posso dire che, a livello di mezzi, ci sono aziende che hanno almeno il 20% della flotta ferma per mancanza di personale. Il problema è che con l'introduzione del green pass questo dato sarà anche peggiore. Noi pensiamo che un'altra componente significativa di austisti verrà meno e così arriveremo a una mancanza di personale intorno al 35%. Aggiungo che il posto da autista a oggi fa gola in Romania e più in generale nell'Europa dell'Est, Paesi dove spesso c'è un'alta componente di persone che non sono a favore della vaccinazione. Aggiungo, inoltre, che quello degli autotrasportatori non è un mestiere nemmeno molto adatto per il tampone. Non è certo facile andare ogni due giorni in farmacia quando si guida un camion». Quale è il motivo di questa carenza?«Il primo problema è che il settore per gli italiani non è interessante. Un ragazzo italiano difficilmente va a guidare un camion: innanzitutto perché c'è un costo da sostenere di circa 8-9.000 euro e almeno un anno di formazione, senza considerare che la retribuzione è spesso bassa e la qualità della vita non eccelsa. Inoltre, la congestione delle infrastrutture fa sì che gli autisti debbano passare molte ore al giorno sul camion correndo anche rischi importanti durante l'attività. L'unico bacino, quindi, interessato a lavorare sul territorio italiano è quindi quello delle persone dell'Est europeo. Però anche loro spesso stanno scegliendo di lavorare altrove come in Germania dove gli stipendi sono decisamente più alti». Di che stipendi si parla? «Lo stipendio base di un autotrasportatore oggi è di 1.750 euro netti a fronte di una qualità di vita non particolarmente buona. Nella realtà, poi, tra indennità e accordi sindacali la retribuzione reale è intorno ai 2.500 euro al mese. Per queste cifre c'è anche chi preferisce affidarsi al settore del trasporto locale per Amazon o l'e-commerce in generale, dove si guida un furgone e i rischi e le responsabilità sono minori».Quali sono dunque gli effetti di questa carenza?«Ci sarà sicuramente un aumento degli stipendi per attrarre tutti coloro che oggi non sono più interessati a fare gli autotrasportatori o lo fanno in altri Paesi europei. Questi aumenti si riverseranno sulle tariffe per trasportare la merce. Noi stimiamo un aumento delle tariffe di almeno il 20%». Cosa si potrebbe fare per arginare il problema?«Il governo dovrebbe intervenire per semplificare il più possibile l'accesso alla professione e, soprattutto, ridurre i tempi per diventare autista. Quello è un tema essenziale. Abbiamo bisogno di giovane forza lavoro il prima possibile. Inoltre, se le istituzioni pensassero a degli incentivi le tariffe potrebbero essere più basse e il numero di autisti potrebbe salire». Oltra ai problemi di costi maggiori per l'industria, dal 15 ottobre quali potrebbero essere i problemi per le merci che devono arrivare sugli scaffali?«Rallentamenti ulteriori delle consegne e altri costi che gravano sulla merce che deve sostare ancora più a lungo sulle banchine. I consumatori dovranno abituarsi a non trovare tutto e subito al supermercato e le aziende avranno problemi per la componentistica». In tutto questo, quindi, quanto c'entra il Covid? «Nel caso del trasporto per via mare si è creato un oligopolio che ha comportato un rallentamento dei servizi e un aumento delle tariffe di trasporto, quindi il Covid ha avuto un effetto. Per il trasporto su gomma si tratta di una crisi che va avanti da 20 anni e dove non si è quasi mai investito, così il settore non si è fatto trovare pronto al boom dei trasporti. Oggi, invece, si scopre che il settore è strategico e per questo è il caso che le istituzioni facciano qualcosa per risolvere la situazione. Si potrebbero ridurre, ad esempio, i costi delle licenze».