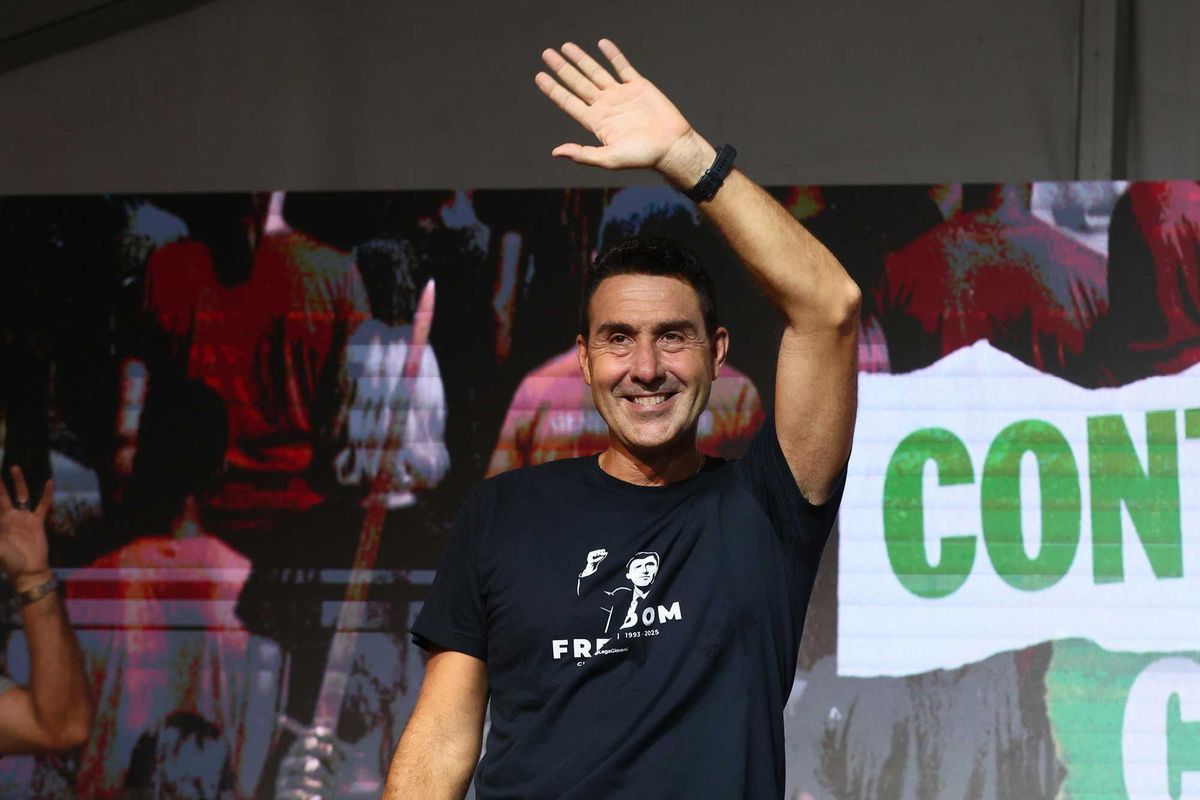Nasce un blocco di 15 Paesi europei contro i deliri green della sinistra
«Non cerchiamo alibi nelle regole europee, perché il tema è se e in che misura la nostra industria sarà capace di guardare al futuro con il sostegno dei governi [...] Siamo indietro sulla componente elettrica e anche su quella digitale. Le auto cinesi hanno una competitività maggiore e questo non dipende dalle regole ma dalla capacità di fare investimenti». Le ultime dichiarazioni di Paolo Gentiloni, ormai ex commissario Ue all’Economia, dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che ai piani alti di Bruxelles hanno capito poco o nulla di quanto successo nell’ultima legislatura. La crisi epocale che sta mandano sottosopra tutti i colossi dell’automotive occidentale parte dalle direttive che hanno imposto di produrre e-car a un prezzo insostenibile per il consumatore medio dell’Unione. E se non si evidenza che la concorrenza sleale (differenza di costo del lavoro, assenza di limiti ambientali e sussidi di Stato a pioggia) della Cina ha fatto da detonatore alla crisi, non si coglie il problema ed è quindi difficile anche trovare le soluzioni. Senza dimenticare che la strategia di Palazzo Berlaymont ha raggiunto l’apice del masochismo nel momento in cui ci ha resi ricattabili da Pechino che vanta la maggior parte delle materie prime necessarie alla transizione green. Un capolavoro.
Il problema non è tanto che queste parole vengano da Gentiloni, che rappresenta ormai il passato di Bruxelles, quanto che potrebbero tranquillamente sovrapporsi al pensiero di Teresa Ribera, la nuova responsabile per la Transizione dell’Europa. La spagnola, al centro di ferocissime polemiche in patria per la tragedia di Valencia, che solo qualche ora fa, giusto per evitare fraintendimenti, ci ha tenuto a sottolineare che l’obiettivo di dire basta alle auto a combustione dal 2035 non è minimamente in discussione.
Il punto è che gli equilibri in Europa sono cambiati. E che se la Commissione guarda alla svolta ambientalista con i paraocchi, tra i singoli partiti del Europarlamento e tra i vari Stati del Consiglio le visioni sono più composite e configurano una contrapposizione incendiaria.
La spaccatura tra i due mondi, quello dei Timmermans e delle Ribera, che vogliono mantenere una visione ideologica rispetto alla transizione verde, e quello più pragmatica dei conservatori e dei popolari che sta man mano drenando consensi è stata resa in modo plastico dall’ultimo report che il Ppe ha recapitato a Bruxelles.
Un documento che chiede di cambiare completamente il passo della transizione energetica. Non più strappi ma una riconversione graduale e progressiva. Che dovrebbe partire dal non considerare più come un dogma lo stop del 2035 per poi iniettare una dose massiccia di flessibilità nel Green deal. Iniziando dall’immediato revisione dei limiti alle emissioni di CO2 previsti per il 2025. In sostanza, eliminare il meccanismo delle multe che potrebbero dare il colpo di grazia (le stime parlano di sanzioni da 15 miliardi) al settore. Così come si chiede di anticipare il check sulle regole «ecologiche» previsto nel 2026. Non solo. I popolari mettono sul piatto la necessità di valorizzare il ruolo dei carburanti alternativi, come e-fuel, biocarburanti e carburanti rinnovabili o sintetici e di puntare in modo deciso sui veicoli ibridi plug-in (Phev), che sembrano oggi avere più mercato.
Il Ppe, insomma, pretende una svolta. E riprende praticamente in toto un documento (non paper) sottoposto all’Europa dall’Italia. Documento che sta facendo proseliti. Al 28 novembre sono otto i Paesi che hanno firmato il il piano che vuol riportare il Green deal alla realtà. Tra i sottoscrittori ci sono, oltre all’Italia, Repubblica Ceca, Austria, Malta, Polonia, Romania, Bulgaria e Slovacchia. A questi poi si potrebbero aggiungere a breve altri sette Stati che non hanno firmato, ma sono molto vicini a farlo: Estonia, Cipro, Croazia, Grecia, Slovenia, Belgio e Lettonia. Basta? Se si sommano le popolazioni dei singoli Paesi favorevoli c’è la maggioranza degli abitanti dell’Ue, ma il problema è che restano fuori alcuni dei colossi del sistema.
La partita, del resto, è tutta da giocare. Se infatti è vero che Danimarca, Spagna, Svezia e Irlanda sono espressamente contrari al documento italiano che per osmosi si lega a quello del Ppe, è altrettanto vero che gli altri Stati possono essere considerati contendibili. Nell’ultimo elenco ci sono oltre a Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Lituania e Ungheria, anche Germania e Francia. Non sfugge a nessuno che fare previsioni su due governi che vivono una delle situazioni più precarie della loro storia diventa assai complicato.
Ma a quanto risulta, proprio Parigi sarebbe molto tentata dalla direzione pragmatica imposta da Roma e popolari. E pensare a una Francia post Macron che si mette al fianco dell’Italia nella svolta verso un’Europa post ideologica, rende lo scenario ancora più interessante.
Del resto, che il dossier auto green possa davvero traumatizzare l’Ue l’ha capito pure la Von der Leyen che infatti si è intestata la partita e si è detta pronta a vincerla nei primi 100 giorni del suo secondo mandato.
Tre mesi per cambiare Bruxelles. Sarebbe un miracolo. Ma prima di riporre eccessive speranze nella riuscita del progetto c’è da chiedersi se Ursula ne abbia parlato con Teresa, il braccio destro spagnolo che lei a difeso fino in fondo e che a più d’uno sembra peggio di Timmermans. Auguri.