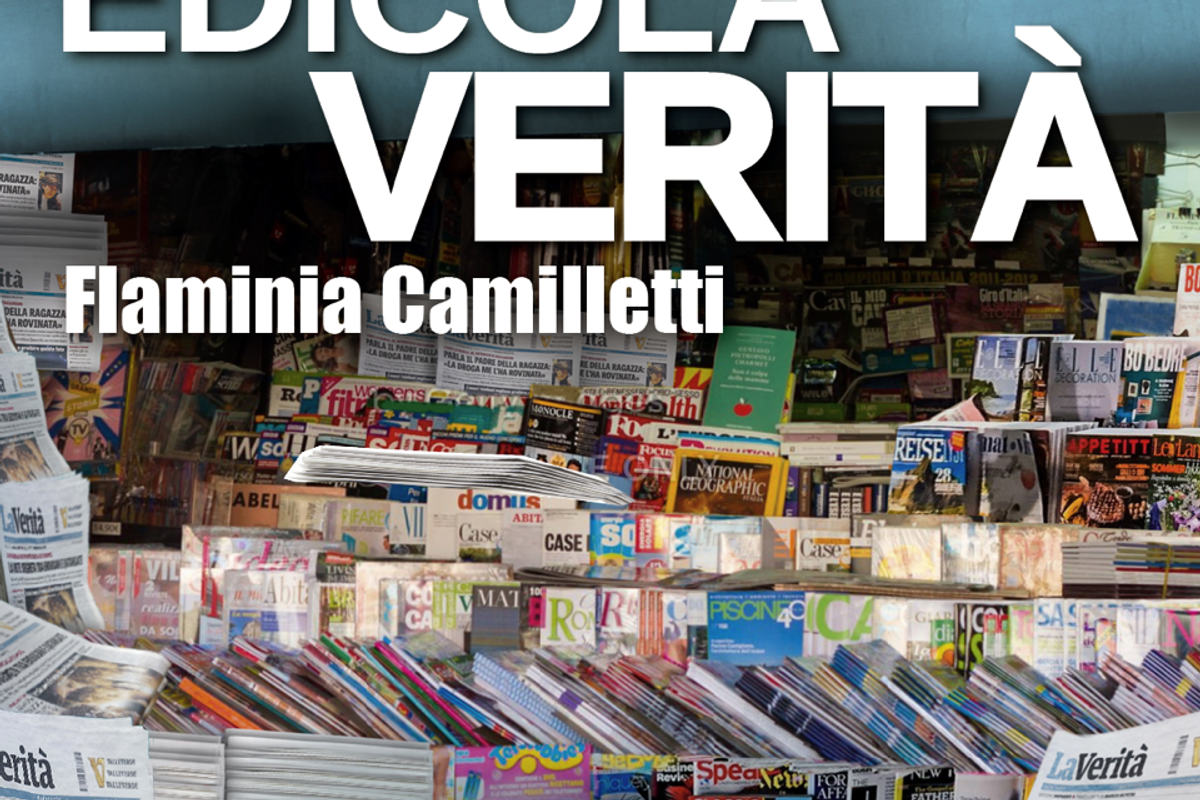2025-05-09
L’Unione di pace di Ursula più disunita che mai
Antonio Costa, Roberta Metsola e Ursula von der Leyen (Ansa)
Ursula von der Leyen e Antonio Costa spacciano il riarmo per un’iniziativa gandhiana. Nascondendo un gigantesco problema politico: gli Stati devono accettare alla cieca piani militari sconosciuti, finanziati con nuovo debito e a tutto vantaggio dell’industria franco-tedesca.Ottant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Ursula von der Leyen celebra la data con il più classico dei trasformismi lessicali. Trasforma il progetto (i fantomatici 800 miliardi) Rearm Ue, già soprannominato Prontezza 2030, in Piano per la pace. «Ottanta anni fa, i nemici hanno deposto le armi. Da allora, noi europei abbiamo costruito qualcosa di straordinario: un’Unione di pace, democrazia e solidarietà. Un’ancora di stabilità. La nostra Unione è nata come progetto di pace e continua a esserlo anche oggi», ha scritto sui social il presidente della Commissione lasciando la spiegazione al collega del Consiglio europeo, Antonio Costa. Il quale partecipando a un evento in Italia ha spiegato che la pace si costruisce con scelte coraggiose anche in termini di riarmo. «I padri fondatori dell’Unione europea e coloro che sono venuti dopo di loro», ha sentenziato, «hanno dimostrato che senza una forte volontà politica, senza azioni concrete, che tocchino le persone, che costruiscano la pace dal basso e ai massimi livelli, la filosofia può essere solo un modo comodo di parlare di pace. Dobbiamo mettere in pratica le idee». Attenzione, però. Qui, a proposito di significanti lessicali, siamo molto lontani dal Si vis pacem para bellum. Qui siamo di fronte a un meccanismo politico e non geopolitico. La Commissione in primis e un bella quota di Consiglio hanno intenzione di creare un meccanismo finanziario che consenta (quasi sicuramente facendo gli stessi errori della transizione green) di rilanciare l’economia di alcuni Paesi. Di aiutare Francia e Germania e favorire le loro industrie. C’è la necessità di convertire l’automotive che è stato pesantemente deindustrializzato proprio dalle norme partorite da Bruxelles. Quindi la coazione a ripetere porta alla spinta verso un debito comune che possa sostenere le idee di Bruxelles indipendentemente dai progetti concreti. I famosi 800 miliardi non esistono. Sarebbero mero debito. Che i singoli Paesi dovrebbero mettere sul tavolo prima di sapere quale strada intraprenderebbero. Quali velivoli vuole sviluppare l’Europa? Come e con che aziende vuole far crescere la Marina? Stesso discorso per i satelliti, mentre sulla cyber security c’è il buio totale. Per l’Italia aderire senza conoscere i dettagli significa accettare il concreto rischio di vedere il Pil prodotto dall’industria militare svanire in pochi anni. E già negli ultimi 20 anni abbiamo perso pezzi importanti di tecnologia. Non è - il nostro - un ragionamento astratto. Basta prendere le dichiarazioni di Emmanuel Macron e di Friedrich Merz di mercoledì. Senza contare il fatto che anche il viaggio del Cancelliere tedesco in Polonia ha chiarito l’intento: asse a tre e forse a quattro. Dove il quarto Paese sarebbe la Gran Bretagna. Sempre ieri fonti diplomatiche Ue coinvolte nella preparazione delle decisioni del Consiglio e dei capi di Stato e di governo della Ue, rispondendo alla domanda se fossero state discusse le proposte avanzate da Spagna e Italia hanno risposto con un secco «no». Il riferimento è al budget del fondo Safe da 150 miliardi che è un tassello del più ampio piano di riarmo. Il governo italiano ha proposto un sistema di garanzie Ue per il finanziamento di progetti per difesa e sicurezza. Madrid propone di creare un nuovo fondo europeo per la difesa finanziato dagli asset della Banca centrale russa congelati dalle sanzioni e detenuti nella Ue. Al di là del merito (l’idea spagnola come più volte ha scritto La Verità è tecnicamente inapplicabile) l’esclusione è un fatto formale che apre la questione di fondo di tutto questo discorso. Le parole della Von der Leyen nel ricordare gli ottant’anni della fine della guerra appaiono come vuote. L’Europa ancora una volta dimostra di non aver creato stabilità e tanto meno fiducia tra gli Stati. Quelli che sono più afflitti dai problemi dell’immigrazione non hanno alcuna forma di solidarietà da Bruxelles e dal blocco del Nord. Quando c’è stata la crisi dei debiti sovrani è stato coniato il termine Pigs (a indicare gli Stati del Sud) quasi a sfregio visto il richiamo al termine «maiali». Tant’è che qualcuno si è dovuto arrangiare (Italia) e qualcun altro è stato bastonato (Grecia), altro che debito comune per un sostegno reciproco. Per carità i motivi sono numerosi e in buona parte hanno radici storiche. Ma tutti percepiscono l’assenza di unità e il tentativo di un blocco di prevalere sull’altro. Usando la clava di Bruxelles che continua a professarsi come parte terza. Guarda caso sempre ieri le solite fonti dell’Eurogruppo (previsto per lunedì) hanno fatto sapere che si aspettano chiarimenti da parte del ministro Giancarlo Giorgetti sulla mancata adesione dell’Italia al Mes. L’urgenza adesso non è più sanitaria e nemmeno bellicista, ma rientra nel pericolo dazi. Che starebbero, usando il termine delle fonti dell’Eurogruppo, provocando il dissesto dei commerci. L’Ue alza il tiro e continua a non voler trattare con gli Usa così c’è la nuova scusa per imporre il meccanismo Salva Stati. Se non è coazione a ripetere questa non sappiamo come altro definirla.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 12 settembre con Flaminia Camilletti
Charlie Kirk (Getty Images)