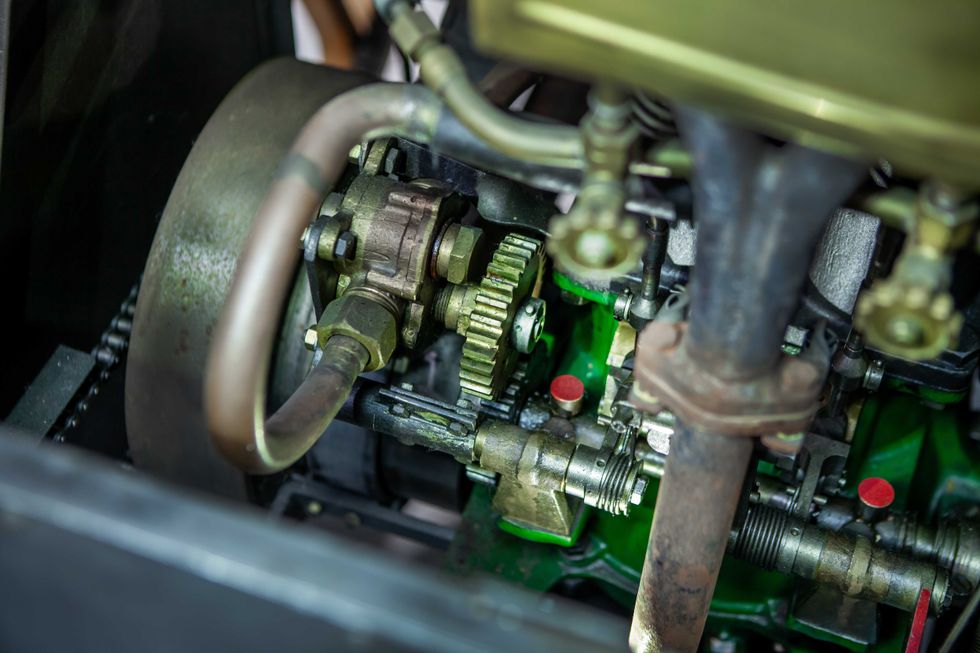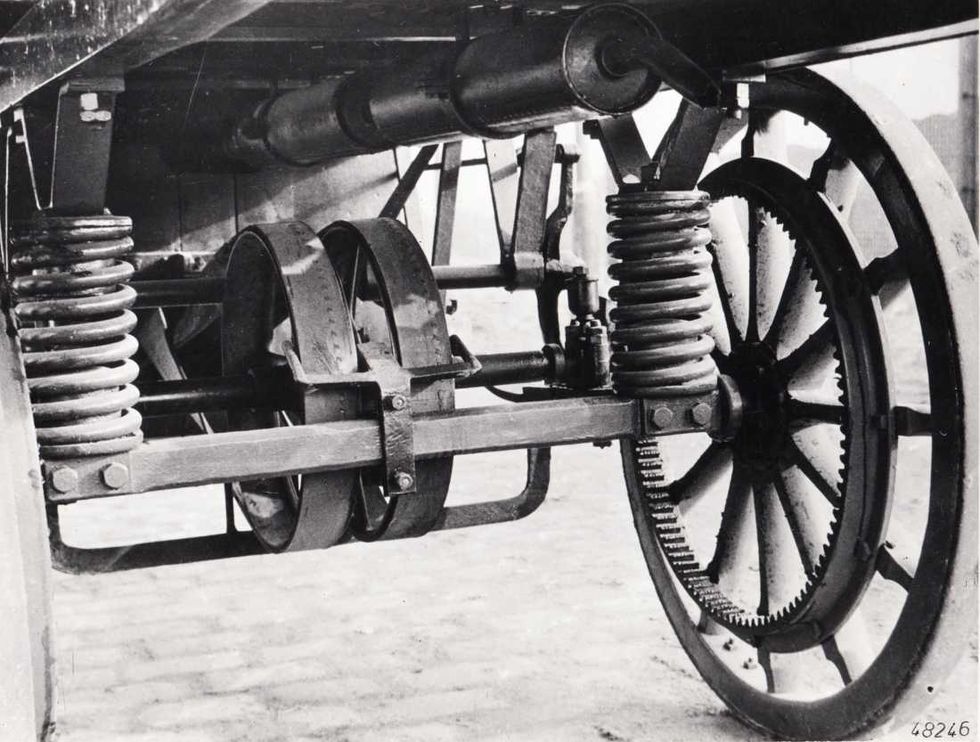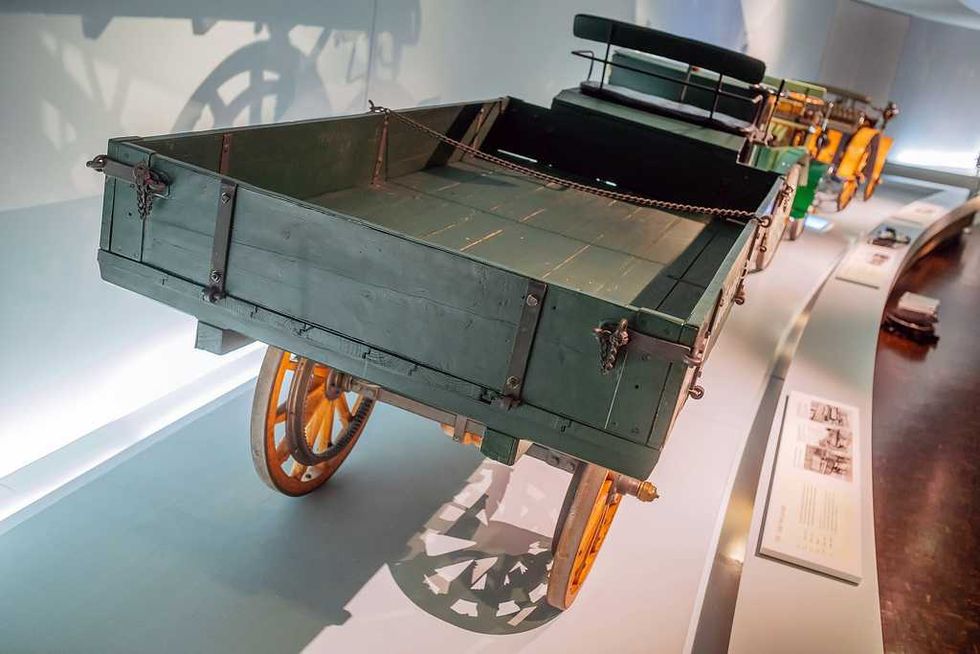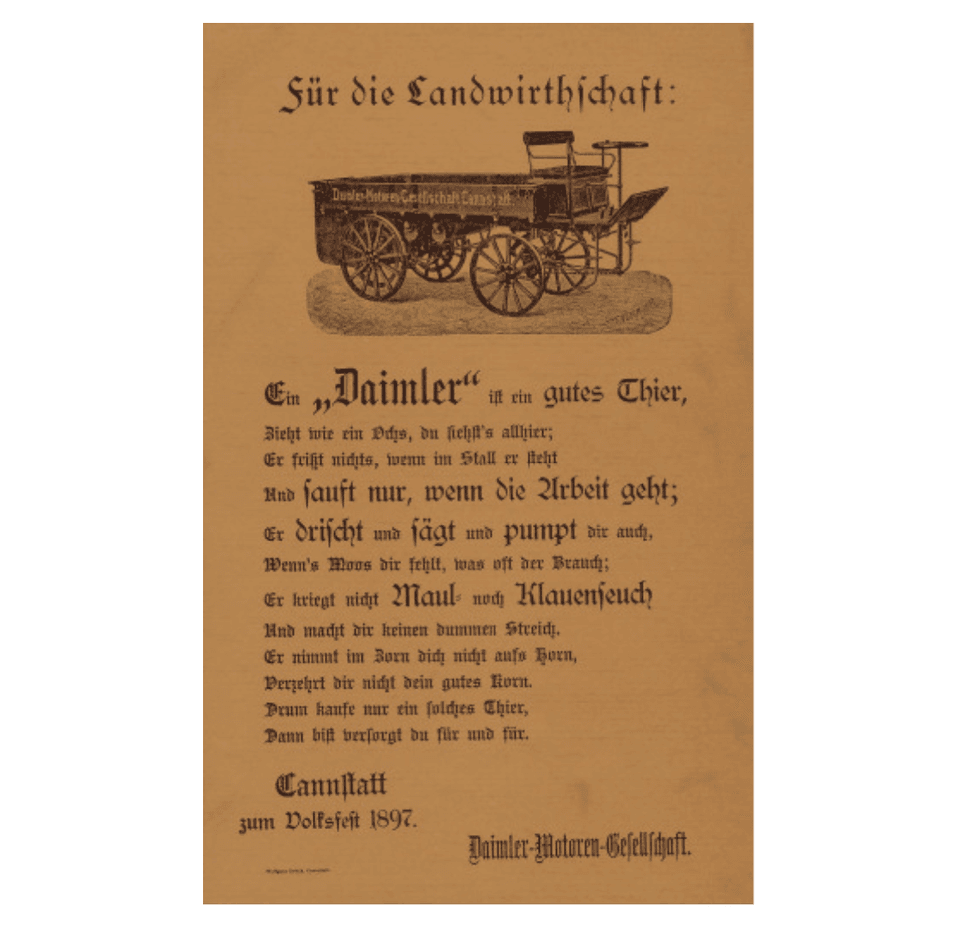«Quando, fra qualche tempo, si comincerà a far la storia della Corte costituzionale italiana, un capitolo molto interessante dovrà essere dedicato alla carriera percorsa dai suoi membri dopo l’uscita dall’ufficio».
Mentre Gianfranco Miglio pronunciava pubblicamente queste parole in un convegno del 1978 a Como, Giuliano Amato aveva 40 anni e, con Giorgio Ruffolo, stava lavorando al «progetto socialista» che gli sarebbe servito a scalare le gerarchie del partito. Il geniale studioso poi diventato simbolo di una stagione leghista ci aveva visto incredibilmente lungo, anche perché l’elenco delle toghe emerite si sarebbe arricchito con capi di Stato, ministri della Giustizia, eterni kingmaker e appunto giulianiamati.
Nel suo intervento (pubblicato in Le regolarità della politica, Giuffré 1988, volume 2), Miglio aveva capito che l’Amato che, oggi, spiega come la Consulta debba essere «contraltare alla maggioranza» non è l’invocazione di una laica terzietà giuridica incardinata al dettato costituzionale rispetto a qualunque potere politico, ma una alterità rispetto a una maggioranza specifica, quella di centrodestra che dovrà sostituire quattro toghe supreme nel corso del 2024.
E quindi Amato, molto semplicemente, vuole una Corte orientata alle sue idee politiche a prescindere dal consenso elettorale, dalla legislatura e dalle regole costituzionali. Esprimendo una concezione dei rapporti tra Consulta e potere politico perfettamente agli antipodi di quella che scriveva Miglio: «È noto a tutti che i meccanismi destinati a garantire l’equilibrio dei poteri entro una data Costituzione sono tanto più efficaci quanto più automatici: cioè quanto meno sono influenzabili dall’uno o dall’altro dei poteri stessi che devono “tenere in briglia”. Non mi sembra che, nell’esercizio delle due prime funzioni indicate dall’articolo 134, la Corte costituzionale italiana abbia mai assunto quel ritmo autonomo ed inesorabile dal quale soltanto potrebbe discendere la sua “temibilità” [...]. Al contrario, infatti, si è instaurata presto l’abitudine di una bonaria fornicazione tra l’esecutivo-legislativo da una parte e la Corte dall’altra, intesa a rendere la seconda consapevole delle difficoltà del primo e, quindi, a regolare la propria attività - nei tempi e nei modi - in maniera da non ostacolare soverchiamente l’azione del governo. Questa cauta collusione si basa evidentemente sul convincimento che l’idea della “divisione” dei poteri dovrebbe essere superata dall’altra , della “collaborazione” fra gli stessi».
Con precisione stupefacente, Miglio addirittura azzeccò proprio l’espressione che sarebbe entrata in voga lustri e lustri dopo: quella «leale collaborazione» che sia Marta Cartabia sia Giuliano Amato avrebbero teorizzato, soprattutto con maggioranze dalle quali provenivano o che avrebbero potuto incaricarli.
Ecco, l’intellettuale comasco riteneva che un «meccanismo veramente garantista» presupponesse «non solo la divisione, ma addirittura l’“antagonismo” dei poteri. Infatti, una volta imboccata la via delle “reciproche comprensioni”, fra controllori e produttori degli atti da controllare, il rigore e la prontezza della verifica della legittimità diventano un pio desiderio». Ma perché avviene questa «bonaria fornicazione»? Miglio rispondeva così: «I costituenti credettero di assicurare l’autonomia e l’imparzialità dei giudici, facendo di ognuno di essi una specie di monaco, avulso dalla professione e dall’ufficio abitualmente esercitati: ma [...] allo scadere del mandato, il giudice che non sia già un vegliardo si trova alle prese con le angustie non solo della perdita di prestigio, ma anche e sopra tutto di un difficile “rientro” nella vita di prima. A tutto ciò i costituenti non pensarono: immaginarono disponibile una stirpe di Cincinnati, pronti al sacrificio anche del proprio “status” sociale e professionale».
Il succo è chiaro: troppo forte la tentazione di ragionare sul «dopo» per esercitare un controllo ferreo sul decisore. Miglio proponeva di risolvere il problema facendo per legge i giudici emeriti senatori a vita dopo il loro mandato. Questo però, forse, è meglio non dirlo ad Amato: è una carica che gli manca.