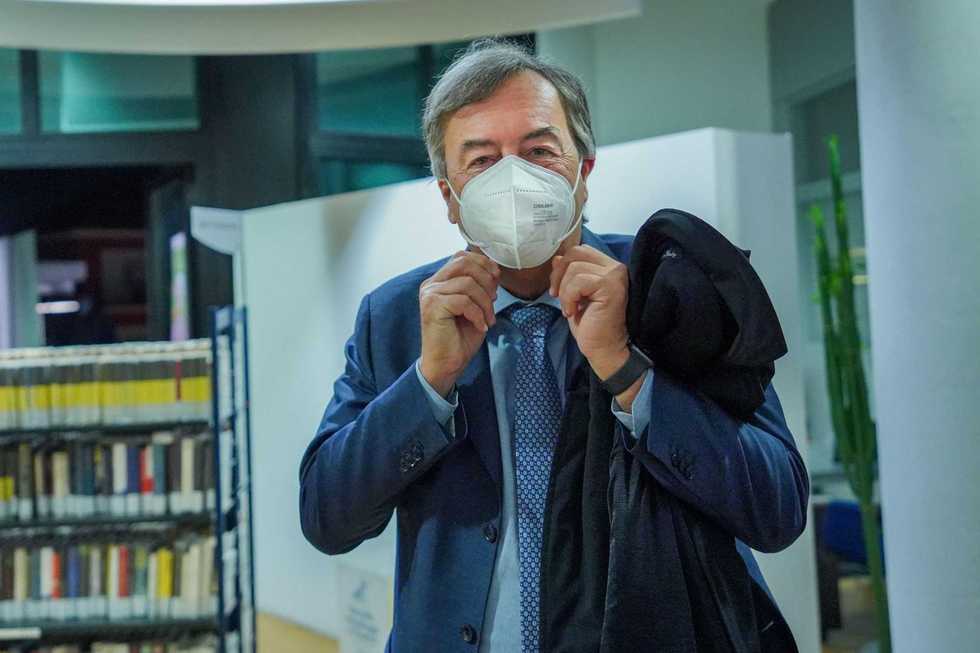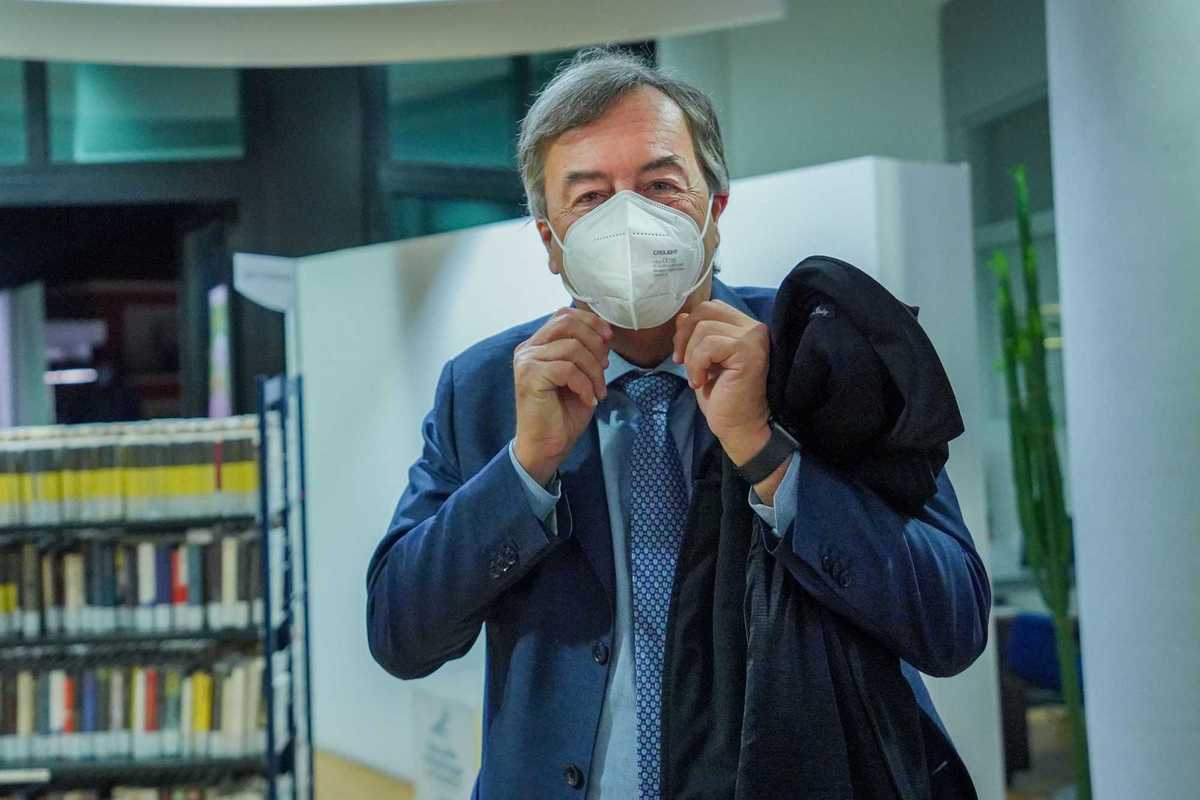L'analisi sul governo
È corso un brivido prima sulla schiena di molti ministri, ieri pomeriggio quando alle 17,27 la portavoce del presidente del Consiglio Mario Draghi ha inviato nella chat dei giornalisti che seguono Palazzo Chigi tre righe improvvise: «Consiglio dei ministri convocato alle ore 18.00. All’odg Comunicazioni del Presidente». Perfino le maiuscole messe un po’ a capocchia hanno contribuito all’agitazione: nessuno dei convocati ne sapeva nulla, e c’è stato anche chi ha temuto un fulmine a ciel quasi sereno: le dimissioni del presidente del Consiglio.
O ancora peggio in questi tempi di guerra. Il mistero si è chiarito nel giro di una mezzoretta: Draghi per la prima volta dopo molto tempo ha voluto battere un colpo da Draghi. Davanti ai ministri è apparso un premier irritato e anche un po’ stufo delle liturgie e dei freni messigli da una strana e litigiosa maggioranza. Così Draghi ha voluto fare vedere a tutti che quando vuole sa battere i pugni. Non sulla guerra, non sul gas e sul petrolio, ma a sorpresa su un argomento che non sembrava in questo momento proprio in cima all’agenda politica: il ddl concorrenza che starebbe andando un po’ troppo per le lunghe per via della norma sui balneari che non passa in Senato con il centrodestra che frena la liberalizzazione delle spiagge.
Può fare simpatia ed essere anche popolare il Draghi che batte i pugni, e può trovare non pochi sostenitori anche sul punto delle concessioni sulle spiagge. Certo, avere fatto correre un brivido non solo ai ministri (che nulla sapevano prima che iniziasse il consiglio), ma pure ai mercati per una vicenda che onestamente sembra minore rende un po’ più difficile capire questa enfasi. Può essere che i partiti stiano stufando chi li deve tenere insieme. Ma che il suo compito non potesse essere una passeggiata doveva essere noto a Draghi le due volte (un anno fa e pochi mesi fa) in cui ha accettato l’incarico datogli da Sergio Mattarella. Ed è anche giusto in un paese normale che sia faticoso tenere insieme una maggioranza politica innaturale, che rappresenta due Italie diverse e spesso contrapposte negli interessi e nelle idee.
L’anomalia in un sistema democratico è un governo di questo tipo, non che fatichino a stare insieme Lega e Pd, Forza Italia e Cinque stelle: questo è naturale che accada. Se Draghi quella fatica voleva risparmiarsi doveva porsi il problema nel giorno stesso in cui ha fatto la lista dei ministri, scegliendo uomini e donne che voleva lui senza passare attraverso i vertici dei partiti. Ora diventa una fatica in più per il presidente del Consiglio: se i ministri di Forza Italia - per fare un esempio - dicono ok, questo non comporta affatto che i gruppi parlamentari seguano l’accordo, anzi. Quindi per portare a casa i provvedimenti tocca fare due giri: quello inutile in consiglio dei ministri, e poi i lunghi incontri con i leader di partito a cui Draghi non si sottrae, vivendoli però con lo stesso piacere di uno a cui si chiede di passare a gambe nude in mezzo a un sottobosco di ortiche. Ieri sera c’è stata la dimostrazione plastica di questa situazione: Draghi ha fatto minacciare la fiducia sul ddl concorrenza, che in effetti risale al dicembre scorso ed è ancora in prima lettura in commissione, sostenendo che l’approvazione è necessaria per ottenere i miliardi del PNRR e che questa era la missione primaria del suo esecutivo.
Gli hanno risposto con una cortese pernacchia i capigruppo di Forza Italia e Lega in Senato che in un comunicato hanno rivendicato la loro difesa dei balneari, aggiungendo ipocriti e pungenti allo stesso tempo: «Siamo ottimisti che si possa trovare un accordo positivo su un tema che, peraltro, non rientra negli accordi economici del PNRR». Il centrodestra vuole lo stralcio della norma, il governo non lo concederà e metterà la fiducia sul testo come è oggi convinto delle sue ragioni, che sono identiche a quelle della procedura di infrazione europea verso l’Italia e quelle con cui il Consiglio di Stato italiano ha bocciato ipotesi alternative. Chi vincerà il braccio di ferro? Se devo scommettere un euro in questo momento lo punto su Draghi, perché dallo sfogo di ieri non tornerà indietro e in questo momento una crisi politica danneggerebbe di più chi la va a provocare. Le spiagge interesseranno di sicuro i 100 mila che vi lavorano, ma agli altri milioni di italiani interessa solo potere trovare una sdraio e un ombrellone dove tirare il fiato qualche giorno con le proprie famiglie la prossima estate. Vincerà Draghi, e poi si metterà a posto in qualche modo per salvare la faccia a tutti. Ma questa giornata resterà come una ferita importante a pochi mesi dalla fine della legislatura. Passata la buriana sulla concorrenza resterà un governo davvero balneare a trascinarsi fino alla imminente fine...
Da qualche tempo nel nostro Paese sta succedendo qualcosa di nuovo. È una metamorfosi che, sottotraccia ma incalzante, sta modificando i termini del confronto civile. Inesorabilmente. Alcuni grandi enti, alcune grandi istituzioni civili e sociali stanno cambiando mestiere. La Cei, Conferenza episcopale italiana, la Cgil, Confederazione generale italiana del lavoro, e la Anm, Associazione nazionale magistrati, non sono più quelle di una volta. Non agiscono più all’interno del loro ambito di competenza. Hanno deciso di scendere in campo, in trasferta. Cioè, abbandonando il loro scopo, la loro ragione sociale. Tralasciando il motivo per cui sono nate e che dovrebbe impegnarle a fondo e assorbire tutte le loro energie perché attraversano momenti, come dire, un tantino difficili.
Invece no, sconfinano. Esondano. Si allargano. Fanno politica. Il motivo? Ci sono al governo «le destre». C’è la minaccia autoritaria. C’è Giorgia Meloni, l’underdog della Garbatella. L’usurpatrice. Tutto è ancora più inasprito dall’imminenza del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Così, questi organismi che incarnano a pieno titolo l’establishment del Paese, si sentono autorizzati a opporsi, a schierarsi per scongiurare il ritorno del fascismo e ad assumere una postura emergenziale. I vescovi dovrebbero occuparsi della riduzione della pratica religiosa, della crisi delle iscrizioni dei bambini al catechismo (pari a zero nelle parrocchie del centro di Bologna, la città del cardinale e presidente Matteo Zuppi), del crollo delle vocazioni sacerdotali (meno 60% negli ultimi 50 anni) e dello svuotamento dei seminari? Lo storico sindacato dei lavoratori dovrebbe concentrarsi sul calo degli iscritti (meno 45.000 tra il 2024 e il 2025), sul dramma delle morti sul lavoro, sugli aumenti dei salari che, non di rado, quando vengono proposti, rifiutano? Il sindacato dei magistrati dovrebbe dedicarsi all’automazione nei tribunali, alla qualificazione del personale e delle attrezzature della macchina giuridica? Niente di tutto questo. Cei, Cgil e Anm combattono in prima linea tutt’altra battaglia.
Oggi il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, Vincenzo Savino, vescovo di Cassano allo Jonio in Calabria, parteciperà al congresso di Magistratura democratica per il No al referendum sulla giustizia. Nel panel «moderato» da Massimo Giannini, l’intervento del prelato è previsto dopo quello di Silvia Albano, presidente di Md nota per le sentenze contrarie al trattenimento di clandestini condannati nei Cpr albanesi, e Benedetta Tobagi, giornalista collaboratrice di Repubblica. Quello di Savino con Magistratura democratica è uno dei tanti casi di contiguità tra vescovi e toghe riprodotta in convegni e partecipazioni sparse sul territorio nazionale in spazi diocesani, finanche ecclesiali, concessi ai comitati per il No. Su un altro fronte, qualche giorno fa, il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, ha presenziato con Romano Prodi e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, all’Iftar, il pasto con cui i musulmani celebrano la fine del ramadan. Sul palco c’era anche Yassine Lafram, imam della Comunità islamica bolognese e già presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii), che a settembre si era imbarcato sulla Flotilla per veleggiare verso Gaza.
Il cambio di ragione sociale è fattuale. Stupisce lo zelo dei vertici della Cei ad abbracciare battaglie eterogenee, dal dialogo inter-religioso (anche quando le altre religioni sono riluttanti a ogni forma d’integrazione) al contrasto all’autonomia differenziata, dalla predilezione per questa Unione europea fino alla benevolenza verso le Ong nell’accoglienza incondizionata ai migranti. Mai che dalla presidenza dei vescovi arrivi qualche pronunciamento che echeggi l’affermazione di Cristo «centro del cosmo e della storia».
Lunedì scorso la Cgil ha promosso una giornata di astensione dal lavoro nei comparti di scuola, università e ricerca «per riaffermare i diritti delle donne, a partire da quello all’autodeterminazione e alla parità di genere, davanti alla evidente recrudescenza di una cultura maschilista, misogina e patriarcale». È solo l’ultimo della sterminata raffica di scioperi indetti dalla sigla capeggiata da Maurizio Landini per contrastare l’attività del governo e, ciò che più conta, complicare la vita dei cittadini. Dalle manifestazioni pro Pal alle occupazioni studentesche, dal sostegno alla Flotilla al contrasto alla Finanziaria e al decreto Sicurezza, ogni pretesto è buono per paralizzare e incendiare le città con l’aiuto della galassia antagonista, per fermare treni, aerei e autobus, e bloccare il lavoro del personale negli ospedali (puntualmente di venerdì). La missione della «rivolta sociale» contro il governo è prioritaria su tutto. E pazienza se crollano le iscrizioni, secondo uno studio del 2023 al ritmo di 121 al giorno che, negli anni successivi, è ulteriormente aumentato. Motivo? «Molti lavoratori percepiscono la Cgil come un’opposizione politica piuttosto che una tutela sindacale» e criticano «la lentezza nei rinnovi contrattuali e la scarsa attenzione alla sicurezza sul lavoro». Contento Landini…
Qualche giorno fa, l’Anm ha usufruito dell’aula della Corte d’assise del tribunale di Treviso per un convegno in favore del No al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. È uno dei tanti episodi in cui un sindacato della più intoccabile tra le categorie professionali, che si comporta come un partito politico, usa un luogo istituzionale per propagandare la linea contraria alla riforma Nordio. Del resto, l’Anm è un’autorità in materia, avendo da sempre la propria sede nel Palazzaccio della Corte di Cassazione in piazza Cavour a Roma. L’identificazione totale dell’Associazione nazionale magistrati con il comitato per il No ha già prodotto le prime defezioni tra i suoi aderenti, dal membro del direttivo Andrea Reale alla giudice della Corte d’appello nelle sezioni civili di Milano, Anna Ferrari. Sono i primi di una più ampia e consistente diaspora di magistrati decisi, oltre che a votare Sì, ad abbandonare l’associazione di categoria. Come per la Cgil, la perdita di associati è una delle conseguenze dello snaturamento, il prezzo da pagare sull’altare dell’opposizione al governo. Cambiare ragione sociale non può essere un processo indolore in termini di fiducia e rappresentatività. Ma alla Cei, all’Anm e alla Cgil ancora non se ne preoccupano. L’imperativo di detronizzare l’usurpatrice viene prima di tutto.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mail inviata ieri agli «sfortunati» studenti del corso di medicina e chirurgia dell’Università Vita-Salute del San Raffaele, fondata da don Luigi Maria Verzé: «Vi comunico che non verranno concessi appelli d’esame». Firmato: il professore dei «somari» - così li chiama lui - alias Roberto Burioni, di cui da troppo tempo si lamentano centinaia di studenti. Ma non sembra essere un caso di allievi demotivati o semplicemente non all’altezza: la pertinacia con la quale il docente farebbe «strage» di allievi è tale che alcuni di essi stanno prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di lasciare l’ateneo e andare a studiare altrove, depauperando il San Raffaele di chissà quante quote d’iscrizione dal costo di 15-16.000 euro l’anno ognuna, che portano nelle casse del San Raffaele circa 6 milioni l’anno soltanto per il corso di laurea di Medicina. Per non parlare dell’effetto deterrenza nei confronti di chi ancora deve iscriversi.
La vicenda dello «sterminatore» di studenti, professore ordinario di microbiologia e virologia al San Raffaele e nel tempo libero animatore del salotto televisivo di Fabio Fazio sul canale Nove, è nota da due anni. L’accusa è semplice: Burioni falcidia gli studenti agli esami, manifestando un accanimento anomalo contro chiunque intenda partecipare e abbia la velleità di passare il suo esame. Un esame, a quanto pare, dal quale non si può prescindere: a Medicina, una volta arrivati al secondo-terzo anno, non è possibile accedere agli esami successivi se non si supera il test con Burioni, che bocciando tutti sta formando una sorta di collo di bottiglia in facoltà, facendo inesorabilmente andare centinaia di studenti fuori corso.
È infatti dal 2024 che praticamente tutti gli studenti di microbiologia vengono sistematicamente bocciati: se due anni fa, su 408 studenti, soltanto dieci furono promossi e i restanti 398 bocciati, oggi, nonostante numerosi ricorsi e infinite polemiche sui giornali, che hanno consentito alla virostar di atteggiarsi a campione di rigore e inflessibilità, la situazione non è cambiata: all’ultima sessione, i promossi si contavano appena sulle dieci dita.
Non è una notizia che in alcune università italiane diversi professori siano particolarmente severi nei confronti degli studenti e, se questo rigore tocca materie fondamentali come la medicina e la giustizia, verrebbe quasi da rallegrarsene. A Roma era famoso negli anni Ottanta il professor Natalino Irti, una delle figure più autorevoli del diritto italiano, professore emerito di diritto civile all’Università La Sapienza e accademico dei Lincei, noto per un approccio al diritto estremamente formale e teorico. Il suo esame era uno degli scogli più difficili da superare a causa dell’alto livello di preparazione richiesto. Al netto delle dovute distinzioni - Burioni (h-index su Scopus salito da 26 ad appena 32 in ben cinque anni e a dispetto del passaggio pandemico che riguarda esattamente la sua materia) non rientra certamente tra le figure di riferimento della microbiologia mondiale ed è più famoso per le sue comparsate in tv che per la sua autorevolezza accademica - non si ricordano lazzi punitivi di Irti, che motivava il proprio rigore semplicemente come atto di rispetto verso la funzione del giurista.
Burioni, viceversa, sembra voler ingaggiare un grottesco «corpo a corpo» con i suoi discenti, da lui esplicitato con il gusto dell’impari sfida: «Professore», ha recriminato su Instagram uno dei suoi allievi chiedendogli un consiglio, «abbiamo problemi con il suo esame». «Tanto non ve lo farò passare mai», è stata la minacciosa replica della virostar. Che, a fronte di una così esigua percentuale di riuscita e delle apparentemente basse performance dei suoi alunni, neanche si è posto il problema di possibili inadeguatezze della sua stessa capacità d’insegnamento, rovesciando sugli alunni tutte le responsabilità: «Faccio notare che il 17% dei partecipanti a questo appello ignorava l’agente eziologico della scarlattina e il 44% non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza», ha dichiarato. Ma la matematica non dev’essere il punto forte della virostar, poiché il 44% non è il 97,55%, che è la percentuale di studenti da lui bocciati. Burioni ha infatti incluso nella «carneficina» anche le eccellenze dell’ateneo: studentesse e studenti con la media del 30 o 30 e lode che puntano a laurearsi con 110 e lode - non esattamente dei «somari» come la virostar sostiene, insomma - e che inciampano soltanto nella sua materia.
Qualcuno è già dovuto emigrare all’estero o in altri atenei italiani per passare l’esame di microbiologia, per poi rientrare al San Raffaele e proseguire il ciclo di studi; altri si sono rivolti al Comitato di Garanzia dell’ateneo per protestare contro l’attitudine sterilmente vessatoria della virostar, ma finora non si è mossa foglia. Gli stessi genitori dei docenti, per alcuni dei quali un anno di università in più è una spesa quasi insostenibile, non possono andare a colloquio con il professore per non esporre i propri figli a sicura bocciatura.
Anziché moltiplicare le opportunità di riscatto per gli studenti respinti, Burioni l’altro ieri ha annunciato l’annullamento della sessione di inizio aprile, subito dopo le vacanze di Pasqua, dichiarandosi semplicemente «infastidito» da tutti i «somari» che erano stati bocciati alla sessione precedente del 23 febbraio e poco propenso a concedere la sessione d’esame prevista per aprile. Il giorno dopo, ha inviato la mail: sessione annullata, gli alunni dovranno aspettare giugno e luglio per poter andare avanti, l’appello sembra essere per lui un «merito» anziché un diritto. Il regolamento in teoria consente ai docenti di annullare una sessione d’esame, ma soltanto per motivi organizzativi o gravi irregolarità come frodi, errori procedurali, gravi disturbi esterni, problemi ambientali o altre violazioni, non ravvisate però da Burioni fino a due giorni fa, quando ha incontrato gli alunni. Che stanno cominciando a orientarsi verso il cambio di ateneo.