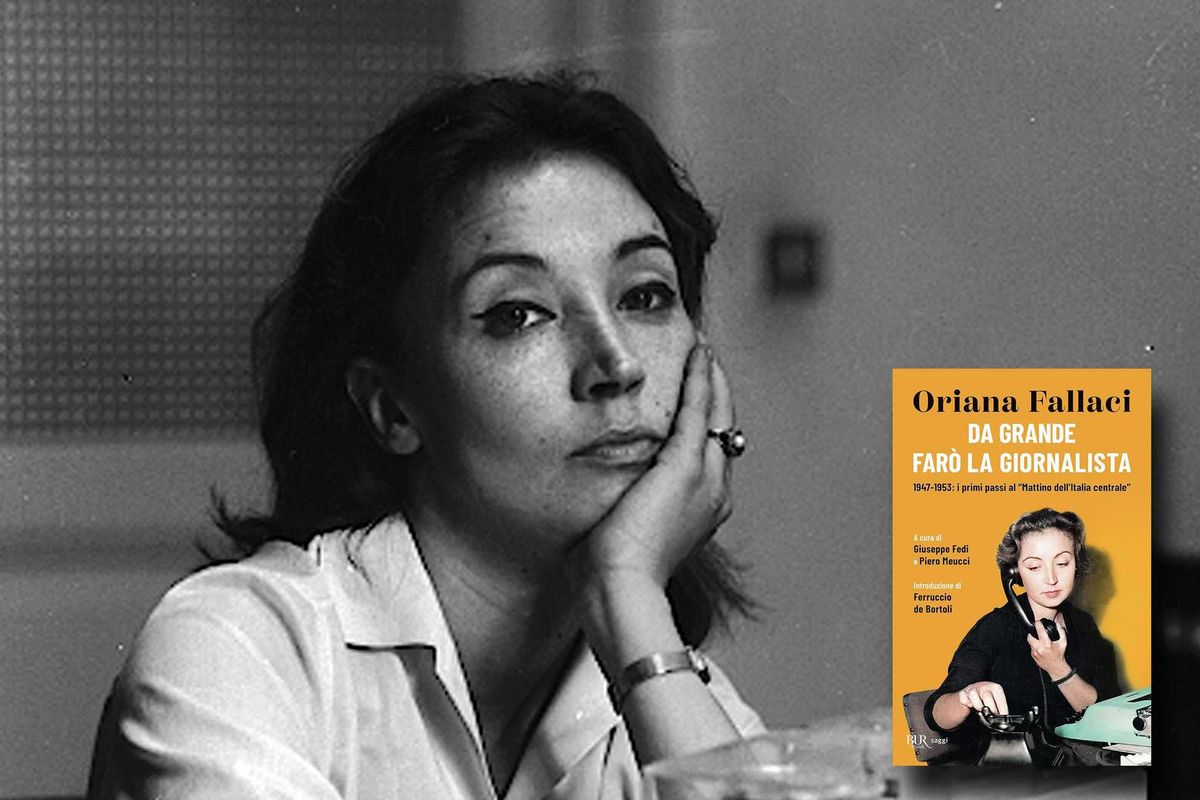Miracolo di Capodanno alle Regioni. Riescono a spendere 1,5 miliardi
Quando si parla di fondi europei la domanda è sempre la stessa: come è possibile sia tanto difficile spendere (bene) i soldi che la Ue ci assegna? Eppure all'Italia spetta sempre la maglia nera: siamo tra i meno capaci di usare le risorse che ci vengono assegnate (venticinquesimi su 28), terzultimi per spesa certificata sul territorio e tra i più lenti a certificare quello che abbiamo speso. Non contenti, siamo anche riusciti ad arrivare col fiatone alla prima verifica di mandato dell'Unione rischiando di perdere ancora una volta denaro a causa dei soliti ritardi. Il 1 gennaio 2019, tutti i presidenti di Regione hanno cantato vittoria dichiarando scongiurato il pericolo, ma in realtà, per far tornare i conti e non finire nel «tritacarne» (non riuscire a spendere il tesoretto messo a disposizione dall'Europa è davvero follia), alcune Regioni furbette hanno giocato con i numeri.
Si tratta di questo. Per il periodo 2014-2020 all'Italia spettano 42,77 miliardi di euro in fondi Fesr, che sommati ai 31 miliardi di contributo nazionale, fanno quasi 74 miliardi da investire in sette anni, in qualsiasi settore, basta che crei sviluppo. Il 31 dicembre scorso, dopo quattro anni dall'assegnazione dei fondi, ogni Regione è stata chiamata da Bruxelles a rendicontare le spese fino a quel momento certificate, un controllo quanto mai necessario dopo che nel periodo precedente (2007-13) l'Italia era riuscita a spendere solo 37 miliardi su 46,4.
La verifica consiste nel certificare una piccolissima parte del fondo che ogni Regione ha a disposizione nei sette anni, una cifra stabilita dalla Regione stessa: poche centinaia di milioni. Eppure, a 20 giorni dalla fine del 2018, mancavano all'appello certificazioni per oltre un miliardo e mezzo di euro, di cui un terzo solo in Sicilia e quasi tutto il resto nelle regioni vicine. Come è finita? Con il solito «miracolo» all'italiana: in due settimane gli uffici regionali sono riusciti a sbrigare il lavoro mai fatto in anni. Ma sarà proprio così?
Per far quadrare i conti la Regione Sicilia, guidata da Nello Musumeci, ce l'ha messa davvero tutta. Si trattava di certificare 710 milioni di euro (su 4,3 miliardi di finanziamenti complessivi), ma in ottobre il contatore era fermo a 6. Dove trovare pezze d'appoggio per quasi tutto l'ammontare in soli 60 giorni?
Una missione impossibile. Eppure, alla data prevista, Musumeci ha dichiarato di aver raggiunto il traguardo. Come ci è riuscito? Per esempio facendo largo uso dei cosiddetti «progetti coerenti», finanziando cioè con i nuovi fondi Ue (quelli del piano 2014-2020) progetti vecchi, già avviati o spesso addirittura fermi da anni per problemi con le aziende appaltatrici. L'operazione è stata complessa. Per prima cosa gli uffici hanno chiesto di ricevere meno denaro (-285 milioni di euro) abbassando così la quota da certificare. Poi, per fare in fretta, hanno saltato a piè pari i sotto-obiettivi più noiosi, quelli che riguardano per esempio lo sviluppo delle piccole imprese (che hanno ricevuto poco più di 37 milioni di euro su 200 previsti), buttandosi sulle grandi opere mai completate. La fetta più consistente delle assegnazioni infatti ha riguardato il settore infrastrutture, dove sono stati certificati circa 460 milioni di euro. Le due opere più importanti, che incidono da sole per 435 milioni, non sono però delle novità: bensì la tratta B del passante ferroviario di Palermo e il secondo tratto della Caltanissetta-Agrigento, con i cantieri fermi da un pezzo a causa dei guai finanziari della ditta che si è aggiudicata i lavori (Cmc di Ravenna). «Un trucco da vecchia politica che dà un contributo pari a zero alla crescita dell'Isola», ha spiegato Luigi Sunseri, deputato regionale M5s, che più volte ha sottolineato lo stratagemma.
Del medesimo sistema la Calabria aveva abusato nella precedente sessione di finanziamenti, tra il 2007 e il 2013, con gravi conseguenze. Sui fondi spesi e certificati il 44% era infatti riferito a progetti retrospettivi, inoltre la Regione aveva finito per perdere più di un miliardo di euro di assegnazioni. Alla prova del 31 dicembre 2018, dunque, l'ente guidato da Mario Oliverio era sotto osservazione speciale. Stiamo parlando di 2,3 miliardi di euro complessivi assegnati, di cui solo una piccola parte sottoposta a verifica. Eppure ancora oggi non è chiaro quale sia questa somma. Com'è possibile? Perché qualche mese fa la Regione aveva chiesto alla Commissione europea di ridurre l'obiettivo di spesa da 595 a 363 milioni, però la risposta ufficiale non sarebbe mai arrivata. A complicare ulteriormente le cose, lo scorso 19 dicembre in un documento ufficiale (e a quanto risulta continuando a non rispondere alla missiva calabrese) la stessa Commissione sottolineava come all'appello mancassero ancora 122 milioni. Quale che fosse la cifra, un altro miracolo è avvenuto: appena undici giorni dopo gli uffici garantivano di aver addirittura superato le richieste europee. Totale spese certificate: 420 milioni di euro. Al di là della guerra di cifre a mancare è di certo la trasparenza. Il sito regionale (finanziato con fondi Ue) dedicato alla rendicontazione, risulta fermo allo scorso luglio, mentre nell'elenco dei beneficiari del programma del settennio precedente (2007-13) risultano progetti finanziati che non si sono mai conclusi. Come quello da 3,7 milioni assegnati alla provincia di Reggio Calabria per attività a sostegno del lavoro: doveva durare due anni ma risulta ancora in corso e se n'è persa ogni traccia di rendicontazione on line. «La Calabria si è contraddistinta per l'uso distorto dei finanziamenti comunitari. Ci aspettavamo un cambio di passo nell'uso dei fondi europei», ha sottolineato l'europarlamentare M5s Laura Ferrara, che ha presentato diverse interrogazioni sul tema. «Invece, se le ultime inchieste giudiziarie trovassero riscontro, sarebbe chiaro quale potrebbe essere stata la modalità usata finora per il raggiungimento degli obiettivi di spesa». E una delle inchieste a cui Ferrara si riferisce è quella denominata «Lande desolate» (agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di falso in atto pubblico, corruzione e frode in pubbliche forniture), che lo scorso 17 dicembre ha coinvolto il presidente Oliverio insieme ai vertici del Dipartimento programmazione europea della Regione.
«Stiamo buttando sangue per rendicontare 658 milioni entro fine anno», urlava lo scorso 16 dicembre il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Lo stesso che, senza imbarazzo, dieci giorni dopo cantava vittoria per i 651 milioni di euro certificati, su 649 previsti. Una vittoria di Pirro, a quanto pare, considerato che secondo Bankitalia la Campania ha speso appena il 4,7% dei fondi assegnati dal programma 2014-2020.
Tra il Veneto al top per la capacità di spesa in agricoltura, la Lombardia già prima in Italia lo scorso giugno per la gestione dei fondi e un Enrico Rossi che da settimane festeggia con un tour promozionale i progetti europei finanziati in Toscana, è il profondo Nord a sfigurare.
La provincia autonoma di Trento ha rischiato fino all'ultimo di rimetterci una decina di milioni su un (modesto) programma da 108, mentre la Valle d'Aosta non è riuscita a spendere i fondi che si era prefissata. All'appello mancano quasi 3 milioni di euro (su 8 preannunciati come spesa) che, ora, la Regione non potrà più recuperare. Secondo Eurobarometro il 60% degli italiani non sa cosa siano i fondi Ue e, tra chi sa di cosa si tratta, l'80% pensa che siano inutili. Non è difficile capire perché.