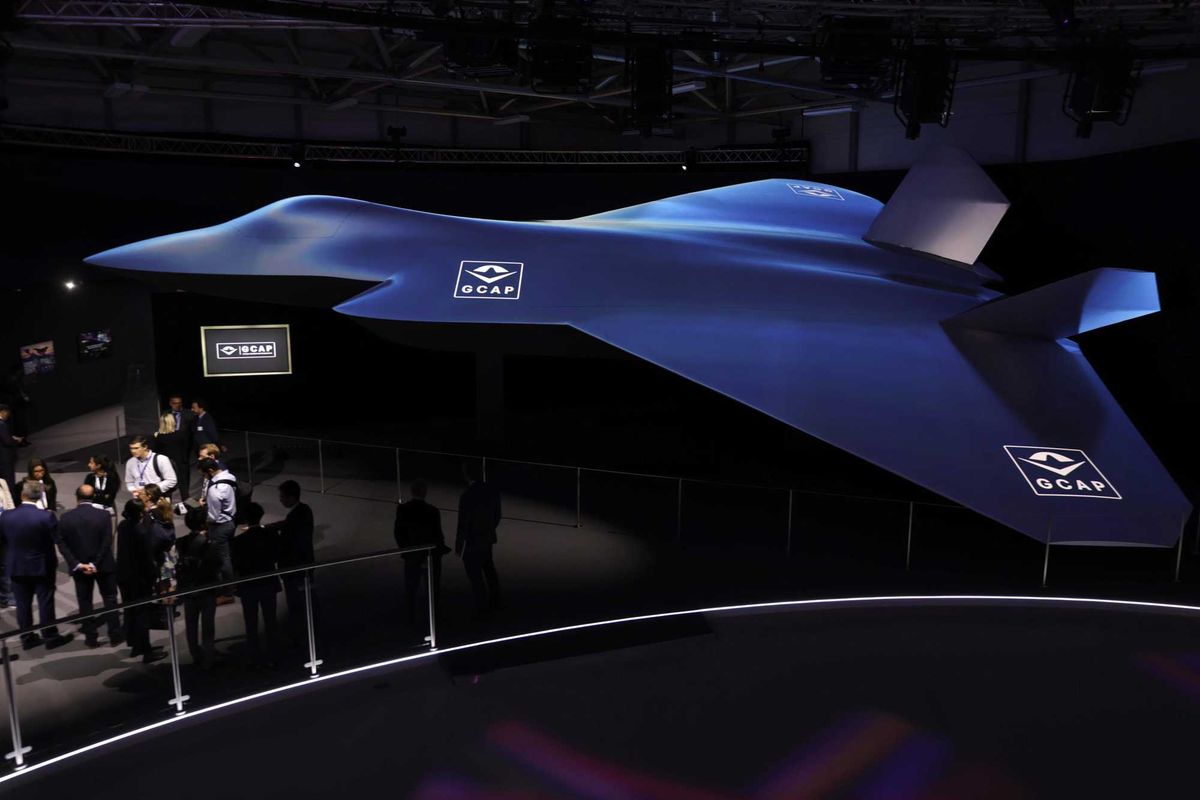Il nuovo siluro della Merkel: la guerra in Ucraina è stata colpa dei baltici e dei polacchi

Quando vanno in pensione, i politici imparano una cosa nuova: dire la verità. Angela Merkel ne ha appena raccontata una sulla guerra in Ucraina durante un’intervista a Partizán, tra i più seguiti canali YouTube dell’Ungheria, dove l’ex cancelliera tedesca era in tour per promuovere la sua autobiografia. Ne ha parlato il britannico Daily Mail, tra i primi a captare la traduzione in inglese del colloquio, che è apparso doppiato in lingua magiara. La Merkel ha attribuito ai Paesi baltici e alla Polonia una grossa responsabilità per lo scoppio del conflitto nell’Est. Secondo l’allora leader della Germania, falliti gli accordi di Minsk del 2014 e del 2015, d’intesa con la Francia, lei avrebbe voluto proporre, a nome dell’Unione europea, l’apertura di colloqui vis-à-vis con Vladimir Putin. Ma Tallin, Riga, Vilnius e Varsavia si misero di traverso. E il gelo con lo zar portò la situazione al punto di rottura.
dopo i flop di minsk
Riavvolgiamo il nastro. Dopo la rivoluzione di Euromaidan del 2013 - sarebbe più corretto considerarla un golpe antirusso eterodiretto da Washington - Mosca annetté la Crimea, mentre nel Donbass iniziavano gli scontri tra separatisti e forze governative. Per porre fine alle ostilità, con la mediazione della Merkel e del presidente francese dell’epoca, François Hollande, si arrivò alla firma di due protocolli, entrambi sottoscritti nella capitale bielorussa, che avrebbero dovuto garantire alcune forme di autonomia alle regioni filorusse in cambio dell’armistizio. Nessuno dei negoziati si rivelò risolutivo. E forse il loro scopo era di tendere una trappola alla Russia: la stessa cancelliera tedesca, in un’intervista a Die Zeit del dicembre 2022, rivelò che gli europei cercavano un modo di «dare tempo all’Ucraina» per ricostruire l’esercito, in vista del confronto finale col nemico.
È una versione che la Merkel sembra aver modificato, nella ricostruzione offerta agli ungheresi. Archiviati Minsk 1 e 2, ha ricordato, «volevo un nuovo format, insieme al presidente Macron», che era approdato all’Eliseo nel 2017, «affinché l’Ue trattasse direttamente con Putin. Alcuni, specie negli Stati baltici, e parecchi in Polonia, erano contrari, perché temevano che non saremmo stati in grado di sviluppare una politica comune nei confronti della Russia». Laddove «politica comune» va evidentemente letto come «oltranzismo antirusso».
Berlino e Parigi, quindi, avrebbero cercato una via d’uscita definitiva dalla crisi. Sarebbero stati gli irriducibili russofobi polacchi e delle Repubbliche confinanti con la Federazione a sabotare la pace. Aiutati da un alleato inatteso: il Covid. Sempre stando alla Merkel, infatti, i colloqui di persona con lo zar sarebbero divenuti impossibili, dato che lui «aveva paura della pandemia di coronavirus. Se non ci si può incontrare, se non si può discutere dei disaccordi faccia a faccia, non si riescono a trovare nuovi compromessi».
il rapporto con orbÁn
I critici hanno subito rinfacciato all’ex cancelliera di aver screditato le nazioni del fronte orientale proprio durante il viaggio promozionale in Ungheria, la più ostile alla causa di Volodymyr Zelensky. Peraltro, nei giorni scorsi, la Merkel è stata ricevuta con tutti gli onori nella residenza ufficiale del premier magiaro, Viktor Orbán, ormai ai ferri corti con il collega ucraino. Questi, in segno di sfida, ieri ci ha tenuto a ribadire che Kiev entrerà nell’Ue a dispetto del parere di Budapest. Ossia, aggirando il requisito dell’unanimità.
Il resoconto della tedesca più illustre spiegherebbe come mai l’Europa, in tre anni dall’inizio dell’«operazione speciale», non ha saputo far altro che invocare il sacrificio degli ucraini in trincea. E adesso la sua versione può fungere da monito per il futuro: quei Paesi che avrebbero impedito il confronto con Putin sono gli stessi che, approfittando del disinteresse americano, hanno monopolizzato la Nato. Spingendo per concentrarne le risorse culturali e materiali sul fianco Est, anche a discapito dei nostri interessi nel Mediterraneo, per il quale Giorgia Meloni e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, reclamano un maggior sostegno dalla coalizione. Trascurare le frontiere Sud, in fondo, significa mettere a repentaglio la sicurezza dell’intera area nordatlantica, checché ne pensi il segretario Nato, Mark Rutte.
nato ostaggio dei falchi
Sono linee di attrito interne all’Alleanza che stanno emergendo anche rispetto al mantra di Ursula von der Leyen, spinto ancora dagli onnipresenti baltici e polacchi: l’iniziativa del muro anti-droni. Ieri, Euractiv dava notizia della fretta con Bruxelles tenta di racimolare finanziamenti per i produttori dei velivoli, pensando a un fondo ad hoc, o magari a dirottare sui piani bellici il denaro stanziato per la ripresa post pandemia. Guarda caso, tra le aziende capofila nella fabbricazione dei droni, spicca la Stark, una startup creata solo 18 mesi fa e nata nella Germania lanciata verso il massiccio riarmo. Sintesi brutale ma veritiera: soldi nostri dovrebbero finire nelle casse delle joint venture con l’Ucraina e dei soliti tedeschi.
Una speranza che i massimalisti addivengano a più miti consigli arriva però dal Papa: ieri, Leone XIV ha ricevuto il presidente lituano, Gitanas Nauseda. La Santa Sede ha espresso preoccupazione per «il rischio di un allargamento del conflitto dalle imprevedibili e terribili conseguenze». Dopo le atomiche, il senno di poi della Merkel non servirebbe più a niente.