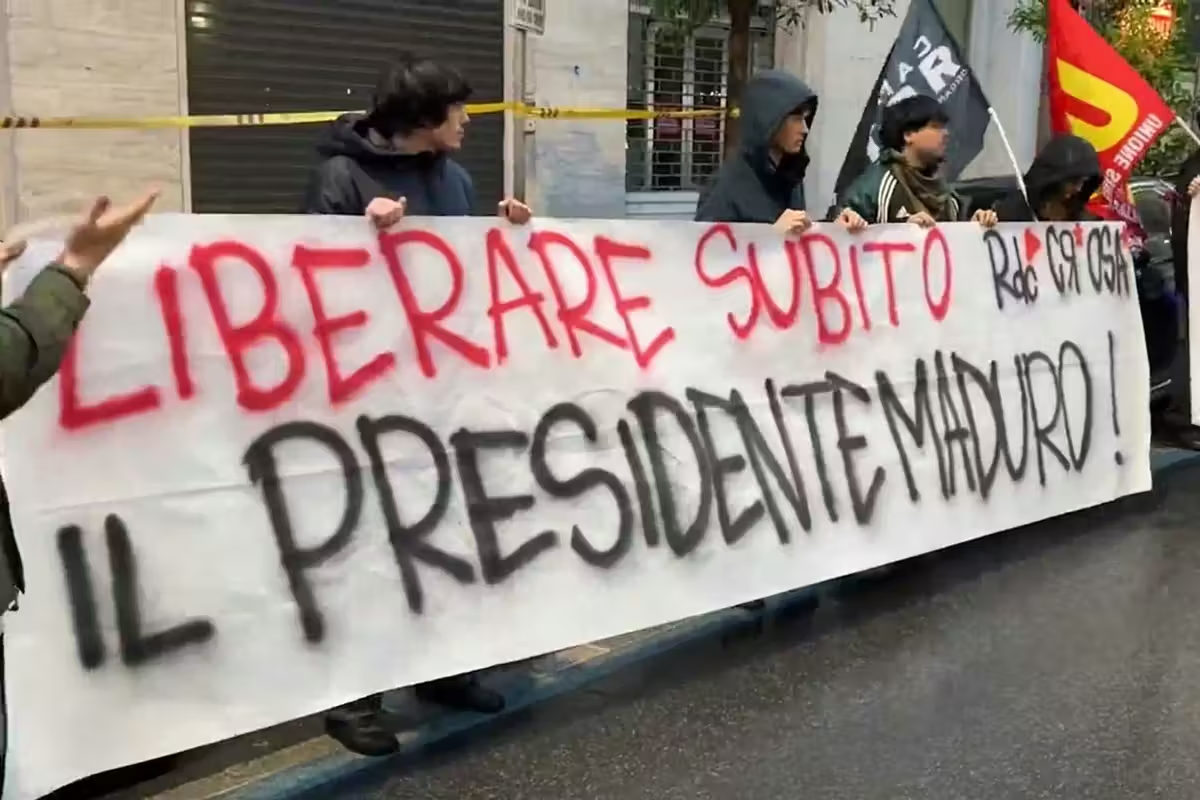- La Pasqua è forse la festa che porta in tavola le maggiori simbologie. E anche la maggior quantità di dolci: eccone una rassegna regione per regione.
- La Carta dei vini per il pranzo di Pasqua: è la grande occasione dei passiti, ma il pranzo comincia con le bolle.
Lo speciale contiene due articoli.
Anche la Pasqua ha il suo calendario dell’avvento: solo che è fatto di pane. La tradizione arriva dalla Sardegna dove peraltro i pani sacrali sono opere d’arte. Si chiama Sa Pippia de Caresima che è una sorta di bambola fatta di pane con sette gambe: se ne mangia una a ogni domenica di quaresima. C’è un’altra signora che annuncia la Pasqua: è la “Vecchia” un dolce fatto a forma di nonnetta con un seno molto rigoglioso e una grande gonna di confettura. La fanno a Gubbio e se ne magia un pezzo alla volta: prima la gonna che è il vecchio anno poi il seno a Pasqua che è l’annuncio di rinascita.
La Pasqua è forse la festa che porta in tavola le maggiori simbologie. E anche la maggior quantità di dolci. Partiamo dal dessert. Il più diffuso dei dolci pasquali è senza dubbio la colomba: un sondaggio dice che il 57% per ceno degli italiani la preferisce di gran lunga all’uovo di cioccolato. Come sempre accade si pensa che la colomba abbia dietro di se una tradizione antica. È invece un po’ come Babbo Natale il frutto di un’invenzione di marketing di una grande industria e dell’intuizione di un artista. Così come la conosciamo noi e come la consumiamo la colomba è figlia del panettone. Dino Villani creativo della Motta decise di usare l’impasto e le macchine che la motta usava per fare i suoi dolci natalizi anche per Pasqua fece un’innovazione: la glassa di mandorle che ha reso questo dolce inimitabile. Affascinante no? Eh anche perché Villani si era inventato anche il concorso che diventerà miss Italia e la sua colomba sta per compiere cento anni! In realtà però esisteva una tradizione di pani fatti a colomba. Un’antenata è sicuramente la fugassa veneta che ha un impasto molto simile e pare che a Verona già alla fine dell’800 i pasticceri la confezionassero a mo’ di colomba. Se poi sia vero che l’abbia fatta San Colombano nel VII secolo per addolcire Teodolinda, che invece sia servita a ingolosire e dunque rabbonire Alboino all’assedio di Pavia poco dopo il Cinquecento o che abbia celebrato la vittoria della Lega Lombarda a Legnano è soave crederlo.
Ci sono però almeno due dolci che devono qualcosa agli svevi e a Federico II in particolare. Il primo sono gli agnelli in pasta di mandorle che si fanno in Sicilia e specialmente tra Messina e Catania proprio per Pasqua. Gli arabi avevano insegnato ai siciliani a fare lo zucchero dalla canna, ma una volta cacciati le piantagioni deperivano. Fu lo “stupor mundi” a imporre di ripiantarle e così mentre tutto il resto d’Italia addolciva ancora col miele nel regno svevo si usa lo zucchero. Le monache della Martorana a Palermo in occasione della visita di Carlo V inventeranno grazie a quello zucchero il marzapane da cui gli agnelli pasquali. L’altro dolce carico di simboli è senza dubbio la pastiera napoletana. Nasce come evoluzione dolce di un piatto povero e salato. Si faceva una peci di pasta brisè riempita di grano bollito, formaggio sale e pepe per dare ai pescatori del sostentamento. Si dice fosse un lascito delle sacerdotesse di Cerere che col grano celebravano la fertilità. Ma le monache del convento di San Gregorio Armeno - siamo attorno al XV secolo - ci hanno messo molto del loro. Hanno tolto la parte salata e lascato il grano cotto nel latte, sostituito il formaggio con la ricotta e grazie allo zucchero dello Stupor Mundi e all’essenza di fiori d’arancio hanno fatto o’ miracolo. Perché la pastiera è davvero un dolce assoluto. Che ha tutti i simboli pasquali: il grano e il latte incontro di natura e fertilità con l’aggiunta delle uova, e spezie simbolo di ricchezza, lo zucchero inno alla dea Partenope e al fascino femminile in un mix pagano-cristiano che è alla base di gran parte della nostra gastronomia. E poi ci sono le sette strisce di pasta che indicano le sette vie di Napoli! Una similitudine che ci porta verso la cultura giudaica è la torta di visciole e ricotta che si fa nel ghetto ebraico a Roma: meravigliosa. E ancora ricotta spunta nei cannoli siciliani.
Dolci pasquali molto particolari sono i buccellati: c’è quello siciliano ricchissimo di canditi, c’è quello lucchese che si fa con l’uva sultanina e di solito si serve dopo la lavanda dei piedi. E poi ci sono le tante pizze dolci. Quella toscana con i semi di anice, quella umbra che si fa Ciaramicola a Perugia, la pinza triestina dove incontra la Gubana giuliana. E poi ci sono la Coddura, la crostata di ricotta, le ciambelle ogni regione d’Italia porta in tavola una specialità pasquale.
E le uova di cioccolata? Beh loro sono un po’ tarde: arrivano alla fine dell’Ottocento ma la particolarità è il loro significato. Sapete perché si rompono e hanno la sorpresa? Perché simulano il santo sepolcro! Le uova sono invece il simbolo della Pasqua da sempre. Lo erano anche in età pagana e i romani quando descrivevano il or pasto diceva ab ovo ad mala che è diventata una locuzione per descrive un lavoro compiuto. Ab ovo perché? Perché l’uovo era l’antipasto ed è sempre simbolo della vita. Per gli egizi era il simbolo cosmico. Così a Pasqua si mangiano tantissime uova. Secondo Unaitalia - l’associazione delle aziende avicole - durante la settimana santa gli italiani ne mangiano sei a testa il che fa salire il nostro consumo annuale a 227 procapite. Ma a Pasqua si usano per fare le tagliatelle, i tortelli che sono uno dei patti indispensabili di questa festa perché con l’unione di erbe e ricotta si celebra la rinascita, perché son indispensabili per alcune preparazioni specifiche. Su tutte la torta Pasqualina ligure che deve avere 33 strati quanti gli anni di nostro Signore, poi il Casatiello napoletano, e ancora il Tortano sempre campano che ha la forma della corona di spine. Ma le uova sono protagoniste di un rito specialissimo del centro Italia: la colazione di Pasqua. Si fa con la pizza al formaggio (una specie di panettone farcito di pecorino) la coratella di agnello, le uva in frittata di mentuccia o asparagi selvatici, il salame. Un rito esteso in forme più o meno diverse in tutta Italia, dove un tempo i bambini dipingevano le uova assodate che si facevano benedire e poi si mangiavano la mattina di Pasqua.
E cosa si porta in tavola a Pasqua? È la fine della Quaresima dunque ricordando il carnem levare (il Carnevale) torna in tavola la carne. Soprattutto l’agnello in ricordo dell’ultima cena di Nostro Signore che con i 12 apostoli celebrava la Pesah, la pasqua ebraica che in ricordo del sangue dell’agnello usato per segnalare all’angelo vendicatore le case degli ebrei in procinto di fuggire dall’Egitto sacrifica i figli della pecora. Tante sono le ricette, una delle più diffuse è l’agnello con i carciofi tanto per stare totalmente dentro la cultura giudaica. Ma torna in tavola anche il maiale in larga misura sotto forma di affettati e salumi anche se il maialino arrosto e la porchetta son tipicamente pasquali. Dunque carne in tavola e se possiamo dare un suggerimento perchè non pensare al vitello tonnato che tiene tutti i sinoli pasquali? L’uovo nella salsa (andrebbe usato il rosso bollito e non la maionese) l’ictis che segno di Cristo (il pesce) il vitello sacrificale.
Tra le tante ricette italiane ecco dalle Marche e in particolare da Macerata che ha registrato la ricetta come STG (specialità tradizionale garantita) i Vincisgrassi con i sette strati di sfoglia a simboleggiare i sette giorni della settimana santa, poi i cannelloni, gli gnudi fiorentini (ricotta e spinaci senza pasta), i risotti vegetali, le frittate di asparagi e carciofi, i fritti vegetali. Questo è il menù della Pasqua. Ma anche qui occorre indagare un po’ di simboli. Ad esempio se andate al Cenacolo di Leonardo a Milano vedrete che sulla tavola on c’è carne ma pesce. La ragione? Il simbolo di cristo è il pesce, ma pare che Leonardo fosse anche vegetariano. Se invece andate a Montelupone un borgo incantato delle Marche, nella pinacoteca c’è un’ultima cena che avrebbe fatto felice Dan Brown perché si vede chiaramente Maria di Magdala accanto a Gesù tra gli apostoli. E su quella tavola c’è pane non azzimo e carne con vino rosso. Ma ci dovrebbero essere anche i carciofi visto che quelli di Montelupone sono tra i migliori d’Italia. Una proposta che vi farebbe fare grande figura con gli ospiti è quella di portare in tavola un piatto con lo zafferano. La ragione? Sta nel secondo concilio di Nicea nel 787 quando per porre fine all’iconoclastia si decise che l’oro sarebbe stato il colore della santità (da qui anche i tanti fondi d’oro della pittura alto medioevale). Ma ciò che è santo è sano, ed ecco che lo zafferano entrò in cucina come sanificatore dei cibi. Qualche idea se non volete fare il riso giallo ala milanese? Un cus cus oppure la trappa allo zafferano che si fa in val d’Orcia, meravigliosa! E già che siamo in tema di concili ecco un consiglio per la cena del venerdì santo: tanto baccalà. In tutti i modi. Il merluzzo è diventato il pesce dei cattolici al concilio di Trento quando si discuteva della riforma protestante e si scoperse che Lutero aveva dettato le sue 90 tesi a cena con i suoi apostoli mangiando aringhe. Che vennero scomunicate. Fu allora che Olao Magno vescovo svedese diffuse ai padri conciliari un libretto n cui si magnificava il pese stocco (stoccafisso). I portoghesi poi superarono lo stoccafisso perché catturavano i merluzzi che risalivano la corrente del Golfo prima di arrivare alle Lofoten e li salavano. Così il baccalà è diventato il pesce dei cattolici per la quaresima. Se volete essere filologici e penitenti accompagnatelo con i ceci. Sarà un perfetto men di vigilia. E comunque buona, anzi buonissima Pasqua.
È la grande occasione dei passiti. Ma il pranzo comincia con le bolle

iStock
È il riscatto dei vini passiti. La Pasqua con i dolci offre a questi straordinari frutti della vigna l’occasione di diventare protagonisti. Dunque sotto con i moscati per accompagnare gran parte dei dolci pasquali. Moscato di Pantelleria, Moscato di Scanzo rarissimo e inimitabile, Moscato d’Asti e Asti spumanti per i dolci con le creme e la frutta, ma anche gli spumanti dolci con il Brachetto o la Vernaccia di Serrapetrona amabile. Spazio al Moscato giallo trentino e al Moscato roso se i dolci sono con i frutti di bosco. Tra i grandi passiti ecco il Torcolato di Breganze e poi il Sagrantino umbro che pare fosse il vino da messa dei francescani.
Un discorso a parte merita il Vinsanto toscano che con la pasticceria secca e le paste di mandorle ha la primazia. Un buon omologo è senza dubbio il Vino Santo Trentino. Se avete dolci con gli agrumi ecco la Malvasia della Lipari, ma anche il Fior d’Arancio e l’Erbaluce di Caluso passito. Un discorso a parte va fatto per il Marsala. È il re di questo momento: austero, non dolcissimo, perfetto anche con i grandi formaggi (ma lì riservate un poso per il Verdicchio passito) l’unico che regge, insieme al Barolo Chinato, la sfida del cioccolato fondente. Se poi si vuole avere una sensazione mediterranea irrinunciabile è la Vernaccia di Oristano. Sosteneva acutamente - ma quest’insegnamento non tramonta mai - Jean Anthelme Brillat-Savarin «pretendere che non si debba cambiare di vino è una eresia; la lingua se ne satura; e dopo il terzo bicchiere, anche il miglior vino perde del suo sapore» e dunque almeno a Pasqua facciamo che il vino si accompagni al cibo. È il grande momento degli spumanti.
Si sa che il Prosecco ormai in quantità batte lo Champagne e in effetti per il pranzo di Pasqua si deve cominciare con le bollicine per accompagnare i salumi ma anche le uova sode. Si possono sceglier degli charmat che sono più fruttati, ma il massimo sono i nostri quattro grandi: Alta Langa, Oltrepò, Franciacorta, Trentdoc. Senza dimenticare che la produzione spumantistica - del resto come insegnerebbero Andrea Bacci e Francesco Scacchi medici marchigiani che a fine ’500 e ben prima dei francesi codificarono la rifermentazione in bottiglia - da vitigni autoctoni in Italia è in grandissima crescita qualitativa: dal Durello dei Lessini al Bombino pugliese, dal Verdicchio marchigiano al Torbato sardo, dal Vermentino maremmano e di Gallura al Nerello mascalese siciliano, sono tutte basi spumanti eccelse e tantissime altre ce ne sono. In alternativa e non è affatto una diminutio un grande Lambrusco o per i più affezionati alla tradizione: Bonarda.
Se optate per un primo vegetale – risotto, tortelli al burro, cannelloni in besciamella – obbligo rivolgersi a un grande bianco e la scelta in Italia è davvero infinita. Si parte dal Collio con Pinot Bianco, Sauvignon, in Trentino con i Traminer o Sylvaner, si va in Franciacorta con lo Chardonnay, in Piemonte con Timorasso o Gavi, il Liguria col Pigato, in Emilia Romagna con Pignoletto o Albana, in Toscana con grandi Trebbiano e Vermentino, in Umbria con i Grechetti, nelle Marche con Verdicchio, Ribona, Passerina, in Abruzzo con il Trebbiano, in Lazio con Bellone e Malvasia, in Campana con Fiano, Greco e Falanghina, in Puglia con Bombino e Verdeca, in Basilicata col Fiano Minutolo, in Calabria con il Cirò, in Sicilia con Geco, Inzolia, Catarratto, in Sardegna con Vermentino e Torbato. Poi tocca ai rossi Se avete scelto l’agnello servono vini di nerbo Barbaresco, grandi Sangiovese, Montepulciano, Aglianico in tutte le sue forme, Nero d’Avola. Una spresa la Tintillia Molisana, un scelta di carattere il Magliocco calabrese. Perché a Pasqua il vino non è solo brindisi ma torna ad essere bevanda sacra.