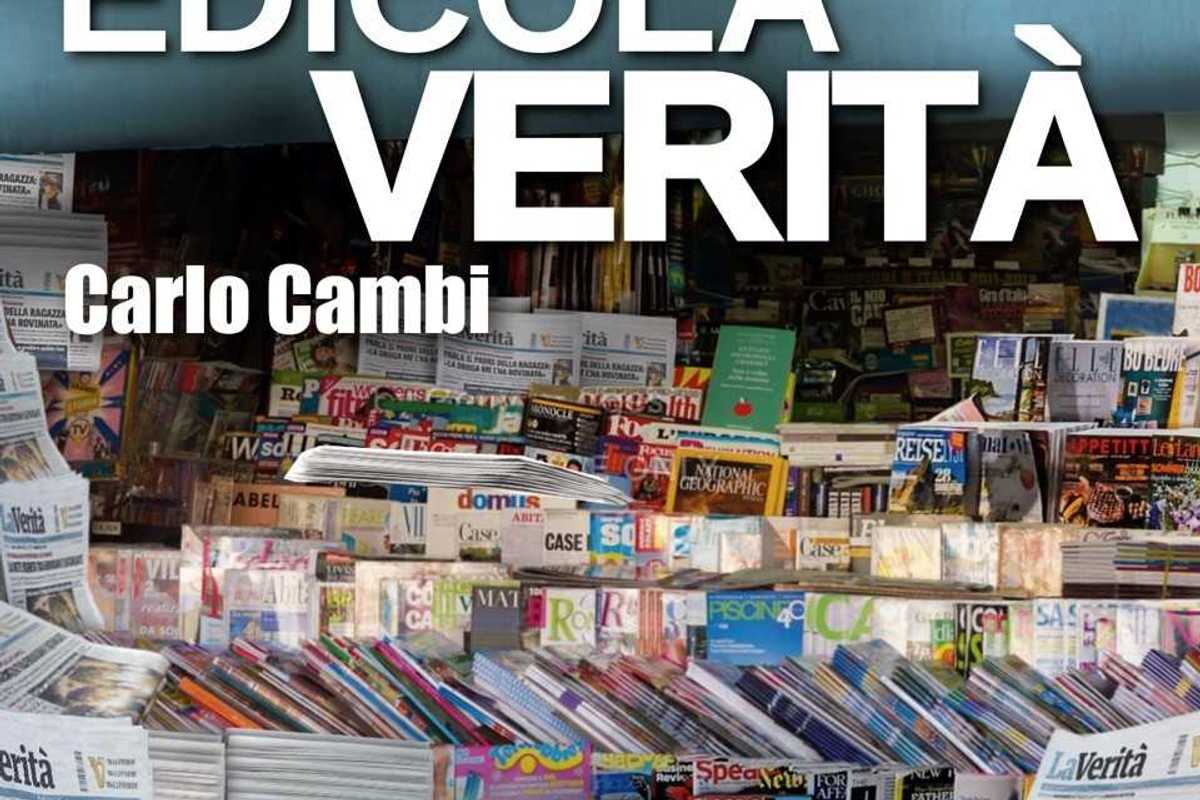Sorelle separate o cugine di prossimità? Si potrebbe introdurre così la storia di prodotti legati al recupero ultimo del sacrificio suino, quello riassunto con il noto mantra «del maiale non si butta via niente». Tecnicamente si potrebbero raggruppare in una inedita categoria, quella delle polpette di maiale, perché alla base, tutte, derivano dal macinato della principale materia prima, fonte inesauribile di prosciutti e insaccati, ma è meglio procedere con ordine lungo orizzonti nordestini. Un viaggio che parte dalle valli trentine, più precisamente la Val di Non, con capitale norcina la piccola Tassullo, un centro abitato con poco più di centocinquanta residenti. Qui, da anni, si svolge la Festa della Martondela pu bona. La martondela ha una storia antica. Con gli avanzi della lavorazione di tagli più nobili, frattagliame vario non conservabile altrimenti, tipo fegato o polmoni, abbinati con lingua o coppa, veniva pestato nel mortaio (da qui l'etimo che dà il nome al prodotto) e poi avvolto non nel budello come i cugini salumi, ma nell'omento, ovvero quel retino dalle intriganti venature di grasso che avvolge l'apparato intestinale. Questa la variante della bassa valle, mentre salendo in quota cambia il metodo di conservazione, a parità di preparazione iniziale.
Rigorosamente impastati a mano con spezie e aromi diversi (in tutte queste storie la procedura artigianale non può venir sostituita da nessuna catena di montaggio alimentare) si hanno dei panetti del peso medio di due-tre etti. L'abilità del norcino sta nel creare un mirabile equilibrio a bilanciare le diverse componenti. Al posto del retino il rivestimento usato è una farina di grano saraceno, più fina e sgranata della farina bianca. Segue una affumicatura con rami di faggio e bacche di ginepro. La modernità ha fatto uscire dai binari della tradizione rurale la martondela, divenuta più borghese grazie al macinato formato ora da spalla, coscia e pancetta. In cucina gli usi più diversi. Il prodotto fresco cotto alla griglia, spadellato, ma anche ad arricchire una zuppa d'orzo o un risotto con il teroldego. Martondele ghiotte con le erbe cotte, in primis il tarassaco. Quelle stagionate e affumicate si abbinano al meglio con i formaggi.
La famiglia Corrà, con macelleria e laboratorio a Coredo, si occupa da generazioni della valorizzazione di questa piccola eccellenza locale. Davide, ultimo della nidiata, ha portato sul podio nazionale le martondele valligiane, quale miglior salume d'Italia, categoria affumicati. Sue alcune innovazioni. Al posto della tradizionale farina di grano saraceno le possiamo trovare rivestite e affinate con erbe aromatiche o farina di canapa.
Altra valle, altra martondela, stavolta nella vicina Caldonazzo, alta Valsugana. Fegato e filetto nell'impasto. Ogni famiglia un corollario di spezie dosate con sapienza. Non viene affumicata, ma consumata fresca, la forma compatta di un canederlo. Spadellata con un po' di salvia come fritta con l'aggiunta di generose quote di vino rosso. La locale Confraternita, da oltre vent'anni, si prende cura di valorizzarla con festa dedicata. Il tutto sempre rigorosamente con carne di capi suini allevati sul po e alimentati con mangimi misti a base di erbe e mais.
Di valle in valle si giunge in Friuli. Qui la martondela montanara incontra cugine dai nomi diversi, ma dal dna molto simile, vuoi che si chiamino marcundela, markandela o merkundela. Una tradizione radicata e resistente ai venti omologanti della modernità. Il primo a darne notizia a livello nazionale l'intramontabile rabdomante di gusto e tradizioni, Luigi Veronelli, in visita a una macelleria di Lucinico, nel goriziano. L'impasto è un festival di frattagliame vario. Fegato, milza, reni, polmoni. Grassi assortiti sparsi tra i visceri grufolanti. Tradizione vuole che, un tempo, la mattina, ben cotta nel burro, con polenta complice, desse carburante ai villani che si avviavano a passare le loro faticose giornate sui campi. Se ne faceva scorta in famiglia conservandola entro recipienti colmi di strutto. Un bell'esempio di come far di necessità virtù. Non ci si negava nulla, nemmeno tornati al calduccio del focolare domestico, ed eccola ripresentarsi, la sera, bollita o spadellata nel vino rosso, ma anche quale condimento per palati robusti, abbinato alla pasta come a energetiche frittate. Celebrata con degni eventi a Buttrio, a fine novembre, con il Purcit su la bree (il maiale sulla tavola di legno, dove viene immolato agli umani palati), ambasciatore Girolamo Dorigo, uno dei produttori di eccellenza del Friuli enologico. Un rimando a quando, in casa, si faceva festa, con la garanzia di riempire la dispensa per i mesi a venire con i prodotti del generoso suino.
Nelle famiglie più osservanti, il giorno prima dell'ultimo sacrificio, la vittima veniva benedetta, con la dovuta riconoscenza, dal parroco in persona. Nella vicina Artegna si svolge, invece, il Purcit in stajare, con riferimento a un'antica danza friulana (lo stajare) importata dalla vicina Stiria asburgica, grazie ai migranti che tornavano periodicamente all'ovile. Gran celebrante il purcitar locale, ovvero il norcino, che godeva della massima considerazione tra tutte le famiglie che, periodicamente, dovevano ricorrere alla sua arte. Ad Artegna, come a Buia, vi è un'altra versione, dai tratti più aristocratici, del macinato di frattaglia, ovvero il crafus. Fegato a grana finissima, assemblato con il pan di sorc (una meraviglia di cocktail di granaglie, tra cui il mais cinquantino, una storia nella storia), uva sultanina, scorze di limone e arancia, mele a cubetti, e spezie diverse. Le madri stendevano il retino del maiale sul tavolo, tagliato a quadrettini dopo averlo lavato con acqua e aceto. Qui avvolgevano le piccole polpettine che andavano poi a formare i golosi crafus, bombon di frattaglia allo stato puro, adagiati su polenta .
Vi sono poi, nel Veneto centrale, le piccole cenerentole rappresentate dalle martondee. Poche memorie scritte in letteratura golosa, ma ben radicate nella memoria antropologica di chi le ha vissute. Qua ci sono gli «stampi» che fanno la differenza, ma lo scenario si svolgeva nelle aie, non certo in tipografia. La notte della mattanza si riunivano le famiglie allargate di allora: zii, nonni, cugini e parentame vario per un evento atteso tutto l'anno (tranne che dal diretto interessato). Per alleviare ai più piccoli i riti tribali del norcino intento ad affilare le lame, i padri di famiglia mandavano i piccoli innocenti da amici e conoscenti, in altre fattorie, a «procurarsi gli stampi» per confezionare poi le golose martondee. Questi procedevano, piccoli corrieri di frattaglie, nelle brume invernali per tornare un'ora dopo con un sacco, sigillato e pesante, contenente i preziosi «stampi». In realtà, al momento dell'apertura, si svelava l'arcano, manco fossimo al primo di aprile.
Testimone di questa tradizione, ben motivato a spargere il verbo tra le nuove generazioni, il bravo Claudio Reginato, con laboratorio norcino alla Madonna della Salute, piccolo borgo di Maser con vista sui colli asolani, da poco entrato nell'area Mab Unesco del Monte Grappa. «Era tradizione che a fare il velo (cioè il retino avvolgente del macinato) fossero le donne di casa, per la delicatezza e la cura quasi modellassero dei ricami. La nonna metteva i retini distesi sopra la tavola come una tovaglia e lì confezionava le martondee per noi piccoli. Gli stampi erano quelli delle nostre piccole bocce golose». Spadellate con un filo d'olio, il tocco in più con un veloce passaggio in forno così da rendere morbido il velo esterno con la carne all'interno che mantiene tutto il suo sapore.