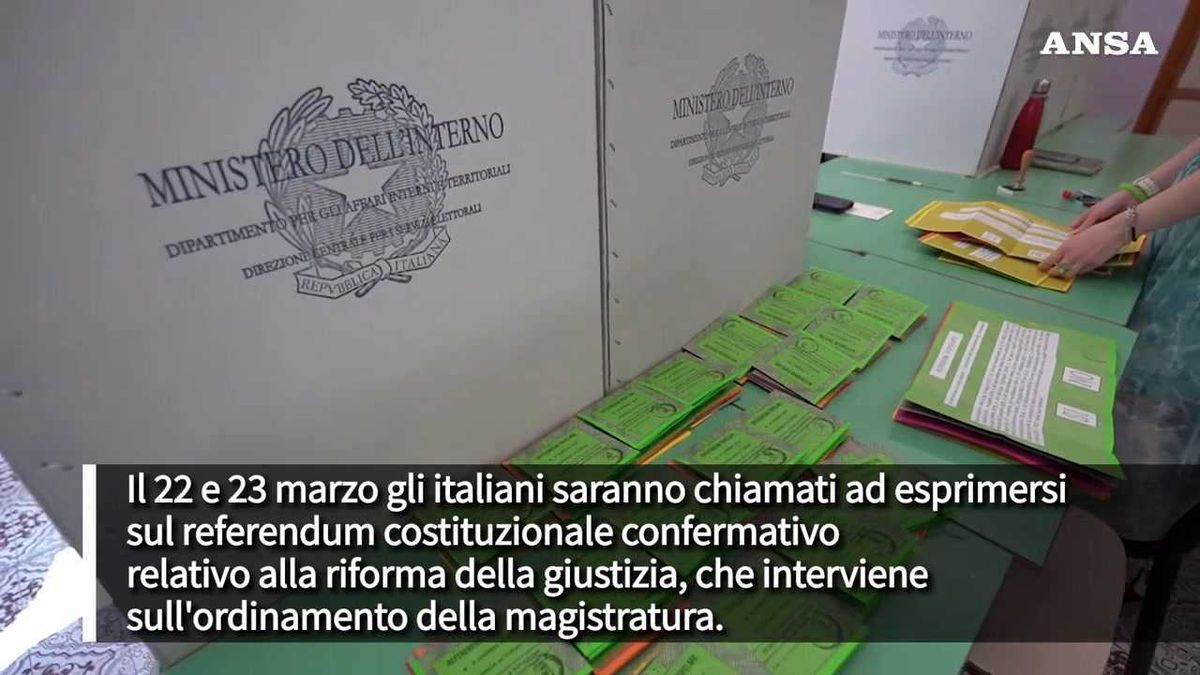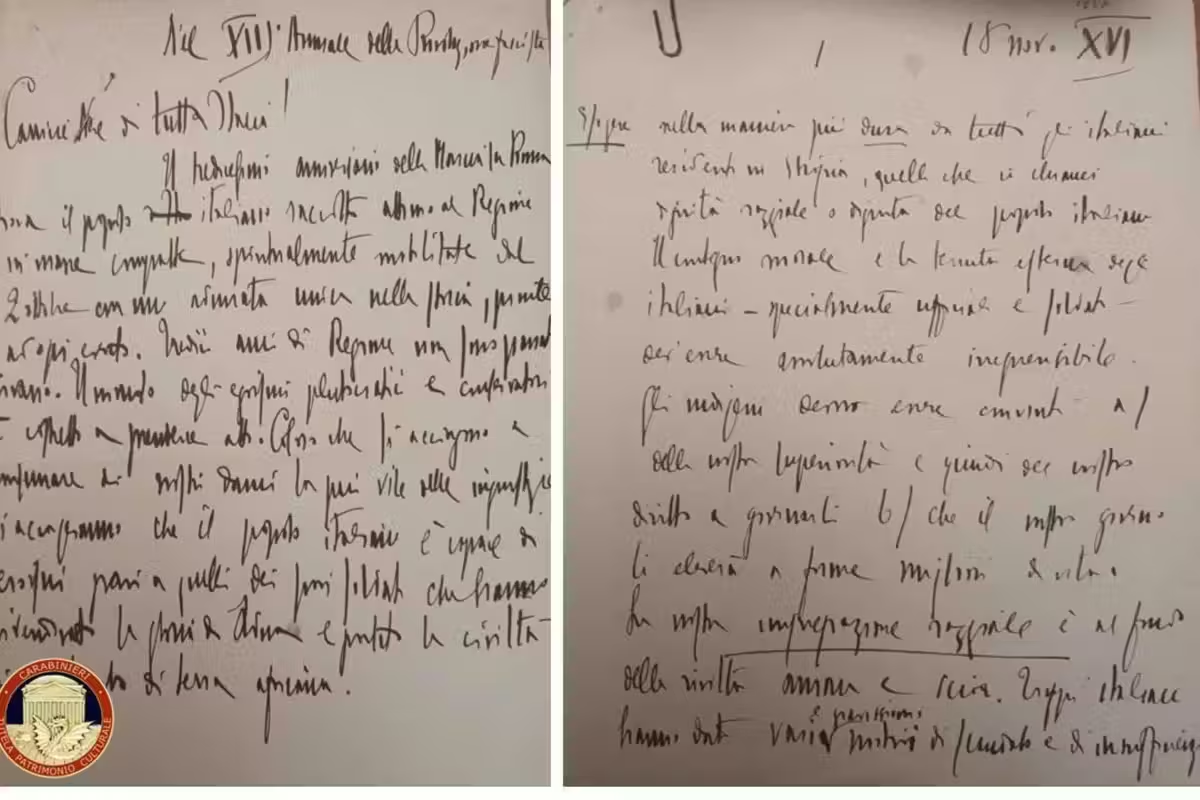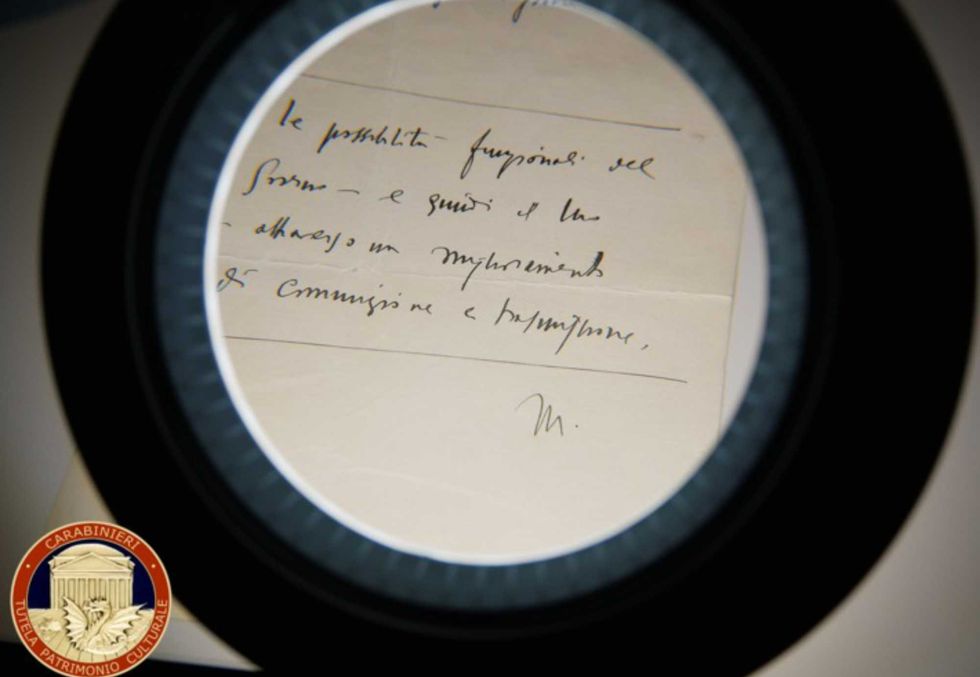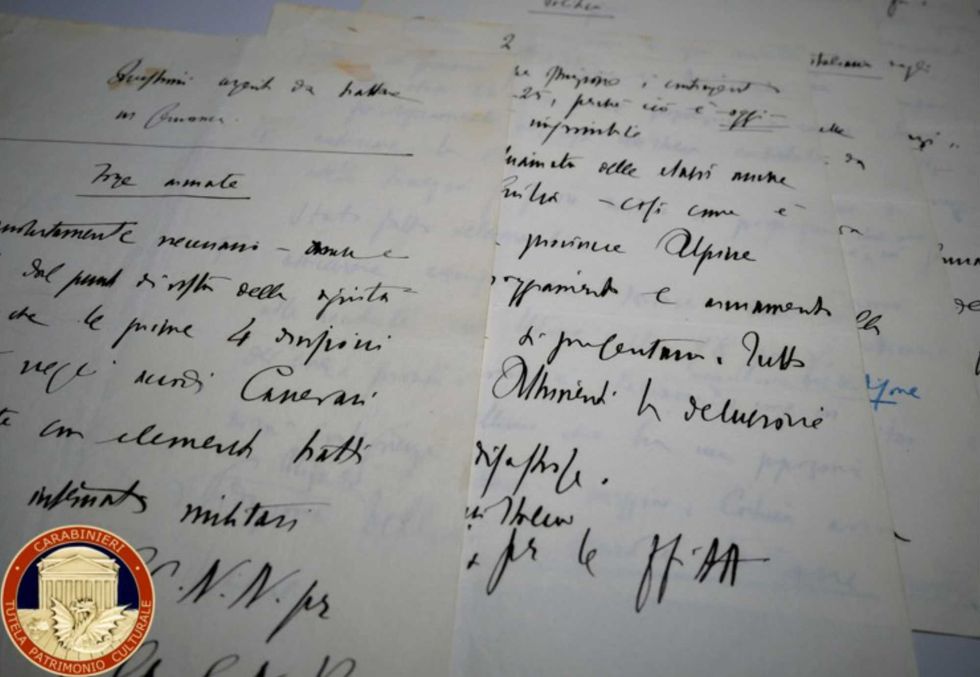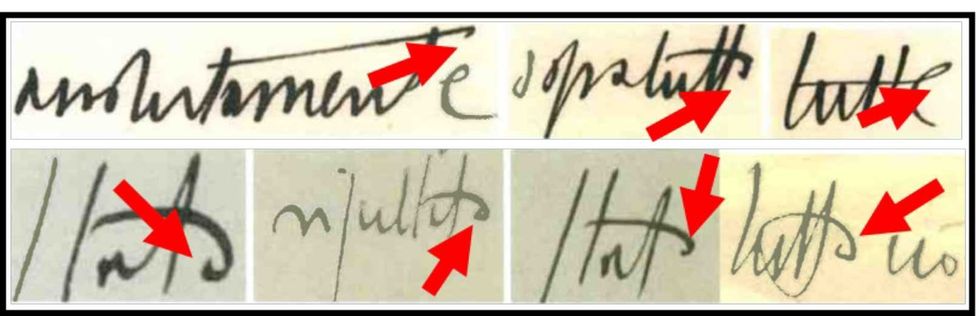Londra, Parigi e Madrid insegnano. Basta isterie sull’aumento dei casi

Il green pass rafforzato è una realtà, con oltre un milione e 300.000 italiani che l’hanno scaricato nelle prime 24 ore, eppure il governo ipotizza nuove restrizioni. Colpa dell’indice di contagio Rt che continua ad aumentare e dell’aumento dei ricoveri: ieri in ospedale c’erano 6.078 pazienti contro i 5.879 del giorno precedente. Di fronte a questa progressione il premier Mario Draghi non esclude l’ipotesi di nuove restrizioni, che potrebbero essere definite anche intorno a Natale, con Regioni dichiarate gialle o arancioni e sottoposte a vincoli. Le regole sono chiare: una Regione passa in zona gialla quando il tasso delle terapie intensive supera il 10 per cento e contemporaneamente il tasso di occupazione dell’area medica supera il 15 per cento e poi diventa arancione se le terapie intensive superano il 20 per cento e l’area medica il 30 per cento. Numeri che portano a divieti generalizzati e anche a chiusure. Una prospettiva che sembra inevitabile al nostro governo, nel caso di un incremento della curva del contagio, ma che in altri Paesi vicini a noi e con caratteristiche analoghe, non viene contemplata.
Prendiamo il caso della Gran Bretagna, dove il contagio dovuto alla variante Omicron è triplicato nell’arco di una settimana, ma non sono state definite contromisure. L’unica iniziativa è stata quella di imporre doppio tampone a chi entra nel Paese, che deve mostrare un certificato di negatività quando varca il confine e comunque deve sottoporsi ad un altro test entro due giorni dall’arrivo e rimanere isolato finché non riceve l’esito negativo anche di questo secondo test. Per il resto si procede come sempre, con le mascherine al chiuso ma non all’aperto e i locali regolarmente in funzione. Proprio ieri mattina il primo ministro Boris Johnson ha analizzato la situazione. «È possibile che la variante Omicron sia più trasmissibile della variante Delta», ha dichiarato, «ma è troppo presto per trarre delle conclusioni». A suo parere serviranno altre verifiche per capire se questa variante aggira il vaccino e determina contagi eccessivi. Per tale ragione il governo ha deciso di non discutere nemmeno il piano B per l’inverno, che potrebbe comportare più restrizioni nel caso in cui la pressione sull’Nhs, il sistema sanitario nazionale, diventasse eccessiva. I dati più recenti parlano di 51.459 nuovi casi in un giorno, con 7.485 persone ricoverate in ospedale di cui 913 in rianimazione. I casi confermati di Omicron sono 336. Anche il collegamento tra il virus e i ricoveri si è ridotto, come pure il numero dei decessi.
Pure in Francia, nonostante ci siano 50.000 nuovi casi al giorno e il tasso di crescita sia passato da 378 casi per milione a 545 casi per milione, sono state chiuse solo le discoteche e per il resto la vita procede come sempre. Per fronteggiare Omicron il governo d’Oltralpe punta sui vaccini, tanto che sono stati riaperti gli hub vaccinali per consentire di rendere rapida la somministrazione della terza dose e anche il contatto con coloro che, a causa della nuova variante, hanno pensato di cominciare il ciclo di immunizzazione.
In Spagna, poi, dove il tasso di crescita è molto simile al nostro, con un aumento dei casi giornalieri che è di un terzo superiore a quello delle settimane precedenti, nessuno si è fatto prendere dal panico. La penisola iberica ha mantenuto le regole esistenti: si usa la mascherina negli ambienti chiusi - ma in fondo non si è mai smesso di farlo - , ci sono otto delle 17 regioni che hanno introdotto il Covid Passport per alberghi e ristoranti. Poi si insiste nella campagna di vaccinazione, che ha percentuali simili alle nostre, con l’85 per cento della popolazione che ha ricevuto le due dosi. Nessuno ha ancora avanzato proposte per restrizioni o limitazioni dei cittadini, con l’ex ministro della sanità spagnolo Salvador Illa, che qualche giorno fa ha precisato che fino a quando si procede con le vaccinazioni e i cittadini rispettano le regole del distanziamento, non servono altri interventi radicali. Anche perché i dati dei ricoveri in terapia intensiva e soprattutto delle morti causate dal virus rimangono bassi (simili a quelli italiani) e quindi non sembrano giustificare la necessità di un giro di vite.
Per ora, insomma, i Paesi nelle nostre condizioni non si stanno spaventando. Soprattutto, nessun governo sembra assumere decisioni facendo riferimento solo alle percentuali dei ricoveri e della saturazione dei posti letto in terapia intensiva. Anche perché i parametri spesso sono molto diversi. Qualche esperto, peraltro, è scettico sulla soglia di saturazione, che viene considerata allarmante e spinge a proporre restrizioni. L’impressione è infatti che non sia abbastanza alta o che comunque rispecchi il livello di ricoveri che anche in passato era stato registrato nelle terapie intensive durante le fasi critiche dei picchi influenzali invernali. A dimostrare che si tratti di un dato non così significativo, potrebbe forse contribuire anche la decisione assunta ieri dalla Regione Lombardia, che rischiava di diventare gialla intorno a Natale. È bastato procedere a una riorganizzazione ospedaliera per affrontare la crescita dei contagi e aumentare i posti letto, per evitare questo pericolo. Adesso il numero di letti a disposizione per il ricovero dei pazienti Covid in area medica è passato da 6.646 a 7.945 (con un aumento di 1.299 unità), facendo salire il numero di posti letto a disposizione per ogni 100.000 abitanti da 66,7 a 79,2 e allineandosi ai dati comunicati dalle altre Regioni e alla media nazionale, che rimane comunque più alta e pari a 99,8. Intanto dal Giappone arrivano notizie incoraggianti: il Covid sembra non essere più un problema, con 800 positivi totali e un solo morto.