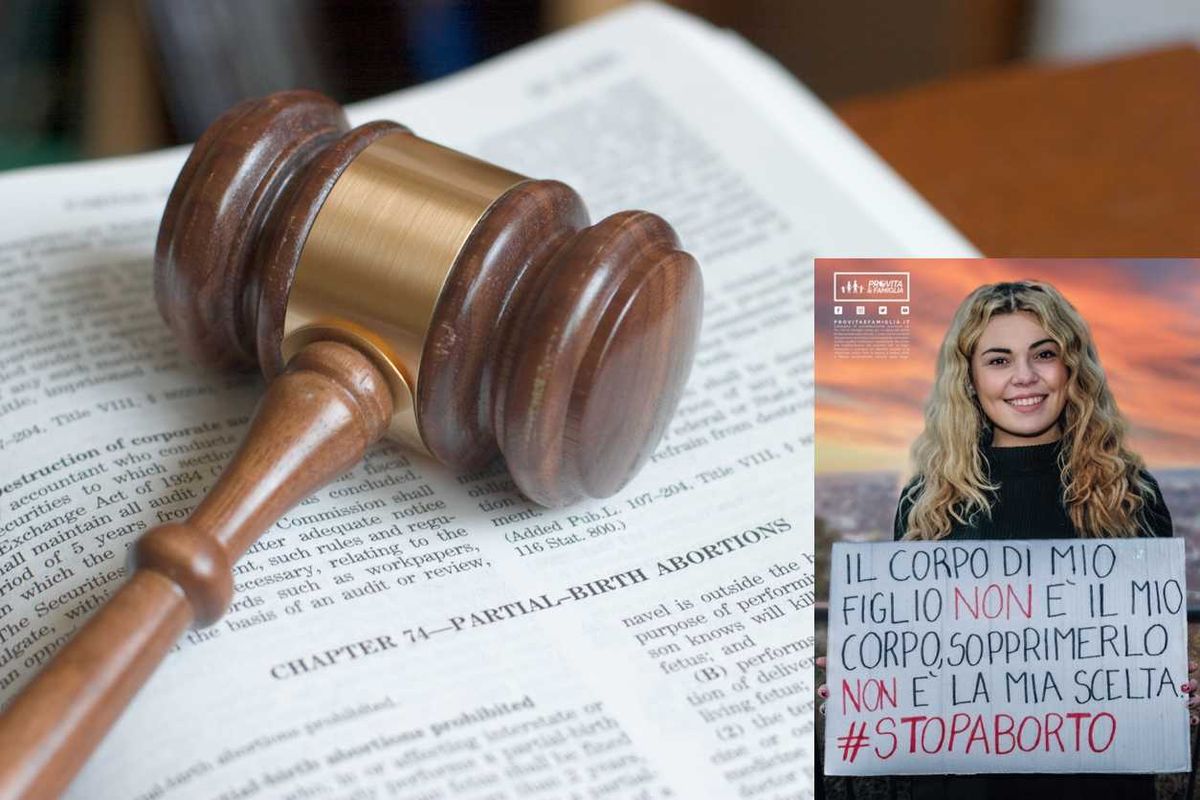Sono in libreria per le edizioni Bompiani le Memorie di un rinnegato. Il «rinnegato» sarebbe Giampiero Mughini, che - invece - non rinnega proprio nulla: anzi, rivendica un rigoroso percorso intellettuale. E la conquista - anche dolorosa - della solitudine, di una scomoda e orgogliosa indipendenza. Al punto da usare quell'insulto (lasciamo ai lettori la curiosità di scoprire chi gliel'abbia scagliato contro) quasi come un segno distintivo.
Disse Graham Greene: «Partiti, nazioni, istituzioni tradiscono. Un'azione morale può solo essere individuale, e, come tale, limitata e fallibile». È così?
«Assolutamente. A questo si riduce l'essenziale: quello che hai fatto, la coscienza e la responsabilità che ne hai».
L'ultimo Pasolini, descrivendo la sua estraneità ai conformismi di destra e di sinistra, diceva: «Scontento tutti, mi inimico tutti, sono costretto a tenere relazioni complicatissime, fatte di spiegazioni continue». Si riconosce un po'?
«Mah, io vivo così appartato che non devo render conto a nessuno. Non mi sento in dovere di dare spiegazioni. Certo, può capitare di sentirmi offeso, per esempio da cose chiaramente lontane da ciò che sono. Di recente, in un libro, si parlava di me come di “uno che viene da Lotta continua". Ma quando mai? Non ho avuto altro rapporto con loro se non, in spirito liberale, l'aver offerto la mia firma affinché il loro giornale potesse uscire…».
Lei infatti firmò per consentire l'uscita di giornali assai lontani dalle sue idee, beccandosi la bellezza di 26 processi.
«Mi parve normalissimo farlo. C'era e c'è una legge idiota, che impone un direttore responsabile iscritto all'albo… Adriano Sofri venne da me a chiedermi di farlo. Pier Paolo Pasolini e Marco Pannella lo fecero prima di me per un tempo breve. Io invece molto a lungo: smisi - credo - quando cessarono le loro pubblicazioni».
Nel libro lei torna sull'assassinio di Luigi Calabresi, e rinnova la sua opinione sulla reticenza del gruppo dirigente di Lc. Lascio da parte le questioni giudiziarie. Ma perché è così difficile per alcuni fare i conti con mesi di campagne politiche di rara e feroce aggressività?
«A onor del vero, l'ammissione morale Adriano Sofri l'ha fatta. Certo, colpisce rileggere quel suo editoriale pubblicato all'indomani della morte di Calabresi. Testualmente c'era scritto che la morte del commissario “rincuorava il proletariato". Ecco, tuttora mi lascia sgomento pensare che un operaio dell'Alfa Romeo o della Pirelli potesse essere rincuorato dalla morte - colpito alle spalle - di un uomo di 34 anni con tre figli, di cui uno doveva ancora nascere. A meno che…».
A meno che?
«A meno che un ragionamento del genere non venisse da chi aveva deciso o autorizzato quell'azione».
Perché in una parte della sinistra e in un certo ceto intellettuale è così forte il ricorso all'arma del disprezzo? È difficile ammettere che anche un'opinione diversa sia rispettabile e in buona fede?
«È davvero difficile da capire, tanto più perché molti di loro vengono dalla mia stessa radice, da un bagno di libertarismo. E cos'è il libertarismo? È la consapevolezza che siamo tanti, diversi, e che le sfumature del grigio arrivano a 200… Non è che ogni volta che si incontra “l'altro" si debba pensare che rappresenti la summa del male esistenziale. Non l'ho mai pensato. La cosa più grave, il “reato" più pesante che posso aver attribuito a qualcuno è essere cretino… Non più di questo».
Lei incarna un approccio opposto. Il suo libro del 1991, ripubblicato l'anno scorso, su Telesio Interlandi (un innominabile, il direttore della Difesa della razza), pur senza alcuno sconto, mostra che le personalità sono sempre sfaccettate, mai unidimensionali…
«Per l'appunto. Davanti a ogni persona, devi cercare di capire, situarla nel mondo reale. Com'era, com'erano gli altri italiani… Si era dentro una dittatura? Certamente. A onor del vero, la più soffice rispetto alle altre dittature (nazismo e stalinismo) di quel lungo periodo. Ma - dicevo - devi ricostruire la fisionomia di un uomo reale, i suoi torti, le sue caratteristiche. Non un mostro: a meno di ritenere che fossero mostri quasi tutti gli italiani di allora. Ma mio padre, che era fascista, non era un mostro».
È possibile un'analisi senza «demonologie» della dittatura fascista?
«Per esempio, occorrerebbe riconoscere che quella classe politica era tutt'altro che banale: vogliamo citare Giovanni Gentile, Alfredo Rocco, Alberto Beneduce, Giuseppe Bottai? Ma pensiamo anche al 25 luglio: i protagonisti arrivano a quella riunione (Dino Grandi raccontò di avere due bombe a mano in tasca) non sapendo se ne sarebbero usciti vivi, o se sarebbero finiti in gattabuia. Misero in minoranza Benito Mussolini, restituirono la sovranità al re, che era stato zitto perfino davanti alle leggi razziali…».
Nel libro c'è il racconto di molte lunghe amicizie, ma anche di alcune rotture definitive. È difficile ricucire il tessuto di un rapporto umano, quando si è lacerato?
«È difficile, non lo si può negare. È avvenuto a tanti di quelli che sono stati esposti nella vita pubblica. Pensiamo al Manifesto: tanti di loro avevano militato per 30 anni nel Pci, eppure i rapporti con gli ex compagni erano difficili e dolorosi… Molti erano ingraiani: e ruppero con una figura adamantina come Pietro Ingrao…».
Perché sottovalutiamo così tanto il «fattore umano», quel labirinto di invidie, ambizioni, colpi bassi, che così spesso ci trova smarriti e impreparati?
«In effetti è incredibile. Penso ai lunghi anni di passione trascorsi a Catania. Tramite un caro amico, l'anno scorso ho ricevuto dei messaggi in cui altri, che pure ritenevo amici, discutevano di un mio libro come se fossi un estraneo totale, uno scrittore rumeno o un intellettuale spagnolo…».
Che spiegazione dà?
«Non so, se io parlassi di loro, si coglierebbe anche dalla più piccola sfumatura che conservo affezione e memoria… Invece la realtà è che, specie in questo mondo giornalistico, è più facile essere rivali che amici. Lo percepisco con tutti e cinque i sensi…».
C'è futuro per la carta stampata? Nel mare dell'informazione online, un'opinione forte scritta può essere un frangiflutti, o almeno una boa?
«Penso di sì. Io stesso al mattino leggo cinque quotidiani, e mi sento quasi in colpa perché vorrei leggerne sette o otto… Non riesco a immaginare un mondo senza carta stampata. Sarà una nicchia, ma la “preghiera del mattino" ci sarà ancora a lungo».
Però lei, come un abile pianista, tocca molti tasti. I suoi articoli sono stracliccati su Dagospia. Anche online è possibile andare oltre la scontatezza…
«Tengo moltissimo alle cose che scrivo per Dagospia, dove godo di libertà assoluta. Certo, non vai proprio oltre la scontatezza se su Instagram sei una giornalista e metti una tua foto ammiccante… Non farò nomi neanche sotto tortura, però confesso di essere sbalordito da chi fa queste cose…».
E poi la tv, popolare (con Loretta Goggi) e ultrapopolare (con Aldo Biscardi, con Pierluigi Pardo). Come riesce a entrare in luoghi tanto diversi da questa sua cattedrale di libri dove stiamo parlando, e farsi capire da un pubblico vastissimo?
«Quando sei in tv, di fronte non hai nulla, in apparenza. E invece c'è una porzione di gente che non conosci e che non ti conosce, che non ha vissuto la tua vita né tu la loro… Ecco, la sfida è, senza tradire ciò che sei, curare che - attraverso la semplicità, la snellezza, la concisione - la comunicazione arrivi. A molti critici televisivi a cui non è mai capitato di scrivere su di me una parola di simpatia, vorrei dire: venite voi, provate a vedere se è tanto facile…».
Come si pone davanti al problema della soglia di attenzione dello spettatore tv? Da giovanissimo, un cinico regista Usa mi disse che la soglia era di «10 secondi se parli, di 20 se piangi, di 30 se sanguini». È così brutale?
«Non siamo troppo lontani… Certo, in quei primi 10 secondi devi acciuffare al collo l'ascoltatore. Non ci mette niente ad andarsene, gli basta premere un tasto in un secondo…».
Nel libro ironizza sulla facilità con cui si usa il termine «opinionista»…
«Sento parlare di opinionisti anche a proposito di persone che - diciamo - fanno rumore con la bocca, o che hanno semmai altre brillantezze, tipo far ridere o avere delle bellissime gambe femminili… Spero che il pubblico sappia distinguere tra macchiette e chi invece si sforza di costruire un ragionamento. Poi il punto vero è il dilagare dei talk show, perché non costano. Di fatto La 7 riempie il palinsesto quotidiano pagando solo i conduttori…».
Trova improprio che a volte il parterre sia costruito con «maschere» di cui si sa già la posizione?
«Infatti… Io ad esempio, costruisco la mia posizione man mano che ragiono. Non posso dirti prima cosa dirò…».
Nel libro riserva parole di autentica ammirazione per Lamberto Sechi e Claudio Rinaldi.
«Due maestri di giornalismo. Quando Sechi venne all'Europeo, aveva un qualche sospetto sul fatto che io fossi amico di chi c'era prima di lui, ma mi affidò subito un pezzo, e dopo neanche un mese e mezzo mi aumentò lo stipendio. Quanto a Rinaldi, è stato un talento eccezionale, il più grande direttore della mia generazione. Avrebbe certamente diretto Repubblica, se non fosse stato per la malattia che l'ha portato via… Era la lealtà fatta persona. Gli dicevi: facciamo questo? Poteva risponderti di no. Ma se diceva sì, ti chiedeva subito: “Quante pagine ti servono?"».