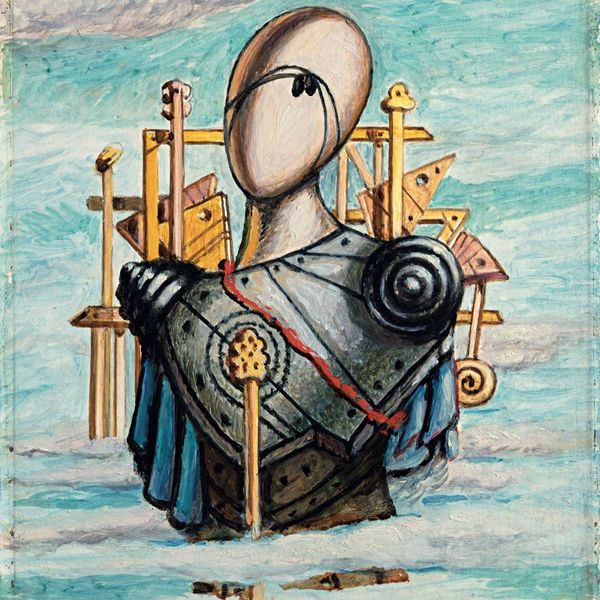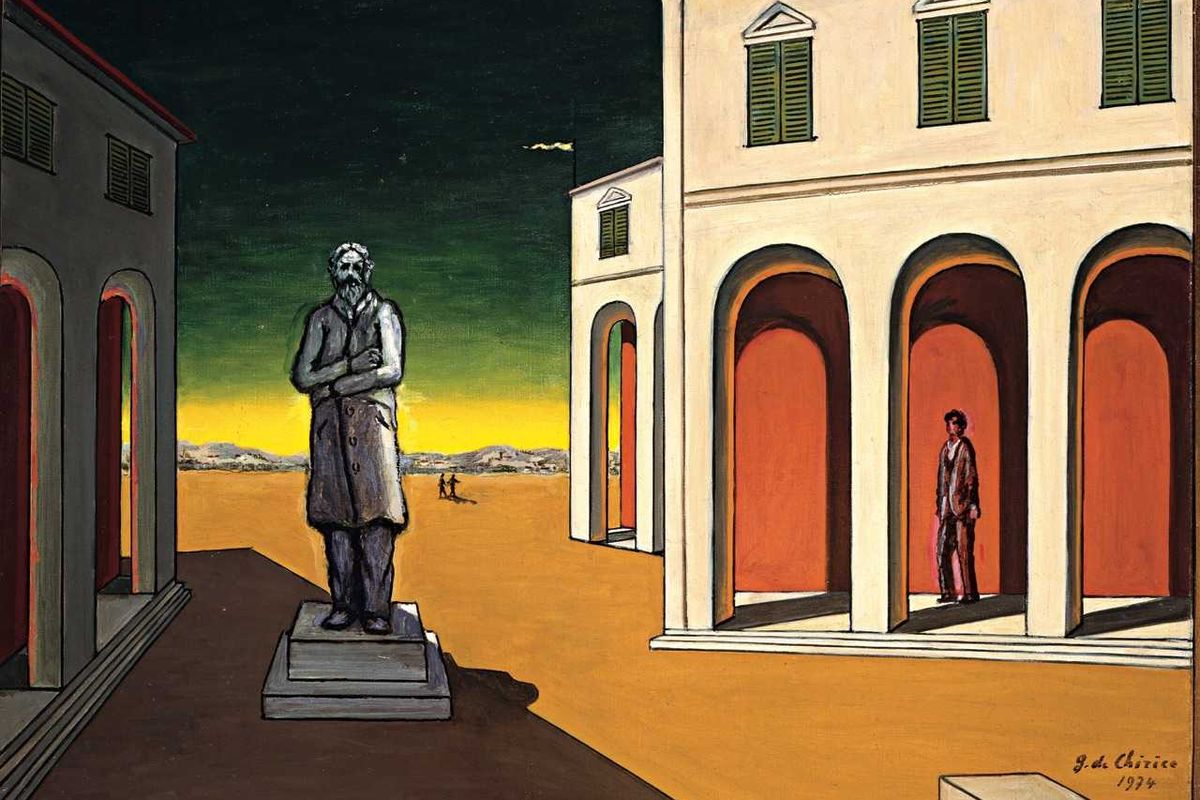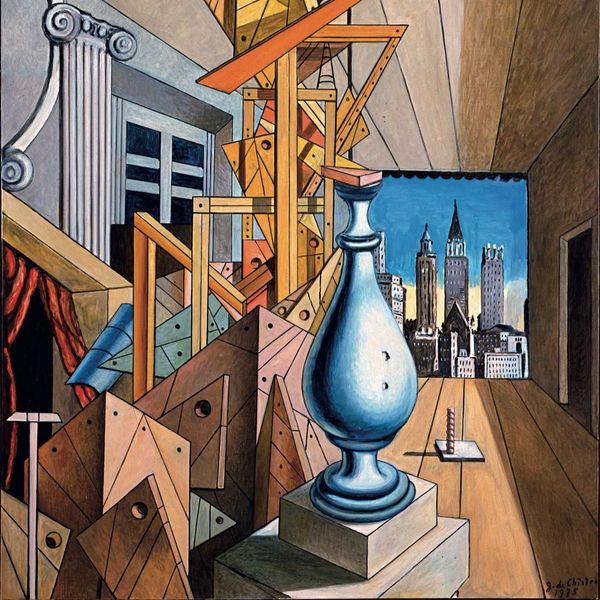È morto a 34 anni, ha avuto un percorso accademico frammentato e incostante, ha prodotto relativamente pochi scritti, è ignoto al grande pubblico (e spesso anche a quello colto). Eppure Thomas Stearns Eliot lo definì «il precursore di una nuova forma mentis, che sarà quella del Ventesimo secolo». Parliamo di Thomas Ernest Hulme, figura cruciale della cultura di lingua anglosassone della prima metà del Novecento e oggi illustre sconosciuto, più per la pigrizia mentale dell'epoca presente che non per le sue smanie censorie.
A porre parziale rimedio all'oblio di Hulme ci pensa ora la casa editrice Oaks, che pubblica il suo Contro Bertrand Russel e altre meditazioni, a cura di Luca Gallesi, che già nel 2005, nel suo Le origini del fascismo di Ezra Pound, aveva presentato al lettore italiano le idee e la vita avventurosa di questo eclettico personaggio. Vediamo quindi di chi si tratta.
Nato nel 1863 a Grafton Hall, nello Staffordshire, Thomas Ernest è un ragazzo inizialmente gracile, forgiato tuttavia da una rigorosa educazione e dal contatto con la natura. Quando arriva al St. John's College di Cambridge è già un marcantonio, che all'esuberanza fisica unisce una vivacità intellettuale non comune. E anche un notevole libertinismo sessuale: una volta affermò che «l'uscita di emergenza della stazione della metropolitana di Piccadilly Circus è il posto più scomodo in cui abbia copulato».
Viene espulso da Cambridge nel 1904, dopo una rissa da ubriaco (sarà riammesso nel 1912 dietro raccomandazione di Henri Bergson, poi di nuovo cacciato per uno scandalo sessuale). Se ne va in Canada, dove si guadagna da vivere come boscaiolo, poi torna in Europa, insegna inglese a Bruxelles, e infine ritorna a Londra, dove si pone al centro di un cenacolo di avanguardia letteraria in cui figurano anche Ezra Pound e Wyndham Lewis. È lui il vero deus ex machina della corrente poetica dell'imagismo.
«Era capace di prendere a pedate tanto una teoria quanto una persona», dirà di lui lo scultore Jacob Epstein. Durante le sue conferenze era solito agitare un tirapugni in bronzo fatto scolpire appositamente dall'amico Gaudier Brzeska, dicendosi convinto che il modo migliore per trattare i suoi avversari intellettuali fosse «un po' di violenza personale». Quando Hulme soffia a Wyndham Lewis la sua finanziatrice, Jate Lechmere, questi segue il suo rivale sin sotto casa, dove scoppia una violenta colluttazione. Lewis afferrò Hulme alla gola, ma quest'ultimo lo appese a testa in giù alle cancellate di Soho Square. Non è un caso, quindi, che parta proprio da Hulme l'iniziativa per tradurre in inglese le Riflessioni sulla violenza di George Sorel (in Italia il libro sarà introdotto da Benedetto Croce). Lo storico israeliano Zeev Sternhell dirà che «nessuno, meglio di Hulme, ha saputo individuare con precisione e raffinatezza concettuale la posizione occupata da Sorel nella storia delle idee».
Al teorico del sindacalismo rivoluzionario, Hulme riconosce il merito di aver spezzato il legame tra classe operaia e ideologia democratica. Da qui le incomprensioni a cui va incontro il sorelismo, in quanto, per i progressisti, è «difficile capire un rivoluzionario che è antidemocratico e, assolutista in etica, respinge ogni razionalismo e relativismo, che in materia religiosa considera valido l'elemento mistico “che non scomparirà mai", che parla sprezzantemente del modernismo e del progresso, e usa senza alcun senso di irrealtà un concetto come l'onore».
Poche parole, che sono però il manifesto della filosofia di Hulme. Il pensatore boscaiolo traduce anche Introduzione alla metafisica di Bergson, che ha anche modo di conoscere personalmente e che, come detto, intercederà per lui, definendo Hulme «uno spirito di grande valore» che «apporta allo studio delle questioni filosofiche delle rare qualità di finezza, rigore e penetrazione».
Per l'inglese, invece, Bergson rappresenta «il filosofo che aveva spaccato il monolitico universo positivista ottocentesco». Il pensatore dell'élan vital non è però la sua unica frequentazione francese: nel 1911 Hulme aveva incontrato a Parigi Pierre Lasserre, esponente di spicco dei monarchici dell'Action française. In A note on the art of political conversion, articolo uscito in Commentator nel febbraio 1911, descrive bene lo spirito del tempo del primo Novecento, quando le idee di avanguardia cessarono di essere situate a sinistra. Hulme descrive «lo studente che, arrivando a Londra, si unisce alla Fabian society», cioè ai ranghi della sinistra, e commenta: «Ora, non c'è nulla di inevitabile in questo. […] Le emozioni coinvolte sono abbastanza semplici: un desiderio insaziabile di “teorie", la vaga idea di essere “avanzato"... Non vi è alcun motivo nella natura delle cose per cui l'altra parte non dovrebbe provvedere a questo. In Francia, l'Action française ha reso piuttosto noioso e démodé essere un socialista».
Il nucleo di questa nuova visione del mondo si fonda, per Hulme, su un'interessante interpretazione del peccato originale. La divisione filosofica e politica fondamentale, secondo l'inglese, è quella tra classicisti e romantici. Ora, «tutto il romanticismo scaturisce da Rousseau», scrive Hulme, e in particolare dalla sua idea della originaria libertà e felicità dell'uomo. Ebbene, questa visione ha il difetto di ignorare il peccato originale. «Possiamo allora definire romantici tutti coloro i quali non credono alla caduta dell'uomo». La quale, tuttavia, per Hulme è la condizione di possibilità di ogni eroismo. Proprio perché parte da una condizione di mancanza e di infelicità, l'uomo deve darsi una forma, deve eroicamente sforzarsi di costruire un ordine. Nel suo A tory philosophy, uscito su Commentator nel 1912, Hulme scrive: «L'uomo è per sua natura essenzialmente limitato e incapace di qualcosa di straordinario. È incapace di raggiungere qualsiasi tipo di perfezione, perché, per natura, come risultato del peccato originale o dell'evoluzione, racchiude in sé alcune antinomie. C'è una guerra di istinti dentro di lui, e fa parte delle sue caratteristiche permanenti che debba essere sempre così. La futura condizione dell'uomo, quindi, sarà sempre di lotta e limitazione. I migliori risultati possono essere ottenuti dall'uomo solo come risultato di una certa disciplina che introduce l'ordine in questa anarchia interna. Questo è ciò che Aristotele intendeva dicendo che solo un dio o una bestia poteva vivere fuori dallo Stato. Nulla è male in sé, tranne il disordine; tutto ciò che è ordinato in una gerarchia è buono».
Allo scoppio della Grande guerra, Hulme parte volontario e si arruola nella Royal marine artillery. Al di là di un vitalismo interventista, presto scemato a contatto con la dura realtà della trincea, il filosofo combatte con una motivazione politica: vuole evitare il dominio tedesco sull'Europa. Ma i pacifisti da questo orecchio non ci sentono: «Molti pacifisti», scrive, «concordano con quanto si dice circa l'egemonia tedesca, ne convengono a parole, ma… è come se a un garden party faceste notare a una vecchia signora che a cinque o sei metri c'è un leone in libertà ed essa rispondesse: “Ah sì?", e tranquillamente prendesse un'altra tartina al cetriolo». Ferito nel 1916, torna al fronte e viene colpito a morte da una granata a Oostduinkerke, vicino a Nieuwpoort, nelle Fiandre occidentali. Ha scritto il suo biografo Robert Ferguson: «Il 28 settembre 1917, quattro giorni dopo il suo trentaquattresimo compleanno, Hulme subì un colpo diretto da un grosso proiettile che lo fece letteralmente a pezzi. Apparentemente assorto in qualche suo pensiero, non era riuscito a sentirlo arrivare e rimase in piedi mentre quelli intorno si gettavano a terra. Ciò che restava di lui fu sepolto nel cimitero militare di Koksijde, West-Vlaanderen, in Belgio, dove - senza dubbio per mancanza di spazio - viene descritto semplicemente come “Uno dei poeti di guerra"».