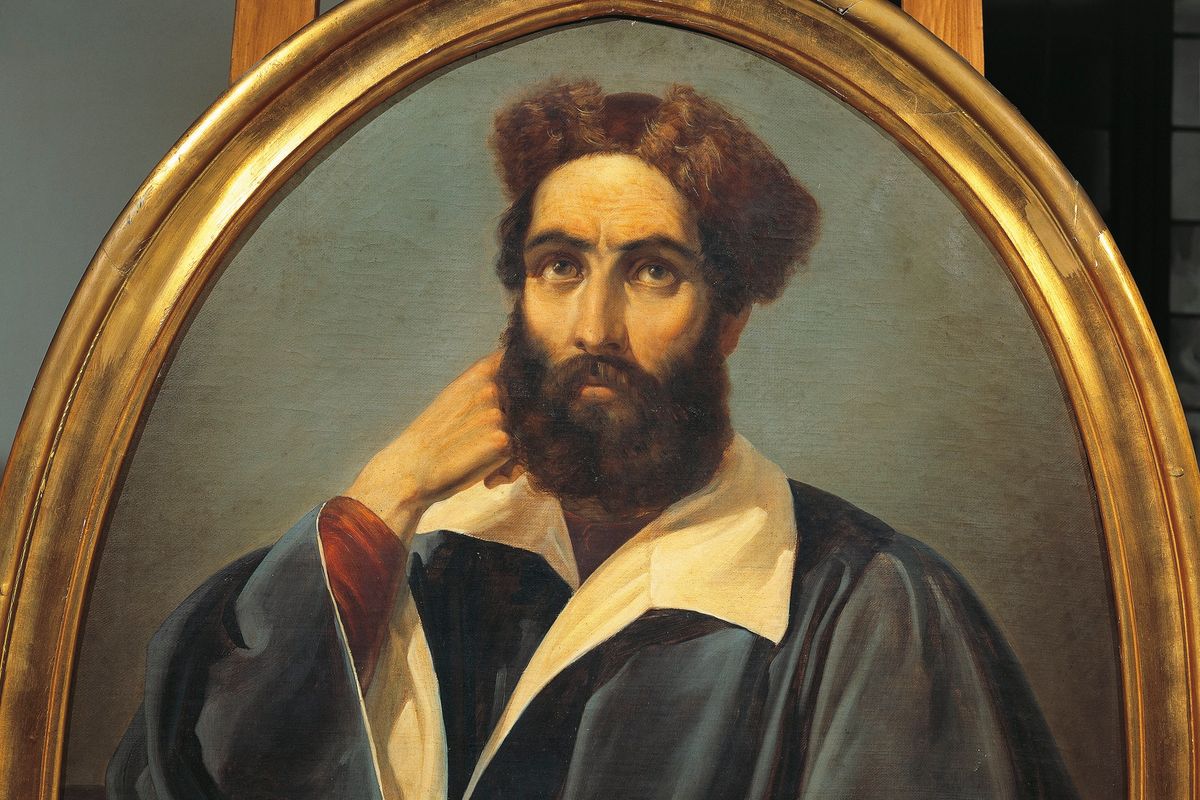True
2020-07-21
L’identità si incideva su oro o su pietra. Ma domani la nostra sarà solo virtuale
Marco Polo (DeA/Getty Images)
Nel 2026 tutti gli italiani avranno in tasca una carta d'identità elettronica. Almeno questa è la previsione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. A oggi è stata richiesta da quasi 16 milioni di cittadini. Il boom è stato raggiunto a inizio giugno, quando il governo ha dato il via libera per richiedere i bonus anti crisi. Oggi sono 7 milioni i cittadini che, oltre alla Cie - questo l'acronimo del nuovo documento -, possiedono anche un'identità digitale. In pratica tutte le informazioni sulla nostra persona vengono racchiuse in un microchip prima e in uno smartphone poi. Ormai tra Cie e passaporti biometrici è possibile prendere un aereo senza mostrare i documenti. Se lo vogliamo - almeno per ora registrarsi è ancora una scelta - lo scanner facciale ci riconosce al nostro passaggio. La Cie, oltre all'identificazione fisica e online, offre anche una serie di servizi come, ad esempio, l'accesso ai siti della pubblica amministrazione, può sostituirsi ai biglietti per mezzi pubblici, stadi e musei, al badge nei luoghi di lavoro, o essere usata come token per una transazione bancaria online. E presto verrà integrata anche con un'app per la firma digitale. Per ottenere una carta d'identità elettronica basta rilasciare le impronte digitali, sottoporsi al riconoscimento facciale, pagare 16,70 euro e in molti casi aspettare pazientemente qualche mese perché i Comuni faticano a smaltire le richieste.
Il primo a citare una carta d'identità in un'opera letteraria fu lo scrittore napoletano Vittorio Imbriani a metà dell'Ottocento, ma bisognerà aspettare il pieno Novecento perché questo documento di riconoscimento sia a tutti gli effetti valido.
In Italia, la carta d'identità cartacea fu introdotta nel 1931 con il regio decreto del 18 giugno. Aveva la foto e durava tre anni. All'epoca, tra le generalità, non c'erano i «segni particolari» bensì i «connotati e contrassegni salienti». Dato che le foto erano in bianco e nero, bisognava definire il proprio colorito «sano» o «naturale». Tra le altre cose si descrivevano anche nasi e menti «regolari» o «pronunciati», corporature «minute», «medie», o addirittura «possenti». Questo tesserino divenne pian piano uno status symbol, con le casalinghe degli anni Quaranta che, alla voce professione, diventavano «attendenti alla casa», e il giovane sottoproletariato degli anni Settanta che, come ricordava Pier Paolo Pasolini, alla qualifica del proprio mestiere preferiva un più nobile «studente».
Finalmente, dopo millenni di studi, la carta d'identità s'era affermata. La prima al mondo nacque su delle tavolette di terracotta. Ad inventarsela fu il governo assiro che distribuì a ogni cittadino queste placche su cui veniva inciso il nome del possessore, il luogo di nascita, la professione e se si trattava di un uomo libero o di uno schiavo. Anche Marco Polo navigò per i mari del mondo con questo prezioso documento: due tavolette d'oro, concesse dal condottiero mongolo Kublai Khan, sulle quali era incisa un'iscrizione che garantiva la sicurezza del navigatore veneziano durante i suoi spostamenti.
Nel Medioevo erano gli abiti a determinare il rango, lo statuto e la dignità della persona. Anche i banditi venivano acciuffati per le loro vesti. Ricorda Valentin Groebner in Storia dell'identità personale che nella città ungherese di Eger, nel 1392, il fuorilegge «Claus Spiler era riconoscibile dalla sua «giacca nera» e dai suoi capelli neri; portava inoltre un berretto e dei calzoni azzurri». O ancora che «nel 1426 il consiglio della città sassone di Rochlitz inviò a Lipsia la confessione di un presunto incendiario» che descrive i suoi complici fuggiaschi: «Il primo portava un mantello grigio rammendato, foderato con un tessuto azzurro intorno al collo, e sotto una giacca di fustagno nera e un cappello a bombetta grigio». Gli abiti servivano anche a riconoscere politici e a identificare i testimoni durante un processo.
Il primo passaporto fu introdotto da Enrico V nel XV secolo. Il re inglese concesse ai suoi sudditi un foglio identificativo che permettesse di dimostrare la propria identità fuori dal Paese. Lo stesso Paese che seicento anni dopo, con Winston Churchill al governo, fu costretto ad abolire la carta obbligatoria perché la richiesta dei documenti da parte degli agenti «minava la fiducia del popolo nelle forze di polizia».
Sui passaporti britannici di un tempo non c'erano né la fotografia né la descrizione fisica. Questi due elementi vennero inseriti nel 1914 dopo che Hans Lody, una spia tedesca, era entrato in Gran Bretagna usando un falso passaporto americano. Le regole sulle fotografie erano molto vaghe. Nel suo The passport: The history of man's most travelled document, Martin Lloyd spiega che alle persone era richiesto solo di mandare un'immagine, «così succedeva che i britannici si ritrovavano sul passaporto il ritratto dell'intera famiglia», probabilmente l'unica foto che possedevano.
I passaporti hanno diversi colori. Quello della Ue è burgundy. Secondo Hrant Boghossian, vicepresidente di Arton group, che ogni anno pubblica il Passport index, questa tonalità di rosso bordeaux «è dovuta a un passato comunista dell'Europa». I passaporti di Marocco, Pakistan e Arabia Saudita sono verdi per via dell'importanza di questo colore nella religione musulmana. Il blu è il colore dell'America e il nero quello dei passaporti diplomatici. Solo il passaporto scandinavo ha tre colori: bianco, turchese o rosso. Nascosta tra le pagine poi si può vedere anche l'aurora boreale. Per farla apparire però bisogna mettere il documento sotto i raggi ultravioletti. Originale anche il passaporto finlandese. Dal 2012 su ogni pagina sono disegnate delle renne in posizioni leggermente diverse e, sfogliandolo velocemente, gli animali sembrano muoversi come in un cartone animato.
Il mito sempre più traballante delle impronte digitali
Fino ai primi anni Duemila, il rilascio della carta d'identità prevedeva solo in via facoltativa l'apposizione delle impronte digitali, che ormai è obbligatoria dai dodici anni in su. Come scriveva Mark Twain, «ogni essere umano porta con sé, dalla culla alla tomba, certe caratteristiche fisiche che non cambiano mai, attraverso le quali può essere sempre identificato, senza ombra di dubbio». E l'unicità delle impronte digitali, che in Occidente fu dimostrata per la prima volta nel XIX secolo dall'anatomista ceco Jan Purkyne, è in grado di distinguere anche due gemelli omozigoti.
Alla fine dell'Ottocento il medico scozzese Henry Faulds tentò di rendere irriconoscibili le proprie impronte digitali sfregandosi le dita con rasoi, pietra pomice, carta vetrata, polvere di vetro, acidi corrosivi. Ma queste, ogni volta, ricomparivano identiche. Quegli esperimenti sollecitarono la fantasia del criminologo francese Alphonse Bertillon e lo portarono a ideare un sistema di riconoscimento biometrico basato su 14 misurazioni alle impronte digitali per incastrare i criminali più recidivi. Tuttavia fu proprio il suddetto Henry Faulds, trasferitosi in Giappone, il primo a individuare il colpevole di un omicidio grazie alle impronte rinvenute sulla scena del delitto. Era il 1880. Entusiasta, decise di condividere la sua scoperta con Charles Darwin e gli mandò una lettera. Lettera che però Darwin, ormai troppo vecchio e malato, girò al cugino Sir Francis Galton, brillante antropologo. Solo dopo otto anni di rilevazioni e calcoli statistici nacque la nuova scienza in Inghilterra.
Nel 1905, i fratelli Stratton, accusati di aver ammazzato i coniugi Farrow, titolari di un colorificio, vennero identificati proprio per aver lasciato le loro impronte digitali e furono condannati a morte. Durante il processo l'ispettore Charles Collins testimoniò: «Il massimo che abbiamo mai riscontrato in impronte differenti è di tre caratteristiche uguali. In altre parole, tutte le impronte con quattro o più punti di contatto devono per forza provenire dallo stesso dito».
Col passare degli anni, a fare delle impronte digitali un vanto è stata l'Fbi, che nel suo Integrated automatic fingerprint identification system, sistema installato nel 1999, ha archiviato più di 65 milioni di impronte per un costo di 164 milioni di dollari. Negli ultimi anni, però, diversi studi hanno sostenuto che la percentuale di falsi positivi - impronte che risultano coincidere anche se in realtà non sono uguali - può arrivare anche allo 0,1%. Spiegava qualche anno fa a Repubblica Mike Silverman, l'esperto che introdusse il primo sistema di rilevamento delle impronte digitali automatizzato per la polizia metropolitana inglese, che non è possibile «dimostrare che non esistono due impronte digitali esattamente uguali. Potrebbe trattarsi di un caso raro, come vincere alla lotteria. È un evento improbabile», eppure a suo dire «accade ogni settimana».
Continua a leggereRiduci
Breve storia dell'identificazione personale, dalle tavolette assire al lasciapassare di Marco Polo. Fino all'odierno chip.Il «calco» del dito è un obbligo all'anagrafe, ma non è affatto esente dai falsi positivi. Con buona pace dell'Fbi (e di Mark Twain).Lo speciale contiene due articoli.Nel 2026 tutti gli italiani avranno in tasca una carta d'identità elettronica. Almeno questa è la previsione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. A oggi è stata richiesta da quasi 16 milioni di cittadini. Il boom è stato raggiunto a inizio giugno, quando il governo ha dato il via libera per richiedere i bonus anti crisi. Oggi sono 7 milioni i cittadini che, oltre alla Cie - questo l'acronimo del nuovo documento -, possiedono anche un'identità digitale. In pratica tutte le informazioni sulla nostra persona vengono racchiuse in un microchip prima e in uno smartphone poi. Ormai tra Cie e passaporti biometrici è possibile prendere un aereo senza mostrare i documenti. Se lo vogliamo - almeno per ora registrarsi è ancora una scelta - lo scanner facciale ci riconosce al nostro passaggio. La Cie, oltre all'identificazione fisica e online, offre anche una serie di servizi come, ad esempio, l'accesso ai siti della pubblica amministrazione, può sostituirsi ai biglietti per mezzi pubblici, stadi e musei, al badge nei luoghi di lavoro, o essere usata come token per una transazione bancaria online. E presto verrà integrata anche con un'app per la firma digitale. Per ottenere una carta d'identità elettronica basta rilasciare le impronte digitali, sottoporsi al riconoscimento facciale, pagare 16,70 euro e in molti casi aspettare pazientemente qualche mese perché i Comuni faticano a smaltire le richieste. Il primo a citare una carta d'identità in un'opera letteraria fu lo scrittore napoletano Vittorio Imbriani a metà dell'Ottocento, ma bisognerà aspettare il pieno Novecento perché questo documento di riconoscimento sia a tutti gli effetti valido.In Italia, la carta d'identità cartacea fu introdotta nel 1931 con il regio decreto del 18 giugno. Aveva la foto e durava tre anni. All'epoca, tra le generalità, non c'erano i «segni particolari» bensì i «connotati e contrassegni salienti». Dato che le foto erano in bianco e nero, bisognava definire il proprio colorito «sano» o «naturale». Tra le altre cose si descrivevano anche nasi e menti «regolari» o «pronunciati», corporature «minute», «medie», o addirittura «possenti». Questo tesserino divenne pian piano uno status symbol, con le casalinghe degli anni Quaranta che, alla voce professione, diventavano «attendenti alla casa», e il giovane sottoproletariato degli anni Settanta che, come ricordava Pier Paolo Pasolini, alla qualifica del proprio mestiere preferiva un più nobile «studente». Finalmente, dopo millenni di studi, la carta d'identità s'era affermata. La prima al mondo nacque su delle tavolette di terracotta. Ad inventarsela fu il governo assiro che distribuì a ogni cittadino queste placche su cui veniva inciso il nome del possessore, il luogo di nascita, la professione e se si trattava di un uomo libero o di uno schiavo. Anche Marco Polo navigò per i mari del mondo con questo prezioso documento: due tavolette d'oro, concesse dal condottiero mongolo Kublai Khan, sulle quali era incisa un'iscrizione che garantiva la sicurezza del navigatore veneziano durante i suoi spostamenti. Nel Medioevo erano gli abiti a determinare il rango, lo statuto e la dignità della persona. Anche i banditi venivano acciuffati per le loro vesti. Ricorda Valentin Groebner in Storia dell'identità personale che nella città ungherese di Eger, nel 1392, il fuorilegge «Claus Spiler era riconoscibile dalla sua «giacca nera» e dai suoi capelli neri; portava inoltre un berretto e dei calzoni azzurri». O ancora che «nel 1426 il consiglio della città sassone di Rochlitz inviò a Lipsia la confessione di un presunto incendiario» che descrive i suoi complici fuggiaschi: «Il primo portava un mantello grigio rammendato, foderato con un tessuto azzurro intorno al collo, e sotto una giacca di fustagno nera e un cappello a bombetta grigio». Gli abiti servivano anche a riconoscere politici e a identificare i testimoni durante un processo. Il primo passaporto fu introdotto da Enrico V nel XV secolo. Il re inglese concesse ai suoi sudditi un foglio identificativo che permettesse di dimostrare la propria identità fuori dal Paese. Lo stesso Paese che seicento anni dopo, con Winston Churchill al governo, fu costretto ad abolire la carta obbligatoria perché la richiesta dei documenti da parte degli agenti «minava la fiducia del popolo nelle forze di polizia». Sui passaporti britannici di un tempo non c'erano né la fotografia né la descrizione fisica. Questi due elementi vennero inseriti nel 1914 dopo che Hans Lody, una spia tedesca, era entrato in Gran Bretagna usando un falso passaporto americano. Le regole sulle fotografie erano molto vaghe. Nel suo The passport: The history of man's most travelled document, Martin Lloyd spiega che alle persone era richiesto solo di mandare un'immagine, «così succedeva che i britannici si ritrovavano sul passaporto il ritratto dell'intera famiglia», probabilmente l'unica foto che possedevano.I passaporti hanno diversi colori. Quello della Ue è burgundy. Secondo Hrant Boghossian, vicepresidente di Arton group, che ogni anno pubblica il Passport index, questa tonalità di rosso bordeaux «è dovuta a un passato comunista dell'Europa». I passaporti di Marocco, Pakistan e Arabia Saudita sono verdi per via dell'importanza di questo colore nella religione musulmana. Il blu è il colore dell'America e il nero quello dei passaporti diplomatici. Solo il passaporto scandinavo ha tre colori: bianco, turchese o rosso. Nascosta tra le pagine poi si può vedere anche l'aurora boreale. Per farla apparire però bisogna mettere il documento sotto i raggi ultravioletti. Originale anche il passaporto finlandese. Dal 2012 su ogni pagina sono disegnate delle renne in posizioni leggermente diverse e, sfogliandolo velocemente, gli animali sembrano muoversi come in un cartone animato.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/lidentita-si-incideva-su-oro-o-su-pietra-ma-domani-la-nostra-sara-solo-virtuale-2646441338.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="il-mito-sempre-piu-traballante-delle-impronte-digitali" data-post-id="2646441338" data-published-at="1595280137" data-use-pagination="False"> Il mito sempre più traballante delle impronte digitali Fino ai primi anni Duemila, il rilascio della carta d'identità prevedeva solo in via facoltativa l'apposizione delle impronte digitali, che ormai è obbligatoria dai dodici anni in su. Come scriveva Mark Twain, «ogni essere umano porta con sé, dalla culla alla tomba, certe caratteristiche fisiche che non cambiano mai, attraverso le quali può essere sempre identificato, senza ombra di dubbio». E l'unicità delle impronte digitali, che in Occidente fu dimostrata per la prima volta nel XIX secolo dall'anatomista ceco Jan Purkyne, è in grado di distinguere anche due gemelli omozigoti. Alla fine dell'Ottocento il medico scozzese Henry Faulds tentò di rendere irriconoscibili le proprie impronte digitali sfregandosi le dita con rasoi, pietra pomice, carta vetrata, polvere di vetro, acidi corrosivi. Ma queste, ogni volta, ricomparivano identiche. Quegli esperimenti sollecitarono la fantasia del criminologo francese Alphonse Bertillon e lo portarono a ideare un sistema di riconoscimento biometrico basato su 14 misurazioni alle impronte digitali per incastrare i criminali più recidivi. Tuttavia fu proprio il suddetto Henry Faulds, trasferitosi in Giappone, il primo a individuare il colpevole di un omicidio grazie alle impronte rinvenute sulla scena del delitto. Era il 1880. Entusiasta, decise di condividere la sua scoperta con Charles Darwin e gli mandò una lettera. Lettera che però Darwin, ormai troppo vecchio e malato, girò al cugino Sir Francis Galton, brillante antropologo. Solo dopo otto anni di rilevazioni e calcoli statistici nacque la nuova scienza in Inghilterra. Nel 1905, i fratelli Stratton, accusati di aver ammazzato i coniugi Farrow, titolari di un colorificio, vennero identificati proprio per aver lasciato le loro impronte digitali e furono condannati a morte. Durante il processo l'ispettore Charles Collins testimoniò: «Il massimo che abbiamo mai riscontrato in impronte differenti è di tre caratteristiche uguali. In altre parole, tutte le impronte con quattro o più punti di contatto devono per forza provenire dallo stesso dito». Col passare degli anni, a fare delle impronte digitali un vanto è stata l'Fbi, che nel suo Integrated automatic fingerprint identification system, sistema installato nel 1999, ha archiviato più di 65 milioni di impronte per un costo di 164 milioni di dollari. Negli ultimi anni, però, diversi studi hanno sostenuto che la percentuale di falsi positivi - impronte che risultano coincidere anche se in realtà non sono uguali - può arrivare anche allo 0,1%. Spiegava qualche anno fa a Repubblica Mike Silverman, l'esperto che introdusse il primo sistema di rilevamento delle impronte digitali automatizzato per la polizia metropolitana inglese, che non è possibile «dimostrare che non esistono due impronte digitali esattamente uguali. Potrebbe trattarsi di un caso raro, come vincere alla lotteria. È un evento improbabile», eppure a suo dire «accade ogni settimana».
«Io non credo nell’ipotesi che gli Usa avviino un’azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei» e «che non converrebbe a nessuno». «L’ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stata esclusa da Rubio e dallo stesso Donald Trump. Io credo che l’amministrazione Trump, con i suoi metodi molto assertivi, stia ponendo l’attenzione sull’importanza strategica della Groenlandia per i suoi interessi e per la sua sicurezza. È un’area in cui agiscono molti attori stranieri e credo che il messaggio degli Usa è che non accetteranno ingerenze eccessive di attori stranieri». Così il premier Giorgia Meloni nella conferenza di fine anno.
L’attività è il risultato di un’intensa attività di controllo effettuata sulle rotte commerciali che collegano il Sud America con il porto di Genova, che storicamente rappresenta un crocevia dei flussi commerciali per l’Europa.
I 2.380 kg di droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno a 1,5 miliardi di euro.
Il sequestro si inserisce nel quadro di una costante e mirata azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti finalizzata a proteggere le fasce più deboli della popolazione, spesso esposte agli effetti nocivi del traffico criminale di droga.
Ancora una volta, la collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituisce un prezioso baluardo per la sicurezza dei cittadini e per il mantenimento dell’ordine pubblico.
Continua a leggereRiduci