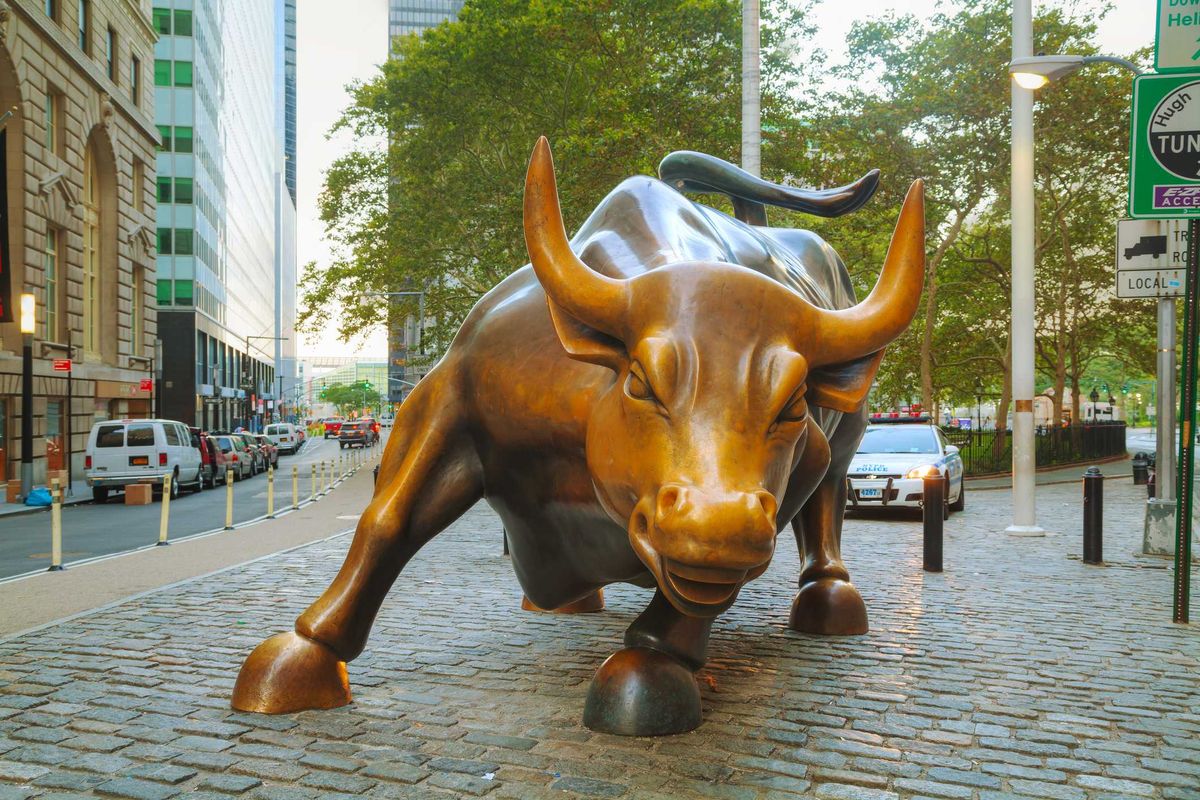2019-07-09
L'eredità del programma Apollo
True
Medicine, batterie, circuiti integrati, aspirapolvere in miniatura, chiusure a velcro, materiali isolanti e altro. Dalle missioni lunari l'umanità ha avuto molto. E parte di queste invenzioni furono studiate per un'auto elettrica che doveva viaggiare senza ossigeno su un terreno ignoto, a temperature glaciali come infernali.I tre esemplari del veicolo lunare portati in missione costarono alla Nasa quasi 39 milioni di dollari e furono usati per percorrere in tutto circa cento chilometri. Praticamente 390.000 dollari ogni mille metri di strada sul suolo lunare. Questi numeri oggi appaiono folli, ma la sfida prima, e la ricaduta tecnologica poi, prodotte dalla necessità di dotare gli astronauti dell'Apollo 15, 16 e 17 di un veicolo su ruote, hanno donato all'umanità congegni che ci hanno migliorato la vita. L'auto elettrica nacque tra il 1832 e il 1839 grazie alle costruzione dello scozzese Robert Anderson e a quelle degli olandesi Sibrandus Stratingh e Christopher Becker. Ma a vederlo oggi presso lo Smithsonian Air and Space Museum di Washington, il progetto "Lrv, da Lunar Roving Vehicle" stupisce ancora per le soluzioni tecniche adottate. A cominciare dall'avere i motori elettrici all'interno delle ruote, un sistema di navigazione inerziale miniaturizzato (il Gps arriverà nel 1989), e uno di radiocomunicazione per l'epoca avanzatissimo. In pratica quando Armstrong, Aldrin e Collins erano sull'Apollo 11, lo Lrv era già quasi pronto grazie alla genialità di un tedesco, Georg Heinrich Patrick von Thiesenhausen (1914 – 2018), che lavorava per Boeing e General Motors. Ebbe l'idea di mettere un motore da 0,58 cavalli e 10.000 giri al minuto, con riduzione 80:1, dentro il cerchio in alluminio e di far costruire pneumatici con struttura sintetica e rivestiti di lamelle in acciaio e tasselli titanio, che potessero reggere alle pietre lunari e a temperature comprese tra 300 e -200 °C. Avevano un diametro di 81,8 cm e una larghezza di 23 cm. Come le tute degli astronauti, le ruote non potevano durare a lungo, ma al contrario di queste non si potevano neppure analizzare una volta tornati a terra, e sono ancora oggi parcheggiati sulla Luna. Poco più di mezzo cavallo per ruota era tuttavia una potenza sufficiente per garantire i 13 km/h previsti di velocità massima; con la gravità ridotta a un sesto di quella terrestre lo Lrv diventava un fuoristrada 4x4 con ottime prestazioni grazie anche alle sospensioni realizzate mediante tubi di torsione. Niente volante: un joystick, e niente sterzo: per curvare le ruote interne rallentavano opportunamente come sui cingolati e consentivano un raggio di sterzata di 3,1 metri. In realtà oltre i 5-6 km orari mantenere il controllo si rivelò problematico a causa delle asperità del terreno lunare e la poca gravità che facevano sobbalzare l'Lrv fin quasi a perderne il controllo. Gli equipaggi si affaticavano parecchio alla guida tanto che non fecero mai più di 40 dei 100 chilometri garantiti dalle batterie all'argento-zinco da 36,5 Volt e 121 Ampére/ora, non ricaricabili ma leggerissime, che aprirono la strada alle prime celle ad alta efficienza della storia moderna.Il record di utilizzo del mezzo fu dell'equipaggio di Apollo 17, che nel tempo della missione percorse 35,9 km in 4 ore e mezza allontanandosi dal Lem 7,6 chilometri, con un viaggio di 20 km in un solo giorno. Per rimanere seduti con le tute di sopravvivenza gli astronauti dovevano legarsi stretti ai seggiolini ripiegabili in nylon e alluminio, mediante cinture in velcro e non esagerare con la velocità poiché, nonostante i grandi parafanghi dello Lrv, la polvere lunare, particolarmente abrasiva, veniva scagliata contro le tute rovinandole al punto da poter creare danni letali per l'occupante. Se oggi per arrivare a destinazione chiediamo a Google di guidarci, sulla Luna il navigatore era del tipo inerziale, cioè basato sulle proprietà dei giroscopi allineati alla partenza dal Lem. Entro un determinato periodo di tempo il sistema riusciva a determinare la direzione per tornare all'astronave quando questa era oltre la visuale dell'equipaggio, tra colline e rilievi. Anche comunicare era un'impresa, uno dei due astronauti a bordo doveva infatti navigare e, in base alla direzione presa, anche mantenere la telecamera orientata a dovere e l'antenna simil-parabolica puntata verso il modulo di comando in orbita che fungeva anche da ripetitore verso Houston. Tra le caratteristiche più interessanti del mezzo, lungo 310 cm e largo 230, con un'altezza dal suolo di 36 cm, c'era il telaio in tubi di alluminio saldati tra loro (in quegli anni saldare l'alluminio non era banale), la ,disposizione dei congegni di bordo davanti e sotto il pianale e il peso del veicolo rapportato a quello del materiale trasportabile: 210 kg lo Lrv, 490 kg quello del carico permesso. Il telaio era ripiegabile e viaggiava fino alla Luna appeso alla struttura del Lem con la parte inferiore verso l'esterno. Una volta allunati, uno dei due astronauti risaliva sulla scaletta del modulo lunare e liberando le cinghie calava al suolo il veicolo, mentre il suo collega ne controllava la discesa mediante altre cinghie. Le ruote posteriori erano ripiegate e dovevano essere aperte e bloccate prima di posarsi. Una volta completata l'operazione, l'astronauta sulla scaletta doveva ridiscendere e attendere che il collega, azionata l'elettronica del veicolo, tornasse a prenderlo. Per guidare lo Lrv si utilizzava una leva posta tra i sedili. Spostandola in avanti o indietro ci si muoveva in quella direzione e si frenava, lateralmente si sterzava e, premendo un pulsante e spostandola ancora indietro si faceva retromarcia. Davanti all'impugnatura erano posizionati gli indicatori di velocità, potenza e temperatura delle batterie, ed anche un dispositivo definito sole-ombra, che mediante la posizione del sole aiutava a mantenere l'orientamento oltre al giroscopio.
Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali.