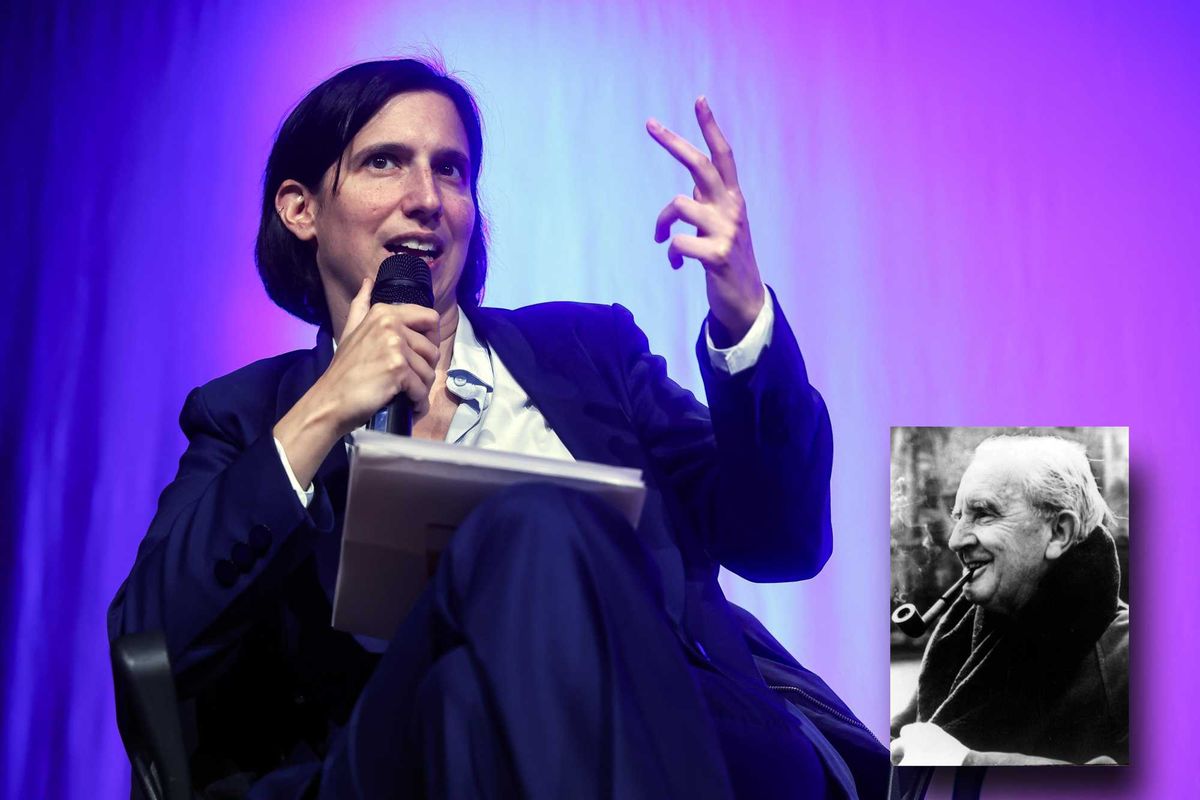Il Sagrantino, intenso e raro, gira lento e armonico nel bicchiere a disegnare la circonferenza dei ragionamenti. Il vino è anche questo: corrobora l’incontro, illumina le intuizioni, dà calore alle parole. Leonardo Valenti, il professore come lo chiamano in cantina qui a Montefalco, è parmense d’Appennino e non è un dettaglio. Significa avere eleganza di pensiero, risolutezza d’intenti, negazione d’orpelli, ma inclinazione quasi inconsapevole al buono della vita. «E della vite», precisa per entrare subito in argomento. Al vino ci è arrivato per convinzione, la prima opzione e la passione restano la terra, il coltivo, lo scrutare dentro il mosaico della campagna la tessera che dà luce all’opera e promette sviluppo. «Sì», racconta incorniciato da una barba sale e pepe e con le mani in moto perpetuo che paiono la bacchetta del direttore che orchestra lo spartito dei ragionamenti, «la campagna è stato l’innesco di un amore che si è fatto studio, l’agronomia è lo strumento di conoscenza che permette di indagare come uomo e natura incontrandosi possano generare giusto profitto rispettandosi, l’enologia è la finalizzazione di questo percorso».
Insegna viticoltura alla Statale di Milano, ha firmato alcuni dei grandi vini d’Italia, tra questi il Sagrantino, come consulente di aziende vitivinicole, ed è autore di una rivoluzione culturale: avere imposto agli enologi di conoscere la vigna per conservare al vino l’anima agricola. Questa conversazione è la dimostrazione di come le minacce possano diventare opportunità, ma di come le esagerazioni fanno deviare dalla giusta strada. È un estratto di saggezza contadina.
Professore lei ha dimostrato che il cambiamento climatico per chi fa vino è un’opportunità. Come ha fatto?
«Non l’ho dimostrato; col contributo di molti, a cominciare da Marco Caprai e dalla famiglia Colaiacovo per continuare con i miei colleghi di università e l’impegno della Regione Umbria, ho cercato una soluzione che potesse dare vantaggio. In questo caso duplice: ricoltivare terre abbandonate, fertilizzare di nuova presenza umana i territori montani».
Dunque l’ossessione climatica si può battere?
«Le ossessioni non portano mai buoni frutti. L’allarme sul clima ha indotto molti a domandarsi se c’era o no bisogno di agire. E molti, per fortuna, hanno riposto sì. Non voglio entrare nella disputa se l’innalzamento delle temperature sia o no, o perlomeno in che grado, colpa dell’uomo. È terreno per altri studiosi e francamente mi pare che i toni non siano quelli giusti. A me interessa sapere un’altra cosa: che ogni cento metri di altitudine che si guadagna alla viticoltura è un grado in meno di temperatura in vigna. E da lì è partito il progetto Spume che si prefigge di fare un grandissimo spumante in Appennino per recuperare territorio e riportare popolazione in montagna. Per dare corpo a questo progetto siamo partiti non come si racconta in genere dallo studio dei suoli, siamo partiti dallo studio del clima. E in questa misura l’allarme climatico ci ha aiutato. Quando sollecitato da Marco Caprai, con cui a Montefalco abbiamo condotto studi lunghi e rigorosi sul Sagrantino e la vitienologia umbra, sono venuto qui a Sermonte, nella bella cantina dei Colaiacovo, ho chiesto se sopra a Gubbio dove loro stanno avevano della terra disponibile. C’era a quasi 900 metri d’altitudine e così ho chiesto a Gabriele Cola che è un mio collega agro-meteorologo dell’università di studiare il clima di questo podere San Marco. È venuto fuori che ci sono le stesse caratteristiche di Epernay: il cuore dello Champagne. Di conseguenza abbiamo piantato Pinot Nero e Chardonnay base spumante e stiamo facendo un ottino prodotto. Ottimo anche perché, e questo è il compito di un altro mio collega dell’università di Milano, il professor Stefano Corsi, stiamo studiando quanta popolazione nella zona eugubino-gualdese è interessata a tornare in montagna per fare coltivazioni ad alto reddito come la viticoltura. La Regione Umbria ha capito la centralità di questo progetto e lo porta avanti per farlo diventare patrimonio comune».
Ma è esportabile in altre zone?
«Certo che sì. L’Appennino è una straordinaria opportunità per l’Italia e in particolare per l’Italia del vino. Si può, come ho detto, salire di quota per trovare le temperature ideali e acquetarsi dall’ansia da riscaldamento globale. In più l’Appennino per la sua conformazione e la sua estensione è la spina dorsale dell’Italia, ha accessi facili, non è come le Alpi che s’impennano anche se in Alto Adige stanno facendo grandi vini, e si può ripopolare la montagna. Bisogna farlo perché la terra va manutenuta. Se si fanno coltivazioni con cui si guadagna, ma richiedono impegno costante – la vite, l’olivo, la frutta – così come la zootecnia, si ottiene il risultato di sorvegliare la montagna e ci si difende dalle alluvioni e dagli incendi dei boschi perché si mantiene il presidio antropico. A chi torna in montagna bisogna assicurare servizi e pari, se non addirittura migliore, qualità della vita di chi sta in pianura. Ma se si vuole salvare il territorio e dare nuove opportunità di lavoro si deve andare in quella direzione. Io ho un po’ di terra nell’Appennino parmense: lì fino a trenta anni fa c’erano famiglie che avevano venti vacche, un po’ di maiali, che facevano l’orto, i solchetti di scolo, che sorvegliavano l’ambiente. Ora è sparito tutto: tornare a quel modello, adeguandolo all’oggi con l’agricoltura di precisione, con condizioni di pari dignità sociale ed economica per chi coltiva, significa inventare futuro».
Eppure a Barolo, in Langa, l’idea di coltivare l’uva sui bricchi esposti a Nord è stata accolta come un’eresia…
«Si dovranno ricredere. L’aumento delle temperature è un dato reale; la vecchia regola: i bianchi si piantano all’ombra e in alto, i rossi al sole e in basso non vale più. Oggi bisogna studiare attentamente il territorio: salvaguardarlo e usarlo bene. Perché a dare valore al vino è il territorio, com’è vero che solo il vino dà valore ai territori».
I salumi e i formaggi no?
«Certo anche quelli, ma sono come il vino prodotti che richiedono sapere unendo in un’espressione culturale territorio, coltivazione e trasformazione».
Tornando alla vigna: non ha bisogno come tutte le piante della CO2 per vivere? Questa demonizzazione delle emissioni non è un danno per l’agricoltura?
«La CO2 è il pane delle piante, più ne hanno più sono contente. Il problema però è se ce n’è troppa cosa succede all’ecosistema. E credo che gli allarmi abbiamo svolto una funzione: ci guidano alla consapevolezza per esempio di risparmiare acqua; non c’è bisogno di tenere il rubinetto aperto mentre si usa il dentifricio! Io vivo a Milano e ci vivo benissimo, ma cerco di non usare l’auto. Non perché è di moda, semplicemente perché visto che abito vicino all’ufficio me lo posso permettere. Però sono consapevole che ci guadagno: in salute e in quattrini. Allo stesso tempo però capisco e non condanno chi deve usare la macchina. I toni esasperati finiscono per non fare capire nulla. Mia nonna sapeva adoperare gli avanzi in cucina, usava gli scarti come concime. Era ecologista? No, semplicemente faceva per il meglio. Col letame si fanno ottime coltivazioni. Noi abbiamo stressato molto i terreni con la chimica, bisogna tornare a “ingrassarli” naturalmente. Dunque se gli allarmi hanno prodotto un’attenzione va bene, ma ora bisogna tornare al buon senso, al buon padre di famiglia. Quanto alla vigna anche lei assorbe CO2. La vite è una liana e ogni anno noi la potiamo, dunque lei immagazzina CO2 solo nel fusto, però possiamo dire che la produzione del vino è sostanzialmente neutra rispetto alle emissioni. Peraltro avere una foot print carbonica neutrale aiuta molto a vendere su certi mercati e le aziende si stanno adeguando. Tutta l’agricoltura arborea assorbe CO2 in grande quantità. È un altro vantaggio di un progetto come Spume».
Da un’emergenza all’altra: quella dell’immigrazione. Anche per questa la viticoltura è diventata una risposta. Marco Caprai, che produce questo Sagrantino e con il quale lei ha collaborazione trentennale, alcuni giorni fa è stato insignito dal presidente Sergio Mattarella del titolo di ufficiale al merito della Repubblica proprio perché ha inserito migranti in azienda. È questo il futuro?
«Anche qui siamo al buon senso. Sappiamo che ci manca la manodopera: entro un decennio avremo bisogno degli immigrati in campagna per ogni coltivazione. Ma dobbiamo formarli e pagarli. Marco Caprai ha fatto questo. In vigna non puoi lavorare senza competenze, in campagna non puoi fare il trattorista se nessuno te lo insegna. Per esempio: c’è la risorsa bosco ora abbandonata. Nel mio terreno ho fatto pulire i castagneti, ho fatto curare i miei venti ettari di bosco, ma fatico a trovare chi lo sa fare. Se i migranti li fai arrivare e basta, non ne selezioni le capacità e non le incrementi, non riuscirai mai ad integrarli, ma se li formi e li fai lavorare vinciamo in due: loro che si garantiscono un futuro, noi che garantiamo un futuro all’agricoltura».
E i nostri giovani?
«Eccolo il futuro! A lezione ci sono tanti ragazzi disposti alla fatica della campagna, anzi affascinati dalla fatica della campagna. L’arrivo dei migranti peraltro non è in competizione con loro, semmai è complementare. Ci sono tante aziende agricole in mano a giovani laureati e sappiamo che la competenza incrementa di molto la redditività dell’azienda agricola. Ma dobbiamo restituire a questi giovani il giusto guadagno e l’orgoglio del ruolo: l’agricoltore colto ed evoluto è custode del territorio, ne fa la manutenzione e lo sfrutta con responsabilità e rispetto a beneficio di tutti».
Sarà l’effetto del Sagrantino, ma questa chiacchierata ha il retrogusto del buonsenso.