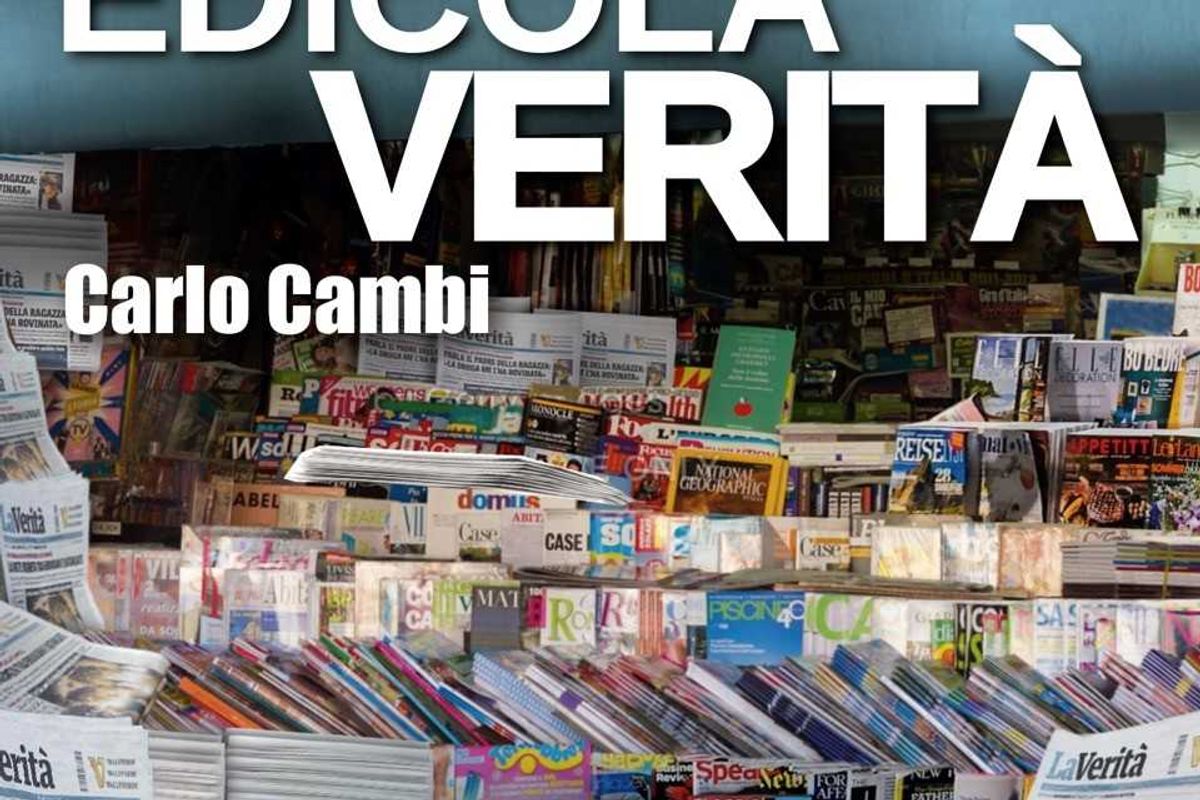L’emergenza clima? Un’esagerazione. Come lo spauracchio delle emissioni

Ogni giugno, puntuali come la morte, due tragedie colpiscono l’Italia: gli esami di maturità e l’estate. Non sarebbero tragedie, se il Quarto potere non le raccontasse tali. E non c’è nulla che tu possa fare per ammorbidire l’uno o l’altro di questi eventi. Oltre 30 anni fa volli fare l’esperienza del presidente agli esami di maturità, che a quei tempi consistevano di due prove scritte e di un esame orale su due materie, una scelta dallo studente e l’altra dalla commissione. Al primo giorno di riunione davo le direttive, che furono:
1 nessuno sarà bocciato.
2 Il voto sarà deciso prima ancora che comincino gli esami; all’uopo presentavo la lista degli studenti col loro voto già deciso, e che avevo assegnato sulla base delle pagelle dei tre anni precedenti e del primo quadrimestre dell’ultimo anno; il voto finale - dissi - sarà quello con un massimo di 5 punti di incertezza, decisa dall’esito delle prove d’esame.
3 La materia che deve scegliere la commissione la sceglierà la commissione, cioè io presidente la propongo e la commissione delibera; assicuravo che avrei proposto una materia ove lo studente aveva già dimostrato di sapersi far valere.
Pensavo di aver smorzato i toni da tragedia che giornali e telegiornali tenevano alti, e invece no: la semplice direttiva «la materia d’esame che deve scegliere la commissione sarà scelta dalla commissione» trasformò la tragedia mediatica in tragedia greca. Per farla breve, la mia commissione finì sulla prima pagina del giornale locale. Il titolo: «Al liceo scientifico Oberdan di Trieste sarà la commissione d’esame a scegliere la materia d’esame che deve scegliere la commissione d’esame».
L’altra grande tragedia del giugno italiano è l’avvento dell’estate e, con essa, del caldo. Che è come allarmarsi per l’avvento della sera e, con essa, del buio. Anche qui è un problema tutto del povero titolista, che deve inventarsi titoli adeguati, da scoop, per articoli pubblicati in prima pagina e che, in quanto tali, meritano, appunto, titoli confacenti. Alcuni esilaranti, come quelli che lo scorso 30 giugno addebitavano alla fusione dei tubi di sostegno il crollo dell’insegna Generali a Milano.
Un tg della sera di giovedì 3 luglio voleva corroborare i propri apocalittici titoli con l’intervista a un esperto. Dio ci guardi dagli esperti. Ecco le sue parole: «Le politiche di mitigazione non stanno funzionando come dovrebbero. Cosa fare? Dobbiamo ridurre le emissioni di CO2, evitare di bruciare carbone e gas, produrre energia dalle fonti rinnovabili e applicare in maniera massiccia le regole dell’economia circolare». Parole che sono di conforto, perché - anche se non era nelle intenzioni di chi le formulava - ci garantiscono che non c’è alcuna emergenza, giacché se ci fosse l’esperto avrebbe formulato la soluzione dello stesso, anziché proporre misure che egli stesso aveva premesso che non stavano funzionando.
Possiamo dirimere la questione se c’è o no emergenza? Beh, sì. Mi sono inventato un test, un po’ casalingo se volete, ma giudicate voi. Ho scelto sei città: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo; ho poi tirato un dado che ha scelto per me: Napoli. Quindi ho scelto un giorno dell’anno, uno dei più caldi a Napoli in questo 2025: il 1° luglio. Mi sono così industriato a raccogliere le temperature di Napoli del primo di luglio degli ultimi 50 anni. I dati, facilmente reperibili su vari siti, per esempio Meteo.it, forniscono le temperature minima, massima e media di tutti i giorni dal 1973 a oggi. M’è sembrato opportuno focalizzarmi sulle temperature massime. Oltre a dirci che non c’è nulla di nuovo sotto il sole, i dati in tabella ci dicono molte altre cose.
Si osserva una tendenza al riscaldamento, cosa che sappiamo già. La pendenza calcolata (quasi 6 centesimi di grado per anno), non deve però allarmare e, soprattutto non deve farci concludere che il futuro evolverà con questa pendenza (cioè che fra 100 anni a Napoli la temperatura massima sarà 6 gradi più elevata). Degli anni qui considerati, quelli di riscaldamento sono stati, anche a livello globale, soprattutto gli anni 1980-1998, e a essi seguirono anni di «hiatus» climatico: si vede bene in figura e se si ricalcola la pendenza dal 1998 a oggi essa è addirittura negativa, 7 millesimi di grado per anno, per la precisione; il che non deve farci parimenti concludere che fra 1.000 anni la temperatura massima a Napoli sarà 7 gradi più bassa. Prima regola: mai estrapolare nel futuro i dati su un intervallo limitato.
Se il giorno del 1° luglio il napoletano del 2025 è stato esposto a temperature fino a 34 gradi, quello del 1998 era stato esposto a temperature fino a 36,3 gradi, e il napoletano del 1994 fino a temperature di 37 gradi. Anzi possiamo senz’altro affermare che, almeno a Napoli, il 1° luglio di tutti gli anni successivi al 1994 è stato più «fresco» del 1° luglio del 1994. Seconda regola: studiare il passato.
Dov’è l’emergenza? In senso di «novità» non c’è alcuna emergenza. Certo, il caldo può essere fastidioso e, a volte, anche fatale. Come fastidiose, e a volte fatali, sono certe conseguenze: siccità, grandinate repentine e inondazioni. Fastidi e fatalità che però sono purtroppo affrontati seguendo i consigli di quegli «esperti» che, come quello citato sopra, ancora credono alla favola della CO2.