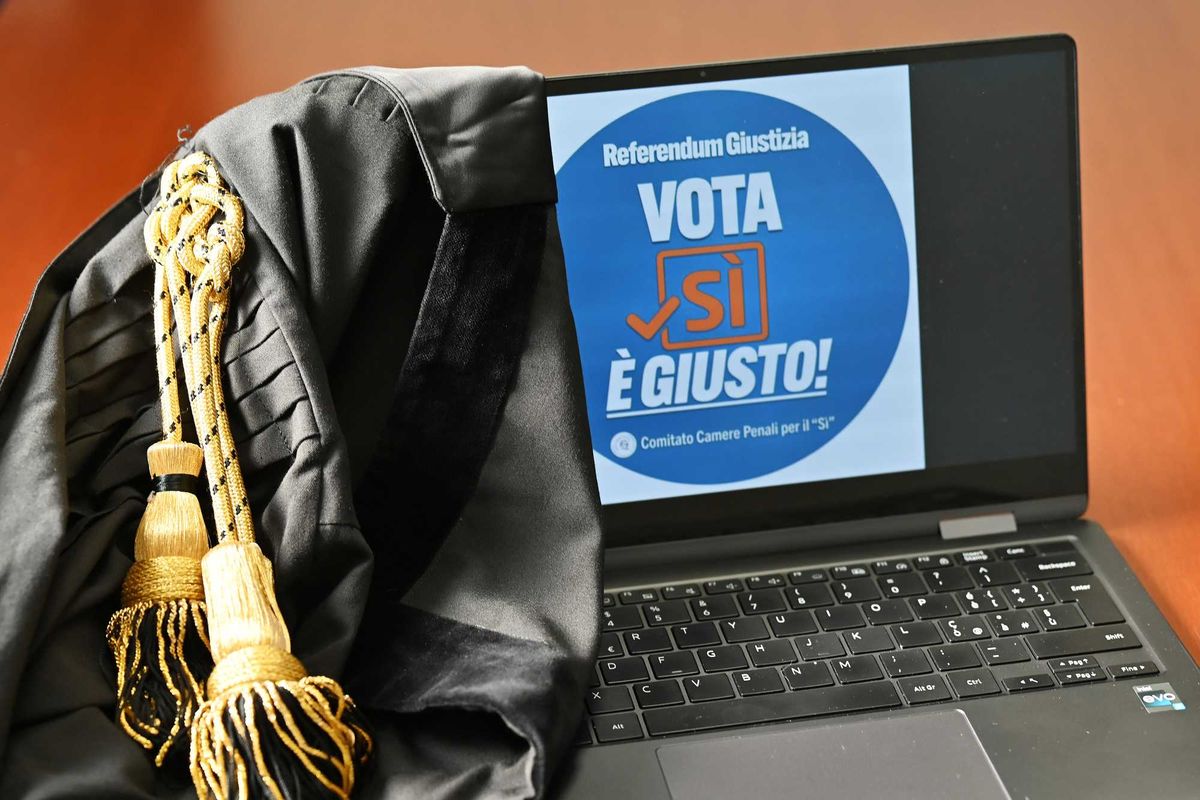Lo scopo del diritto è tutelare i deboli. Una legge sul fine vita fa il contrario

Probabilmente tanti degli attuali parlamentari, non avendola vissuta, non hanno sufficiente consapevolezza di come sia avvenuto e di che cosa abbia comportato la legalizzazione dell’aborto, da un punto di vista sia, ovviamente, giuridico, sia sociale e sociologico. Il tutto, oltre che per l’iter che condusse, subdolamente, alla sua frettolosa approvazione, anche e soprattutto per le sue conseguenze devastanti.
Infatti essa - figlia della cultura del liberalismo solipsista «radicale», basata sull’individualismo utilitarista che conduce al darwinismo sociale e alla cultura dello scarto - finisce, entro un circolo che si autoalimenta, a far da volano a sua volta a tale prospettiva, i cui nefasti effetti si vanno sempre più palesando sia in campo giuridico che sociale-sociologico, etico ed economico.
Senza una tale consapevolezza da parte dei parlamentari in parola, diversamente, non si giustificherebbe tanta fretta nel portare a breve all’esame dell’aula una proposta il cui esito molto probabilmente sarà la legalizzazione del suicidio assistito, in presenza dei requisiti indicati dalla Consulta (sentenza 242/2019).
Non si giustificherebbe perché una legge di tal fatta non è urgente, non è necessaria, genera conseguenze dannose e capovolge il senso del diritto.
Non è urgente, come si evince da «L’attività della Corte nel 2019», in cui Marta Cartabia, presidente della stessa Consulta, afferma: la Corte «individua nella legislazione vigente una risposta costituzionalmente adeguata, anche se non obbligata, applicabile in via transitoria fintanto che il legislatore non reputi opportuno mettere mano alla riforma legislativa che resta pur sempre nella sua discrezionalità attivare nell’an, nel quando, nel quomodo».
Perché allora, in luogo di una corsa del tutto ingiustificata, viste le altre pressanti esigenze del Paese e attesa la particolare delicatezza della materia, non si dà corso a una sperimentale applicazione transitoria, che consentirebbe di correggere eventuali storture emerse nel suo percorso?
Come se non bastasse, la proposta di legge in esame non è nemmeno necessaria, perché la citata sentenza della Corte costituzionale è autoapplicativa, può cioè trovare immediata attuazione, senza alcuna modifica normativa (sul tessuto normativo ha infatti inciso già la stessa Corte).
Entra qui in gioco la fondamentale funzione del giudice del procedimento penale (per il reato ex art. 580 cp), cui spetta un «controllo serio e sostanzialmente “restrittivo” sull’esistenza dei requisiti condizionanti la non punibilità» e sul fatto che la loro sussistenza «sia stata oggetto di verifica da parte di strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale e che sia stato acquisito il parere del Comitato etico territorialmente competente su tutte le circostanze e la dinamica del fatto» (Servizio studi della Corte costituzionale, febbraio 2021).
Mi pare evidente il rischio, volendo legiferare sul punto, di generare una sorta di bulimia legislativa, già avviata con la legge 219/2017 (Dat), destinata a burocratizzare il rapporto medico-paziente, a beneficio di una medicina di Stato sempre più disumana, meccanicistica, basata sulla mera proceduralizzazione! Lo comprova «la circostanza che, negli ordinamenti giuridici ove si legalizzano l’eutanasia o si approva il testamento biologico, la manifestazione del consenso informato è soggetta a procedure laboriose e formalistiche, di regola gestite da organi pubblici» (P. Moro, Dignità umana e consenso all’atto medico, p. 142)
Ma, soprattutto, una legislazione in materia sarebbe foriera di conseguenze assai dannose. Ce lo insegnano i Paesi in cui il suicidio assistito è legge (per esempio Canada e Paesi Bassi), nei quali, aperto il pertugio relativo ai casi limite, esso si è trasformato in voragine, al punto che oggi viene spesso richiesto anche da chi soffre di depressione o semplicemente da chi ritiene di sentirsi di peso (altro effetto indotto di legislazioni di tal fatta).
Ce lo insegna la legalizzazione dell’aborto, i cui esiti, nella sola Italia, sia in termini di vite umane sia di aumento della cultura dello scarto, sono evidenti a tutti. In tal modo, un fatto che è socialmente disdicevole diviene socialmente accettato, finanche doveroso. E così si mutano il modo di pensare delle persone e dei popoli e i criteri del giudizio morale e giuridico.
Mi pare evidente che i passaggi attraverso i quali si opera, surrettiziamente, tale stravolgimento etico, possono riassumersi mediante la normalizzazione, in un crescendo evidente: a) il suicidio non va punito; b) deve essere legittimato giuridicamente; c) deve essere assicurato dal servizio sanitario; d) è un diritto; e) è moralmente accettabile. Analogamente per l’eutanasia. Così il male è chiamato bene e il bene male.
In tal modo operando, viene capovolto anche il senso del diritto. Con la sua funzione antropologica, quale strumento di tutela dei deboli, il diritto educa al senso del limite. E il limite per eccellenza è la dignità, che è unica e incommensurabile per ogni essere umano, indipendentemente dal fatto che sia sano o malato. Quando, malato o sfigurato, è più difficile vederne la dignità, deve entrare in gioco il diritto, tutelando il debole, talora anche da sé stesso.
Una legge che legalizzasse il suicidio assistito trasformerebbe il diritto da custode del limite a sostegno dell’autodeterminazione dell’uomo che non accetta limiti. E la dignità non sarebbe più coessenziale alla natura dell’uomo, bensì alla sua capacità di autodeterminarsi.
Si perde così il significato del limite, che non è ostacolo bensì - sulla scorta dell’antico mito delle Parche (le sole autorizzate a recidere il filo della vita) - monito che vi è qualcosa di indisponibile sia per il singolo sia per la collettività, che ci pone la domanda su cosa è lecito fare.
Perché non si legifera invece in positivo, riaffermando il favor vitae che pervade la nostra Costituzione e approntando un sistema organico di accoglienza, cura, assistenza, riabilitazione per i più fragili, a partire da cure palliative spalmate sull’intero territorio nazionale?
Così si fece come Mpv nel 1977, in tema di vita nascente, con una legge di iniziativa popolare (1.200.000 firme in un mese!), che fu bloccata solo a causa della corsia preferenziale assicurata alla legge 194/78. È in gioco il grado di civiltà del nostro Paese.