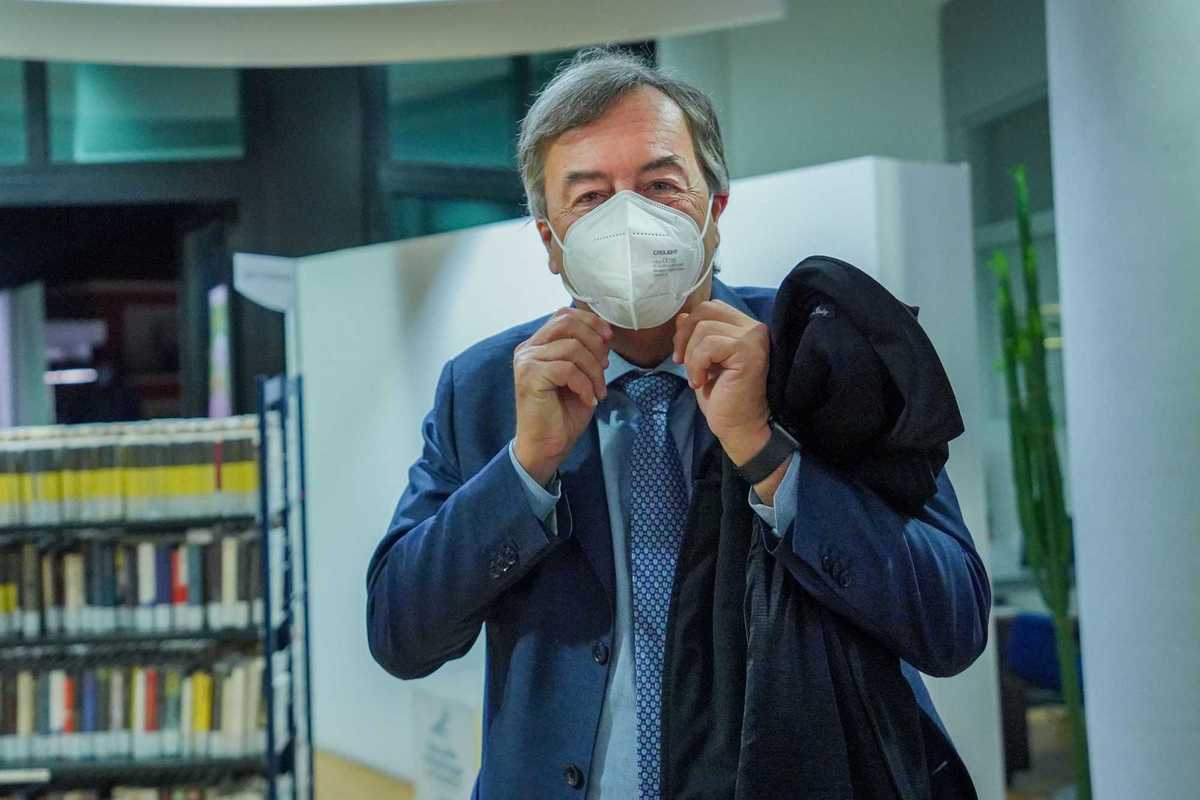True
2020-10-11
Le priorità dei giallorossi. Pillola alle minorenni, eutanasia e bavaglio Lgbt
Qualcuno, nottetempo, deve avere scombinato l'agenda della compagine giallorossa, creando una totale confusione e invertendo l'ordine delle priorità. Altrimenti non si spiega l'assurdità di alcune esternazioni e, soprattutto, l'ossessiva ostinazione con cui i nostri eroi si battono per alcune cause completamente altre. Il governo, tanto per fare un esempio, è in clamoroso e drammatico ritardo su tutto ciò che riguarda il (reale) contrasto al coronavirus: potenziamento di terapie intensive e subintensive, generale riassetto del sistema sanitario, messa in sicurezza delle scuole, reclutamento di nuovi insegnanti...
Disastro anche su un altro tema almeno in parte connesso all'epidemia, ovvero l'immigrazione. Non è vero, come sostiene l'esecutivo, che gli sbarchi si siano arrestati. Proseguono e siamo a quota 24.505 arrivi nel 2020 contro i 7.939 di un anno fa. Nel frattempo la gestione degli stranieri contagiati si è rivelata del tutto inadeguata, con punte di orrore come la morte di un ragazzino di 15 anni ospitato su una nave quarantena. Registrati i fallimenti su due questioni centrali, bisogna prendere atto che i demostellati sono invece attivissimi su quelli che in genere si indicano come «temi etici».
Giusto ieri il presidente della Camera, Roberto Fico, ha preteso un impegno del Parlamento affinché si «diano risposte». Su cosa? Forse sui docenti che mancano? Ma no! Sul fine vita, che diamine. Fico ha inviato un messaggio al XVII Congresso dell'associazione Luca Coscioni carico di emozione. «Le vostre battaglie, i temi rispetto a cui coraggiosamente avete portato avanti tante campagne, sono un costante pungolo per la politica e per l'intera società», ha scritto. «Penso a quelle sul fine vita, rispetto a cui il Parlamento non ha ancora dato risposte. Serve un impegno delle Camere a intervenire su questo fronte». In realtà sarebbe utile un impegno del governo sulla sanità, onde evitare che il fine vita diventi una prospettiva concreta per tanti malati che, data la mala gestione dell'emergenza Covid, passano in secondo piano. Ma a Fico preme di più insistere sull'eutanasia. Forse pensa che sia uno strumento utile a liberarsi di qualche italiano di troppo.
Nel frattempo anche Beppe Sala, sindaco di Milano in quota democratica, non avendo evidentemente altro da fare, si è premurato di intervenire a sostegno del ddl Zan, cioè la legge bavaglio contro l'omotransfobia che il 20 ottobre riprenderà il suo percorso parlamentare (appena superate le regionali hanno pensato bene di sbrigarsi a rimetterla in calendario). Via Twitter, Sala ha issato la bandiera arcobaleno: «Chiedo al Parlamento di accelerare la discussione sul disegno di legge Zan», ha scritto, «e di farlo in tempi rapidi, superando gli ostruzionismi che ne rallentano l'approvazione. Qui non si tratta di politica, ma di diritti umani. Subito una legge contro l'omotransfobia e la misoginia». Ovvio: in questo momento abbiamo bisogno come del pane di una norma utile soltanto a ridurre al silenzio chi non si piega ai dettami dell'ideologia Lgbt. Tutto il resto può aspettare, ma il bavaglio arcobaleno no. Magari potranno andare in giro a metterlo ai milanesi gli stessi agenti che si aggirano in cerca di pericolosi sovversivi con la mascherina abbassata da multare.
Sabato prossimo, a Roma, si terrà una grande manifestazione per la libertà di pensiero contro la mordacchia, segno che non tutta la popolazione è entusiasta del ddl censorio. Ma ai giallorossi non interessa. Anzi si impegnano al massimo per osteggiare qualsiasi iniziativa contraria al pensiero dominante, specie in materia di tutela della vita.
Il colmo si è raggiunto un paio di giorni fa grazie alla responsabile diritti del Pd, Monica Cirinnà. Costei si è scagliata contro una iniziativa di un gruppo di amministratori bresciani (di Fdi e Lega) i quali hanno deciso di sostenere con 400 euro a bambino le donne che rinunciano ad abortire. Secondo la vestale dem si tratta di un «grave attacco alla libertà delle donne». A suo dire, «la scelta di diventare madre o no non si compra, ma deve restare affidata alla responsabilità e alla libertà della donna di autodeterminarsi senza costrizioni». Dove stia la costrizione nel dare aiuto a una donna che liberamente sceglie di essere madre non è dato sapere. Ed è anche curioso che una «esperta di diritti» tenti di toglierli, questi famigerati diritti, invece di concederli.
Da ieri, per altro, in Italia è ancora più semplice evitare la gravidanza. L'Agenzia italiana del farmaco ha infatti stabilito che non sarà più necessaria la prescrizione medica per somministrare alle ragazze minorenni la «pillola dei 5 giorni dopo», cioè l'Ulipistral acetato utilizzato per la «contraccezione d'emergenza». Secondo il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini - questa pillola è addirittura «uno strumento etico in quanto consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze».
Che splendore, questo democraticissimo mondo al contrario: è «etico» dare la pillola senza ricetta alle ragazzine, ma è da fascisti aiutare le donne che vogliono partorire; è giusto che lo Stato fornisca gratis i farmaci per cambiare sesso (perché chiunque ha il diritto di fare ciò che vuole), però vogliono toglierci per decreto il diritto di opporci all'ideologia Lgbt. E mentre i giallorossi al governo si sbracciano sul «fine vita», un'intera nazione sperimenta già l'eutanasia del pensiero.
Arriva il manuale «antirazzista» per spingere i bambini bianchi a eliminarsi
Nel 1967, la femminista Valerie Solanas pubblicò un «manifesto per l'eliminazione dei maschi». Oltre mezzo secolo dopo, la sociologa Robin Diangelo è riuscita perfino a superarla, proponendo un singolare metodo per l'eliminazione dei bianchi. Tutti quanti, maschi e femmine. Ragione dello sterminio? Molto semplice: i bianchi sono irrimediabilmente razzisti. Anche quelli che pensano di non esserlo, persino quelli che si dichiarano progressisti, antirazzisti e fanatici del multiculturalismo. La vena di follia che riluce all'interno di questo discorso è piuttosto evidente, eppure il libro della Diangelo - appena uscito in Italia con il titolo Fragilità bianca. Perché è così difficile per i bianchi parlare di razzismo (Chiarelettere) - è rimasto per oltre settanta settimane nella classifica dei bestseller del New York Times, diventando un incredibile caso editoriale in tutto il mondo anglofono. Come è facile intuire, il volume ha beneficiato dell'onda di attenzione mediatica sollevata da Black lives matter, dagli abbattitori di statue e da altri esagitati «antifa» ostili a Donald Trump. Tuttavia le tesi della saggista americana meritano di essere prese sul serio, perché sono emblematiche del delirio in cui l'Europa e gli Stati Uniti sono immersi da qualche tempo.
Bisogna precisare, intanto, che la signora è bianca. Di più: il suo tomo si rivolge esclusivamente ai bianchi. Anzi, a una categoria ben precisa di bianchi, come lei stessa ha spiegato in una lunga intervista al Venerdì di Repubblica: «Il mio libro non è pensato per i suprematisti bianchi. Ma per quella parte di società civile e progressista che può e vuole fare meglio. Cerco di aiutarla a guardarsi allo specchio. E a migliorare. Molti mi hanno detto di aver iniziato il libro con scetticismo e, poi, di essercisi riconosciuti». Da un certo punto di vista, viene da sorridere. Immaginiamo lo smacco dei sinceri democratici, convinti da una vita di essere moralmente superiori e «Buoni® », che si ritrovano all'improvviso accusati del peggiore dei peccati. «Il nostro progressismo mantiene e perpetua il razzismo perché, asserragliati dietro la nostra falsa certezza», scrive la studiosa-attivista, «ci precludiamo di comprendere la verità». E la «verità» è che i bianchi nel loro complesso sono responsabili della peggiore oppressione della Storia.
Per la Diangelo, «in senso biologico le razze non esistono, ma come costrutti sociali hanno un peso enorme e informano ogni aspetto delle nostre vite». Una curiosa contraddizione: per essere un'antirazzista, la sociologa attribuisce alla razza un'importanza incredibile. E, di nuovo, rifila un colpo mortale ai progressisti di casa nostra, i quali vorrebbero eliminare la parola «razza», mentre gli attivisti americani ne sono ossessionati e non fanno che rimarcane l'esistenza.
Questa razza, tuttavia, nella concezione di teorici come la Diangelo assomiglia molto al gender: è appunto un «costrutto sociale», creato appositamente da una categoria di persone (i bianchi) per opprimere tutti gli altri, e in particolare i neri. Secondo la signora - e numerosi altri attivisti - il «bianco» non si definisce per il suo colore della pelle, ma per il mondo in cui si comporta, per il sistema di potere di cui si fa ingranaggio.
Il razzista non è «una persona che disprezza scientemente qualcuno per via della razza». No, sarebbe troppo facile. Un bianco non ha bisogno di disprezzare nessuno: è razzista in quanto bianco, poiché «il razzismo è un sistema» e tutti i bianchi non fanno altro che perpetrarlo. Come se ne esce? Poiché la razza è un costrutto sociale, dice la Diangelo, allora la si può smontare. Quindi la soluzione è smettere di essere bianchi o comunque «diventare meno bianchi», distruggere la «bianchezza» che è in noi.
In che modo? Chiaro: i bianchi devono sottoporsi all'autodafé, riconoscere il proprio ruolo di carnefici e passare - dopo opportuna rieducazione - lo scettro del potere alle vittime, cioè ai neri. I quali, poiché non sono parte del «sistema» dominante, possono anche nutrire pregiudizi verso chicchessia, ma non possono mai e poi mai essere definiti razzisti. Ovviamente, poi, a chi ha le pelle scura non è affatto richiesto di rinunciare alla propria razza o di cancellarla: deve al contrario difenderla, esaltarla, usarla come strumento di lotta.
È l'approdo di decenni di politicamente corretto. Si è arrivati a teorizzare l'autocancellazione dei bianchi, a indicare la «bianchezza» come il peccato originale. Se ci pensate, questo castello di idee si fonda su una discriminazione spaventosa, su un odio razziale terrificante e, soprattutto, sull'odio di sé. Fra un po', il solo modo per evitare l'accusa di razzismo sarà strapparsi la pelle di dosso.
Continua a leggereRiduci
Cattedre vuote e invasione incontrollata, ma la maggioranza spinge per fine vita e ddl Zan. Condanne a chi aiuta le mamme, mentre evitare le gravidanze è sempre più facile.Nel suo delirante libro, la sociologa Robin Diangelo criminalizza chiunque non abbia la pelle scura: una sorta di peccato originale. Perfino i fanatici dell'accoglienza sarebbero colpevoli dell'oppressione delle altre razze.Lo speciale contiene due articoli.Qualcuno, nottetempo, deve avere scombinato l'agenda della compagine giallorossa, creando una totale confusione e invertendo l'ordine delle priorità. Altrimenti non si spiega l'assurdità di alcune esternazioni e, soprattutto, l'ossessiva ostinazione con cui i nostri eroi si battono per alcune cause completamente altre. Il governo, tanto per fare un esempio, è in clamoroso e drammatico ritardo su tutto ciò che riguarda il (reale) contrasto al coronavirus: potenziamento di terapie intensive e subintensive, generale riassetto del sistema sanitario, messa in sicurezza delle scuole, reclutamento di nuovi insegnanti... Disastro anche su un altro tema almeno in parte connesso all'epidemia, ovvero l'immigrazione. Non è vero, come sostiene l'esecutivo, che gli sbarchi si siano arrestati. Proseguono e siamo a quota 24.505 arrivi nel 2020 contro i 7.939 di un anno fa. Nel frattempo la gestione degli stranieri contagiati si è rivelata del tutto inadeguata, con punte di orrore come la morte di un ragazzino di 15 anni ospitato su una nave quarantena. Registrati i fallimenti su due questioni centrali, bisogna prendere atto che i demostellati sono invece attivissimi su quelli che in genere si indicano come «temi etici».Giusto ieri il presidente della Camera, Roberto Fico, ha preteso un impegno del Parlamento affinché si «diano risposte». Su cosa? Forse sui docenti che mancano? Ma no! Sul fine vita, che diamine. Fico ha inviato un messaggio al XVII Congresso dell'associazione Luca Coscioni carico di emozione. «Le vostre battaglie, i temi rispetto a cui coraggiosamente avete portato avanti tante campagne, sono un costante pungolo per la politica e per l'intera società», ha scritto. «Penso a quelle sul fine vita, rispetto a cui il Parlamento non ha ancora dato risposte. Serve un impegno delle Camere a intervenire su questo fronte». In realtà sarebbe utile un impegno del governo sulla sanità, onde evitare che il fine vita diventi una prospettiva concreta per tanti malati che, data la mala gestione dell'emergenza Covid, passano in secondo piano. Ma a Fico preme di più insistere sull'eutanasia. Forse pensa che sia uno strumento utile a liberarsi di qualche italiano di troppo.Nel frattempo anche Beppe Sala, sindaco di Milano in quota democratica, non avendo evidentemente altro da fare, si è premurato di intervenire a sostegno del ddl Zan, cioè la legge bavaglio contro l'omotransfobia che il 20 ottobre riprenderà il suo percorso parlamentare (appena superate le regionali hanno pensato bene di sbrigarsi a rimetterla in calendario). Via Twitter, Sala ha issato la bandiera arcobaleno: «Chiedo al Parlamento di accelerare la discussione sul disegno di legge Zan», ha scritto, «e di farlo in tempi rapidi, superando gli ostruzionismi che ne rallentano l'approvazione. Qui non si tratta di politica, ma di diritti umani. Subito una legge contro l'omotransfobia e la misoginia». Ovvio: in questo momento abbiamo bisogno come del pane di una norma utile soltanto a ridurre al silenzio chi non si piega ai dettami dell'ideologia Lgbt. Tutto il resto può aspettare, ma il bavaglio arcobaleno no. Magari potranno andare in giro a metterlo ai milanesi gli stessi agenti che si aggirano in cerca di pericolosi sovversivi con la mascherina abbassata da multare.Sabato prossimo, a Roma, si terrà una grande manifestazione per la libertà di pensiero contro la mordacchia, segno che non tutta la popolazione è entusiasta del ddl censorio. Ma ai giallorossi non interessa. Anzi si impegnano al massimo per osteggiare qualsiasi iniziativa contraria al pensiero dominante, specie in materia di tutela della vita.Il colmo si è raggiunto un paio di giorni fa grazie alla responsabile diritti del Pd, Monica Cirinnà. Costei si è scagliata contro una iniziativa di un gruppo di amministratori bresciani (di Fdi e Lega) i quali hanno deciso di sostenere con 400 euro a bambino le donne che rinunciano ad abortire. Secondo la vestale dem si tratta di un «grave attacco alla libertà delle donne». A suo dire, «la scelta di diventare madre o no non si compra, ma deve restare affidata alla responsabilità e alla libertà della donna di autodeterminarsi senza costrizioni». Dove stia la costrizione nel dare aiuto a una donna che liberamente sceglie di essere madre non è dato sapere. Ed è anche curioso che una «esperta di diritti» tenti di toglierli, questi famigerati diritti, invece di concederli. Da ieri, per altro, in Italia è ancora più semplice evitare la gravidanza. L'Agenzia italiana del farmaco ha infatti stabilito che non sarà più necessaria la prescrizione medica per somministrare alle ragazze minorenni la «pillola dei 5 giorni dopo», cioè l'Ulipistral acetato utilizzato per la «contraccezione d'emergenza». Secondo il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini - questa pillola è addirittura «uno strumento etico in quanto consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze». Che splendore, questo democraticissimo mondo al contrario: è «etico» dare la pillola senza ricetta alle ragazzine, ma è da fascisti aiutare le donne che vogliono partorire; è giusto che lo Stato fornisca gratis i farmaci per cambiare sesso (perché chiunque ha il diritto di fare ciò che vuole), però vogliono toglierci per decreto il diritto di opporci all'ideologia Lgbt. E mentre i giallorossi al governo si sbracciano sul «fine vita», un'intera nazione sperimenta già l'eutanasia del pensiero. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/le-priorita-dei-giallorossi-pillola-alle-minorenni-eutanasia-e-bavaglio-lgbt-2648161734.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="arriva-il-manuale-antirazzista-per-spingere-i-bambini-bianchi-a-eliminarsi" data-post-id="2648161734" data-published-at="1602357209" data-use-pagination="False"> Arriva il manuale «antirazzista» per spingere i bambini bianchi a eliminarsi Nel 1967, la femminista Valerie Solanas pubblicò un «manifesto per l'eliminazione dei maschi». Oltre mezzo secolo dopo, la sociologa Robin Diangelo è riuscita perfino a superarla, proponendo un singolare metodo per l'eliminazione dei bianchi. Tutti quanti, maschi e femmine. Ragione dello sterminio? Molto semplice: i bianchi sono irrimediabilmente razzisti. Anche quelli che pensano di non esserlo, persino quelli che si dichiarano progressisti, antirazzisti e fanatici del multiculturalismo. La vena di follia che riluce all'interno di questo discorso è piuttosto evidente, eppure il libro della Diangelo - appena uscito in Italia con il titolo Fragilità bianca. Perché è così difficile per i bianchi parlare di razzismo (Chiarelettere) - è rimasto per oltre settanta settimane nella classifica dei bestseller del New York Times, diventando un incredibile caso editoriale in tutto il mondo anglofono. Come è facile intuire, il volume ha beneficiato dell'onda di attenzione mediatica sollevata da Black lives matter, dagli abbattitori di statue e da altri esagitati «antifa» ostili a Donald Trump. Tuttavia le tesi della saggista americana meritano di essere prese sul serio, perché sono emblematiche del delirio in cui l'Europa e gli Stati Uniti sono immersi da qualche tempo. Bisogna precisare, intanto, che la signora è bianca. Di più: il suo tomo si rivolge esclusivamente ai bianchi. Anzi, a una categoria ben precisa di bianchi, come lei stessa ha spiegato in una lunga intervista al Venerdì di Repubblica: «Il mio libro non è pensato per i suprematisti bianchi. Ma per quella parte di società civile e progressista che può e vuole fare meglio. Cerco di aiutarla a guardarsi allo specchio. E a migliorare. Molti mi hanno detto di aver iniziato il libro con scetticismo e, poi, di essercisi riconosciuti». Da un certo punto di vista, viene da sorridere. Immaginiamo lo smacco dei sinceri democratici, convinti da una vita di essere moralmente superiori e «Buoni® », che si ritrovano all'improvviso accusati del peggiore dei peccati. «Il nostro progressismo mantiene e perpetua il razzismo perché, asserragliati dietro la nostra falsa certezza», scrive la studiosa-attivista, «ci precludiamo di comprendere la verità». E la «verità» è che i bianchi nel loro complesso sono responsabili della peggiore oppressione della Storia. Per la Diangelo, «in senso biologico le razze non esistono, ma come costrutti sociali hanno un peso enorme e informano ogni aspetto delle nostre vite». Una curiosa contraddizione: per essere un'antirazzista, la sociologa attribuisce alla razza un'importanza incredibile. E, di nuovo, rifila un colpo mortale ai progressisti di casa nostra, i quali vorrebbero eliminare la parola «razza», mentre gli attivisti americani ne sono ossessionati e non fanno che rimarcane l'esistenza. Questa razza, tuttavia, nella concezione di teorici come la Diangelo assomiglia molto al gender: è appunto un «costrutto sociale», creato appositamente da una categoria di persone (i bianchi) per opprimere tutti gli altri, e in particolare i neri. Secondo la signora - e numerosi altri attivisti - il «bianco» non si definisce per il suo colore della pelle, ma per il mondo in cui si comporta, per il sistema di potere di cui si fa ingranaggio. Il razzista non è «una persona che disprezza scientemente qualcuno per via della razza». No, sarebbe troppo facile. Un bianco non ha bisogno di disprezzare nessuno: è razzista in quanto bianco, poiché «il razzismo è un sistema» e tutti i bianchi non fanno altro che perpetrarlo. Come se ne esce? Poiché la razza è un costrutto sociale, dice la Diangelo, allora la si può smontare. Quindi la soluzione è smettere di essere bianchi o comunque «diventare meno bianchi», distruggere la «bianchezza» che è in noi. In che modo? Chiaro: i bianchi devono sottoporsi all'autodafé, riconoscere il proprio ruolo di carnefici e passare - dopo opportuna rieducazione - lo scettro del potere alle vittime, cioè ai neri. I quali, poiché non sono parte del «sistema» dominante, possono anche nutrire pregiudizi verso chicchessia, ma non possono mai e poi mai essere definiti razzisti. Ovviamente, poi, a chi ha le pelle scura non è affatto richiesto di rinunciare alla propria razza o di cancellarla: deve al contrario difenderla, esaltarla, usarla come strumento di lotta. È l'approdo di decenni di politicamente corretto. Si è arrivati a teorizzare l'autocancellazione dei bianchi, a indicare la «bianchezza» come il peccato originale. Se ci pensate, questo castello di idee si fonda su una discriminazione spaventosa, su un odio razziale terrificante e, soprattutto, sull'odio di sé. Fra un po', il solo modo per evitare l'accusa di razzismo sarà strapparsi la pelle di dosso.
Mario Giordano presenta il libro “I re di denari”, nel quale denuncia l’enorme potere delle banche in Italia: un potere aumentato in seguito alla crisi finanziaria del 2011-2013, basato più sulla gestione del risparmio che sull’economia reale e alimentato da lotte di potere nello stesso sistema bancario. Giordano riflette anche sulla divisione politica non più tra destra e sinistra, ma tra élite e popolo e sul ruolo della famiglia oggi.