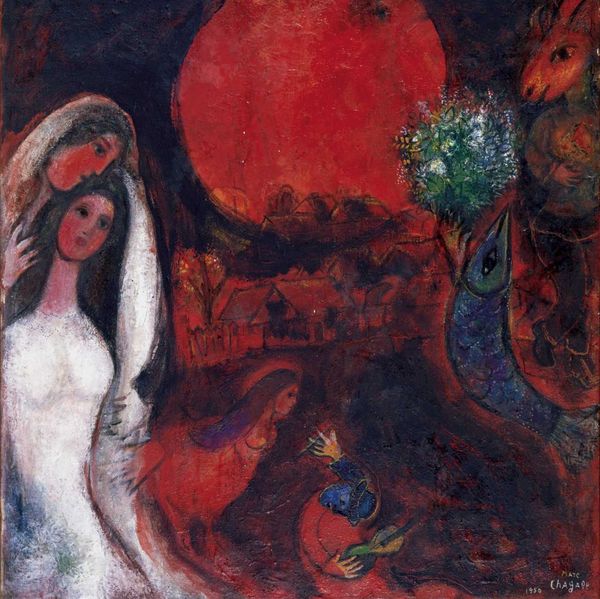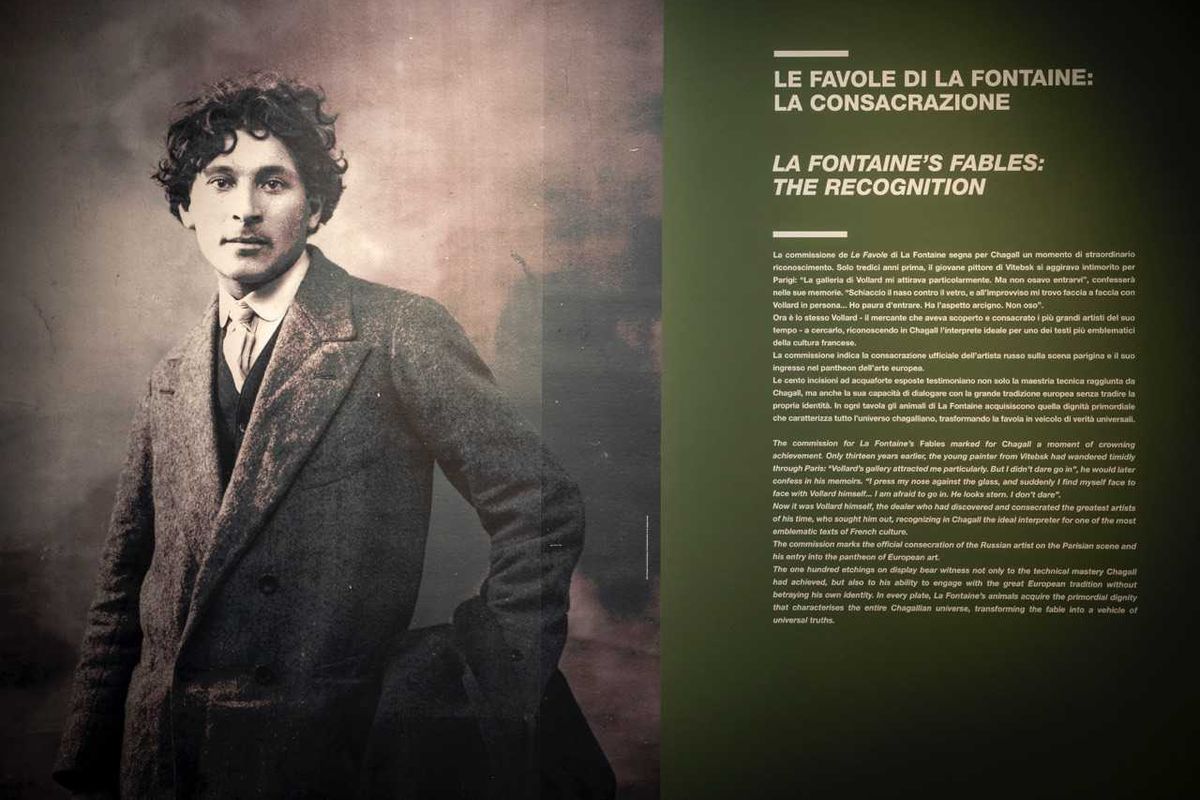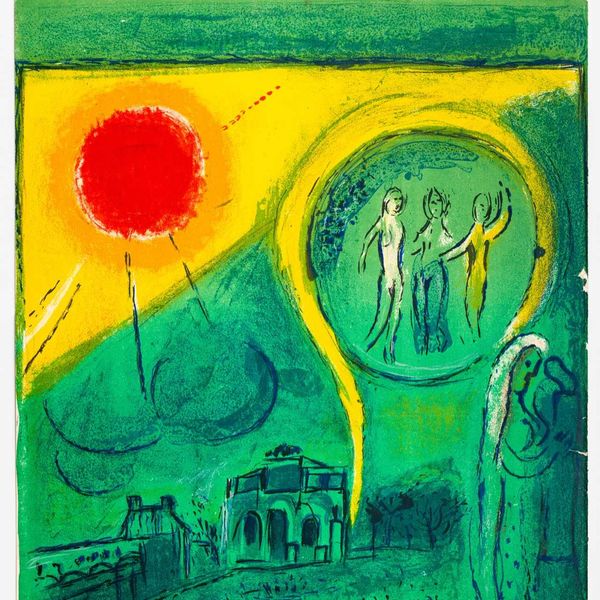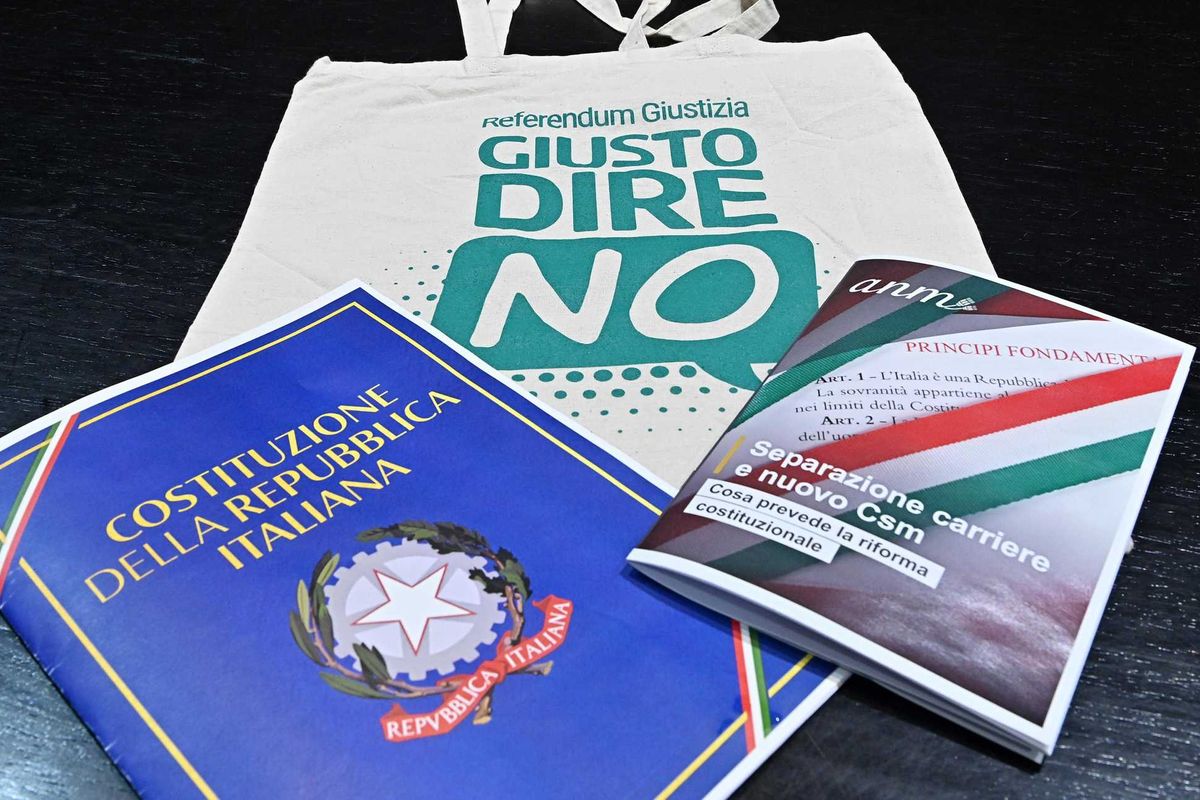Sono tre, anzi quattro, i re dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm o antitrust). Perché? Un presidente, due commissari e un segretario generale. Sono tecnici, come vedremo, di grande esperienza, anche se non mancano le ombre. Insomma loro sono «il Collegio», i comandanti, i «torturatori», ma anche le vittime, di questa potente Autorità, che deve vigilare contro gli abusi di posizione dominante, impedire cartelli lesivi della concorrenza, controllare severamente le concentrazioni (fusioni) che superano un certo valore, valutare (e combattere) i conflitti di interesse dei componenti del governo e difendere in ogni modo gli interessi dei consumatori. Sulla carta quindi i poteri sono immensi e vengono esercitati con sanzioni pesantissime e l'ausilio costante della Guardia di finanza. Il lavoro dell'Antitrust non finisce qui: lavora insieme alle consorelle degli altri paesi Ue, prepara relazioni, segnala al parlamento e a Regioni e agli enti locali «le situazioni distorsive della concorrenza» e così via.
Ma chi sono i «grandi capi» di questa potente Autorità indipendente, nata nell'ottobre 1990 e che ha avuto già ben sei presidenti di alto profilo: Francesco Saja, Giuliano Amato, Giuseppe Tesauro, Antonio Catricalà, Giovanni Pitruzzella e l'attuale Roberto Rustichelli. Quest'ultimo, indicato da Luigi Di Maio, considerato vicino ai 5 stelle, è stato scelto, nel dicembre 2018, dopo l'analisi di 112 candidature (avvocati, magistrati, docenti universitari, imprenditori, pensionati, impiegati). Sarà vero o era già tutto deciso dai due presidenti della Camera e del Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati?
Il nuovo presidente Roberto Rustichelli, è un magistrato di Ravenna, ora collocato fuori ruolo per decisione del Csm, laureato in giurisprudenza e in scienze economiche. Prima della nomina all'Antitrust era presidente del Collegio B del Tribunale delle imprese di Napoli ed era anche presidente di Sezione della Commissione tributaria della stessa città. Rustichelli, oltre a una frequentazione napoletana, che lo ha fatto conoscere al ministro Di Maio (e al presidente della Camera, Fico) ha avuto anche diversi incarichi come esperto (vice capo di gabinetto del ministro delle Attività produttive e poi consigliere giuridico a palazzo Chigi in vari governi). Insomma Rustichelli non è stato un politico, ma ha sempre lavorato vicino agli uomini di governo. Ed ora ha avuto la grande opportunità di diventare il numero uno di un'Autorità molto importante e prestigiosa.
La stessa opportunità non l'ha avuta un altro prestigioso componente del Collegio dell'Agcm, il professor Michele Ainis, forse perché non ha saputo muoversi nel pantano della politica. È stato vicino alla Margherita, poi al Pd, ma ha conservato sempre una sua autonomia di giurista e di editorialista di grandi giornali (da anni scrive per La Repubblica) e talvolta questo suo impegno di «comunicatore» gli ha generato accuse di conflitto di interessi. Il professore, da buon siciliano che si annoia spesso («caratteristica dei siciliani colti», osservava Leonardo Sciascia) si dà, oltre che ai saggi di natura giuridica, anche alla letteratura e ogni tanto filosofeggia nelle riviste culturali. Sperava probabilmente in una promozione a presidente dell'Autorità, ma l'ondata gialloblù gli hanno impedito la scalata al vertice. E di questo è amareggiato, anche se fa di tutto per non farlo trapelare e si sfoga dandosi alla scrittura, anche di romanzi.
L'altra componente del collegio Agcm è una seria studiosa di diritto, Gabriella Muscolo. È stata nominata da Laura Boldrini, trionfante perché è riuscita a ottenere, anche all'Antitrust, la quota rosa, ma (insieme a Pietro Grasso) non si sono accorti che la signora (magistrato al Tribunale di Roma) non aveva tutti i titoli per essere nominata all'Agcm. I due presidenti del Senato e della Camera nel 2014 ignoravano ( o hanno sorvolato) che, secondo la legge, i magistrati per essere eletti nelle Autorità devono essere inquadrati alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato o alla Corte di cassazione. La Muscolo aveva lo stipendio di un giudice di Cassazione, per la sua progressione di carriera, ma non aveva mai messo piede negli organi menzionati. Alcuni giornali hanno fatto notare che le regole andavano rispettate… ma sapete bene come vanno queste cose. Tutto è passato sotto silenzio e le regole della legge sono diventate lettera morta. Tutti sono felici e contenti per sette anni, con lo stipendio annuo di 240.000 euro, 20.000 euro lordi mensili (presidente, gli altri due componenti il Collegio e il segretario generale) .
Ma che cosa ha realizzato negli ultimi tempi questa megastruttura (in cui operano ben 285 dipendenti, fra dirigenti, funzionari e impiegati, oltre ai consulenti, esperti e Guardia di finanza)? Il 2 luglio avrà luogo lo show pubblico, con la solenne relazione annuale (come avviene anche nelle altre Autorità). Ma i componenti il Collegio e lo stesso presidente non si possono pronunciare prima: hanno il divieto assoluto di rilasciare interviste o parlare con i giornalisti per impedire loro di rivelare i grandi segreti dell'Autorità che pontifica solo una volta l'anno, alla presenza del presidente della Repubblica e delle altre massime autorità dello Stato. Alla faccia dell'Autorità trasparente. Ma che rivelerà mai l'Agcm? Nulla di particolarmente nuovo, come si evince dalla Relazione annuale 2019 (di 293 pagine), presentata il 31 marzo di quest'anno al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e che costituirà parte centrale del lungo discorso del presidente Rustichelli.
In particolare, si elencano in questo testo gli interventi dell'Agcm nel corso del 2018 per garantire il corretto funzionamento dei mercati. Citiamo solo qualche esempio: l'istruttoria nel settore auto, per eliminare il cartello tra le principali imprese per l'acquisto di autovetture nuove; l'intervento nel campo dei farmaci contro pratiche abusive messe in atto da imprese in posizione dominante (che ha permesso la riduzione del prezzo dei farmaci); gli interventi nei mercati dei servizi (di trasporto, finanziari, professionali, delle tlc e del settore energia). Complessivamente in sei casi l'istruttoria si è conclusa con 820 milioni di euro di sanzioni. L'Autorità è stata chiamata a valutare 73 casi di concentrazione di imprese. Il numero di questi casi è aumentato del 14% rispetto all'anno precedente. Nel campo dell'advocacy, cioè la presenza di norme che producono effetti anticoncorrenziali sul mercato, l'Autorità ha compiuto 84 interventi, impugnando atti anche dei Tar (soprattutto nel campo dei servizi pubblici e del turismo). Nel settore specifico della tutela dei consumatori l'Agcm ha concluso 90 istruttorie, riscontrando infrazioni delle leggi in 63 casi. Le sanzioni irrorate complessivamente ammontano a 65 milioni di euro, di cui la metà a danno di imprese dei settori comunicazione, finanza, assicurazioni e servizi postali.
Intensa è stata l'attività dell'Antitrust anche nel campo dei mercati informatici e, tra le attività recenti, la vicenda di Blue Panorama airlines, in cui è stata comminata una sanzione di un milione di euro per «pratiche commerciali scorrette».
L'altro clamoroso caso ha riguardato l'assegnazione dei diritti televisivi (partite di calcio), in territori diversi dall'Italia. Le sanzioni ai soggetti interessati ammontano a 67 milioni di euro. È stata anche risolta la controversia tra Sky e Mediaset Premium per ripristinare la concorrenza fra queste reti nel mercato delle pay tv ,con un accordo di tre anni. L'Autorità ha anche deciso di aprire un'approfondita istruttoria nei confronti di Google per accertare «un presunto abuso di posizione dominante in violazione della legge». Il procedimento si concluderà entro maggio del prossimo anno. Infine, una gigantesca sanzione (235 milioni di euro) è stata comminata nell'aprile scorso alla Consip (la centrale acquisti della pubblica amministrazione) per un appalto del valore complessivo di 2,7 miliardi (suddiviso in 18 lotti geografici). L'appalto riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e manutenzione degli uffici pubblici in tutto il Paese. Sono state accertate intese extra gara fra tre grandi imprese, che hanno violato la legge sulla concorrenza nel mercato.
Come si vede, la «macchina» funziona: le sanzioni, anche pesanti, vengono irrorate. Dai documenti del sito si evidenzia che anche nei sette anni precedenti (nella gestione di Giovanni Pitruzzella), dal 2011 al 2018, sono state comminate multe per un miliardo e mezzo di euro (130 casi). Non è chiaro però se queste cifre siano state realmente pagate perché «l'Amministrazione trasparente» non dice nulla a questo proposito. Fa piuttosto intravvedere una sorta di sanatoria quando osserva che, a causa della crisi economica, le sanzioni sono state ridotte. È anche per questa ragione che risulta ribassato il contributo delle imprese per finanziare l'Agcm (attualmente è dello 0,06 per mille del fatturato dell'anno precedente). L'Autorità non grava più da anni sullo Stato e il bilancio risulta sempre in attivo. Nel 2017 è stata acquistato il palazzo di piazza Verdi a Roma, dove aveva sede l'Enel e lo Stato l'ha ceduta in uso gratuito all'Agcm. Per la storia, la spesa è stata di 88 milioni 244.580 euro. Secondo il piano finanziario, il 69 per cento delle uscite è rappresentato dal costo del personale. Il resto è suddiviso per trasferimenti: ai ministeri (2%), alle altre Autorità (7%), al Fondo di riserva (6%), per investimenti fissi (4%). Sulle cifre trionfa sempre una grande confusione, in un sito con voluminosi rapporti, relazioni e tabelle anche contradditorie. Abbiamo chiesto al portavoce e all'Ufficio stampa: è così difficile sapere quali sono le entrate e le uscite 2018? La risposta è stata un lungo silenzio. Per fortuna il chiarimento lo abbiamo trovato in una nota aggiuntiva del Bilancio di previsione 2019. Chi ha scritto questa nota ha premesso: «Al fine di rendere più comprensibile le spese effettive dell'Autorità si pubblica il seguente prospetto». Ora noi lo riassumiamo : i costi effettivi di funzionamento dell'Agcm sono pari a 61,67 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i versamenti, contribuzioni e rimborsi di legge. Complessivamente dunque le uscite sono 67,99 milioni di euro. In realtà (secondo il Bilancio 2018, che ci è stato fatto recapitare quando avevamo chiuso questo articolo) le uscite equivalgono a 69 milioni e 971.000 e le entrate a 93 milioni 184.000. Come si è detto le entrate sono a carico delle imprese: un attivo di quasi 25 milioni di euro.
Si può essere contenti soltanto del fatto che finalmente un ente pubblico chiude il suo bilancio in attivo?