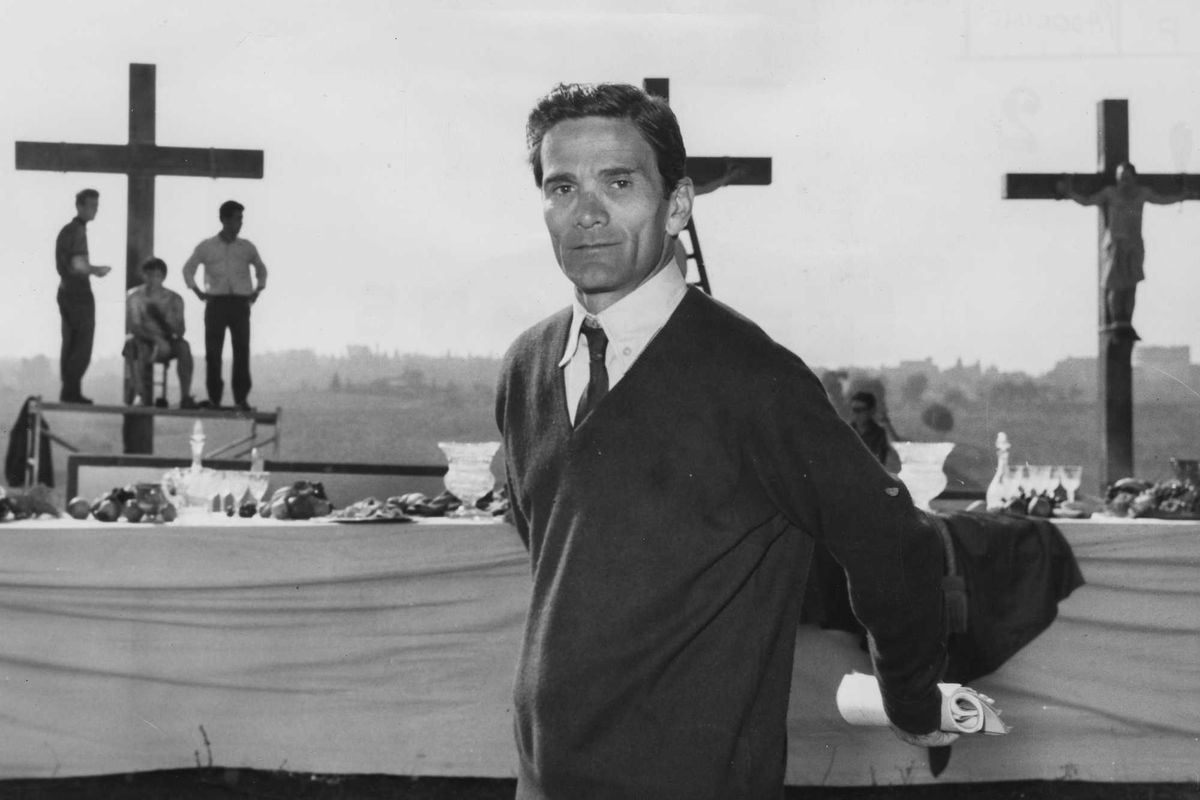2023-04-15
L’anarcogastronomo ribattezzato Sua Nasità
Libertario idealista del bien vivre e del bere meglio, Gino Veronelli aveva un approccio multisensoriale a quello che poteva raccontare un vino. E si rammaricava che il suo orecchio non avesse la stessa sensibilità del naso. Coltivava anche la passione dei calligrammi.Gino Veronelli non cessava mai di stupire, anarchico idealista del bien vivre e del bere meglio. Sue millanta idee e progetti per valorizzare l’enorme patrimonio vitivinicolo nazionale e i suoi protagonisti, che fossero umili vignaiuoli del Monferrato come nobili casati delle terre senesi. Mai dare nulla per scontato. «Iniziai a occuparmi professionalmente del mondo del vino solo dopo aver conosciuto Luigi Carnacina. E pensare che sono nato sotto il segno dell’acquario. Forse neanche gli astri avevano previsto quanto si sarebbe evoluta questa mia passione». Sviluppata in vari modi, sia «camminando la terra», assieme ai suoi protagonisti, ma soprattutto sapendola raccontare con piglio coinvolgente a vari livelli. «Aveva un carisma a calamita», come dirà di lui Arturo Rota, entrato giovanissimo in casa Veronelli per riordinare la sterminata biblioteca di oltre novemila volumi «caotica come lo sono quelle di chi i libri li legge davvero» con appunti sparsi ogni dove, tanto che la ricetta del pesto alla genovese e un aforisma di Pascal si potevano trovare sovrapposti l’uno all’altro. Non solo. Un intero scaffale vedeva disordinatamente allineati dizionari e vocabolari assortiti, un ossimoro per un personaggio come Veronelli il cui stile era talmente personale da venire riconosciuto all’istante. Diverse le testimonianze di personaggi che, a loro volta, hanno lasciato un’impronta fondamentale nel panorama culturale del novecento. Gianni Brera che non era certo uno che scherzava con sostantivi e congiuntivi, gli riconosceva «che sa scrivere intarsiando, come tutti i lombardi che hanno parlato dialetto e studiato italiano a scuola». Lo affianca Mario Soldati, cineasta e letterato come pochi. «La lingua di Veronelli si adatta alla materia appena i piatti di cui parla sono veneti, come liguri o pugliesi. Slitta, senza bisogno di virgolette, nel lirismo del dialetto o della lingua straniera corrispondente, con associazioni mnemoniche di ogni tipo, visive, verbali» e quantaltro. Se Soldati e Brera potevano essere sospettati di complicità gastronomica, Giuseppe Prezzolini era inattaccabile: «l’abbondanza del vocabolario di Veronelli fa invidia a chi cerchi di scrivere con precisione senza annoiare». Suoi neologismi? C’è solo l’imbarazzo della scelta. Si va da «millanta», per dire molti e di più a «stassentire», peraltro facilmente traducibile. Ma anche un più compito «vino da meditazione». Quello che spiazza ulteriormente, per chi si avvicina alla galassia veronelliana, è un altro aspetto: la sua calligrafia, precisa, ordinata. Un grafologo, quelli che ricostruiscono anche gli aspetti più celati di una personalità, davanti alle ordinate architetture calligrafiche del nostro avrebbe una crisi di identità. Anche perché il Gino nazionale, tra i suoi svariati interessi, coltivava anche quello dei calligrammi, un omaggio al suo inventore, Guillaume Apollinaire, ovvero testi, anche poetici, disposti in modo da formare un disegno, «così da essere guardati, oltre che letti». Una sua opera, sviluppata assieme all’artista Silvia Coppola, «in ogni bicchiere di vino il volto di una donna» è stata esposta al Moma di New York. Un’altra opera è dedicata ai vini dell’Oltrepò pavese «ove il testo, in prosa, sembra assumere quell’effervescenza che la bottiglia e il territorio suggeriscono». Da qui il suo approccio multisensoriale per dare il massimo valore a quanto si poteva percepire da quello che poteva raccontare un vino. È vero che Gianni Mura, uno dei suoi migliori allievi, lo aveva onorato come «Sua Nasità» (anche per una discreta taglia anatomica), ma era lo stesso Gino a rammaricarsi che il suo orecchio non aveva la stessa sensibilità del naso. «Quando le bollicine sollecitano il naso producono un suono leggero… guai non percepirlo, è come un bosco senza il rumore delle foglie o il movimento del mare senza il suono dell’onda che si frange» tanto da sottolineare come «nel vino tutti i sensi sono coinvolti. Sono loro che raccolgono la materia del suo racconto, del suo canto». Veronelli sempre devoto cultore del talento femminile. «Amica mia paritaria» è stato uno dei veronellismi più radicati. Ne sa qualcosa Paola Mura che, in una degustazione in cui lei era semplice accompagnatrice del più noto consorte, percepì delle sfumature olfattive che colpirono il maestro Gino. Fu così che la avviò a seguire un corso per sommelier, accompagnata dalla relativa considerazione «le donne sono avvantaggiate perché possiedono una cultura del profumo che noi uomini non abbiamo». Paola affiancò poi per anni il marito Gianni Mura nel firmare la rubrica golosa di un noto settimanale. E che dire del Veronelli designer, posto che non si è negato nemmeno questo modo di dare forma alle sue idee, alle sue invenzioni dove poter conciliare emozioni diverse. Collabora con due maestri del design, Achille e PierGiacomo Castiglioni, per realizzare Gli Orseggi, una linea originale di bicchieri, dalla esile flute al corposo balloon. Si inventò una pentola da forno in legno, chiamata chissaperchè Il Sarcofago, adottata poi dallo stellato Ezio Gritti e che dire di ElleVi, un originale portatappi, sorta di medagliere, da appendere al collo della bottiglia, per dare il giusto onore anche all’umile creatura di sughero, invero preziosa custode, nel tempo, dei sentori di Bacco. Al passo con i tempi con un piccolo opuscolo, Il Frullatore Gastronomo, dove adatta per l’uso del nuovo elettrodomestico la preparazione di ingredienti per ricette sino ad allora tramandate dalla manualità delle donne di casa. Era un tempo in cui la cultura enologica come la intendiamo oggi stava muovendo i primi passi. L’etichetta, identità anagrafica di un vino, non sempre era valorizzata quale indispensabile abbinamento alla fatica di chi l’aveva prodotto. Veronelli le dedica due righe di poesia pura nel suo maritarsi alla creatura di Bacco. Sulla bottiglia «vi si adagia ad àncora, vi si appropria, al di là della vitrea barriera, della morbidità e degli aromi e se ne fa bandiera». Passaggi che neanche la miglior Liala, anche perché «una bottiglia senza etichetta è come un libro che non riportasse in copertina né titolo, né nome dell’autore». Viaggiando di etichetta… nel 1983 fonda l’omonima rivista, che dirigerà per undici anni. Un inno al bien vivre, in cui coinvolge testimoni nei diversi settori. Carla Fracci a suggerire i migliori gioielli da indossare a teatro, Gianni Brera detta le regole per essere competitivi nelle sfide a scopone scientifico, magari con un bel fiasco di Oltrepò al fianco. L’Etichetta che riscuoterà successo anche all’estero, piacevole ambasciatrice del miglior made in Italy, tanto che un prestigioso testimonial quale George Bertrand così la descriverà «non vi è al mondo una rivista che si occupi della qualità della vita materiale che gli possa stare anche lontanamente alla pari». Ma Veronelli, al di là dei meritati successi, continuerà sempre «a camminare la terra», al fianco della fatica dei suoi protagonisti. Da queste premesse era nato, nel 1975, il Premio Nonino «Risit d’Aur». In giuria gli amici di sempre, Mario Soldati e Gianni Brera. Dall’iniziale missione di premiare i migliori protagonisti dell’enomondo si passa via via a quello letterario per poi assumere, nel 1984, dimensioni internazionali, con un palmares di assoluto livello. Veronelli, tuttavia, non perderà mai quella dimensione umana che lo ha reso testimone ineguagliabile del mondo della civiltà contadina. Un esempio la descrizione di Romano Levi, da lui ribattezzato il Grappaiol Angelico. «Si muoveva a scatti, guardava a terra per l’imbarazzo di stare con gli altri. Le sue etichette erano vergate a mano, una ad una. Quando le compila con la penna a cannuccia e il pennino che intinge nel calamaio china la testa di lato e fa fuoriuscire la lingua per concentrarsi meglio». Poesia pura. Anche questo è stato Gino Veronelli.
Nel riquadro la produttrice Giulia Maria Belluco (iStock)
Gaia Zazzaretti prima e dopo il vaccino (iStock)