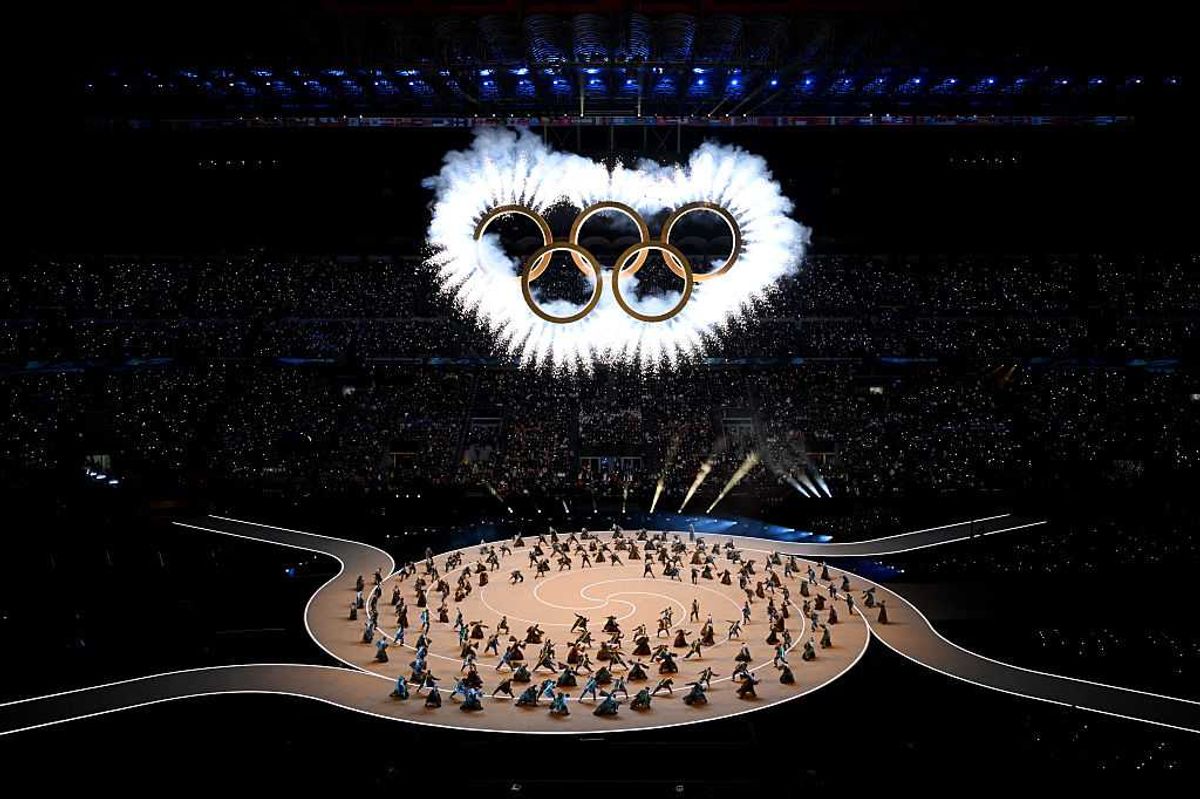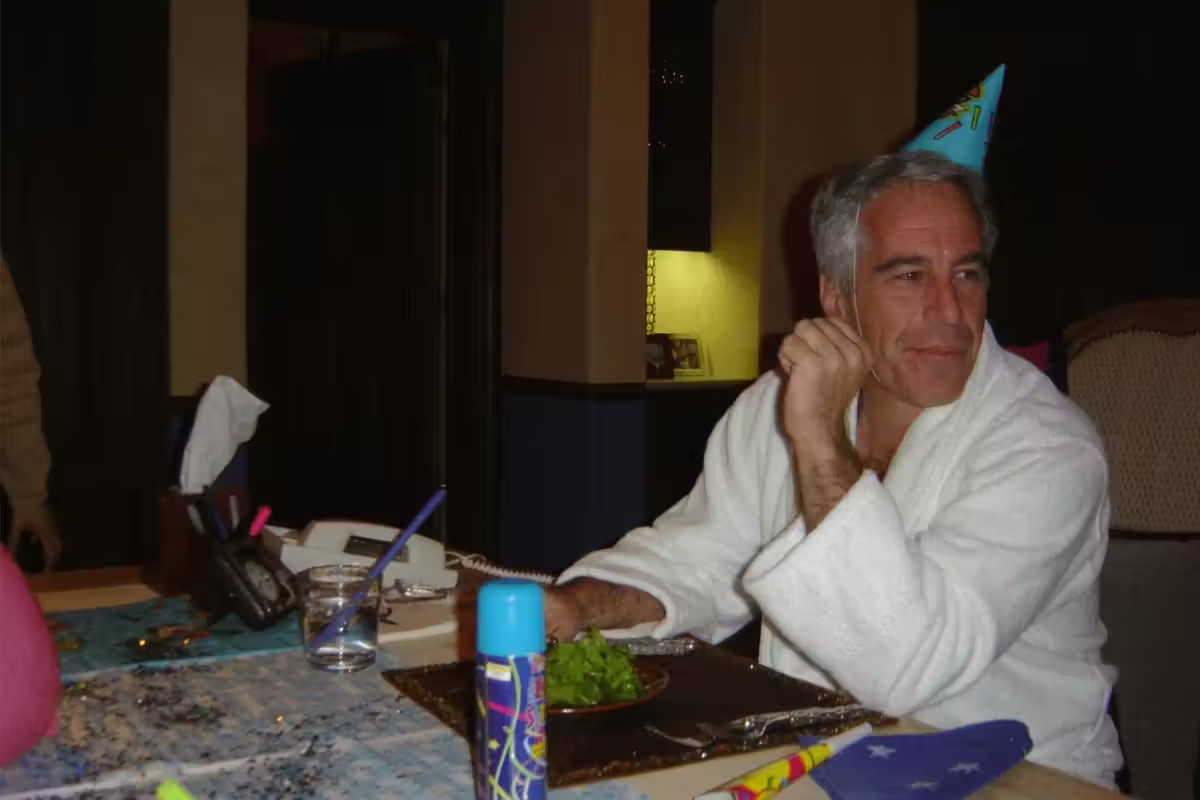«La sinistra moralista odia il corpo. Ma la vera filosofia si fa in palestra»

Filosofia e arti marziali, Nietzsche e Schwarzenegger. Accostamenti spaesanti, ma che hanno un capostipite illustre: Platone. Il filosofo genovese Simone Regazzoni ne parla nel suo nuovo saggio, La palestra di Platone, appena uscito per Ponte alle grazie.
Che c'entra il filosofo greco con la palestra? Platone non era un odiatore del corpo?
«La storia di Platone che odia il corpo si riduce ad alcuni passi del Fedone, in cui il filosofo parla del momento della separazione dell'anima dal corpo. A parte questa circostanza, Platone (che era un atleta e aveva le orecchie “a cavolfiore" come i lottatori) non odia il corpo. Odia il corpo morto. Per il resto, parla di un “plesso mente-corpo" che va educato e allenato in parallelo. Nel Timeo Platone dice chiaramente che chi si occupa di questioni intellettuali deve allenare anche il corpo. E per spiegare i suoi concetti usa molte metafore tratte dalla lotta».
Popper ci disse che Platone è il fondatore del totalitarismo. Ora che va di moda la cancel culture, non è che qualcuno vorrà cancellare anche Platone?
«La lettura di Popper è ingenua e astorica, senza sensibilità per il testo. È evidente che l'utopia platonica applicata alla lettera al di fuori del suo contesto storico ti porta a dire che Platone era già fascista, nazista o comunista. Ma allora lo potremmo fare con chiunque. Quasi tutti i filosofi sono stati razzisti, contro le donne, per la pena di morte. Se usiamo le categorie del politicamente corretto prendiamo l'intera storia della filosofia e la mandiamo al macero».
Ci sono stati altri filosofi atleti?
«Marco Aurelio praticava pugilato, Nietzsche era il gran camminatore, Derrida voleva diventare calciatore, ma non abbiamo dei grandi atleti. Questo perché da un certo punto in poi la filosofia diventa solo discorso, lavoro del pensiero. E quindi anche quando fa sport, il filosofo lo fa privatamente. Peter Sloterdijk scrive libroni sull'allenamento, ma la sua bicicletta, di cui è appassionato, non entra nel suo testo. È questo che fa la differenza: io parlo del mio corpo che si allena».
Le tue foto social mentre pratichi hwa rang do ti sono valse una menzione nella pagina Facebook «Io, professione mitomane». Ma presentarsi in quel modo è mitomania o filosofia?
«Il corpo del filosofo oggi viene costruito in un certo modo: il filosofo è la mano sotto il mento, la barba, il volto contratto, la postura incurvata. Il filosofo è Cacciari. Pubblicare la foto del filosofo che tira un calcio alto o usa il nunchaku è destabilizzante. È come se tra l'immagine e il pensiero ci fosse una discrasia. In altri rami del sapere non è così, gli scrittori questo lavoro sul corpo lo hanno già fatto. Il corpo del filosofo è invece ancora soggetto a una codificazione ottocentesca. Io ho voluto decostruire quell'immagine. Il filosofo può anche mostrarsi con un corpo muscoloso».
Tu tieni anche dei seminari di allenamento filosofico. Di cosa si tratta?
«Preparando questo libro ho cercato di vedere se fosse possibile riscoprire un'esperienza simile a quella della palestra di Platone. Invece di fare la classica conferenza ho proposto di fare un allenamento che prende spunto da molte metafore fisiche presenti in Platone. Si va in un parco e si alternano momenti di esposizione ad altri di allenamento. Prossimamente verrò a fare una conferenza a Milano, in una palestra di pugilato».
Una delle formule più fortunate della filosofia italiana è quella del «pensiero debole». A prescindere dai contenuti, l'espressione non tradisce una fascinazione verso il «debolismo»?
«Il rischio c'è. Uno come Vattimo, che è il filosofo del linguaggio, non può pensare che la scelta della parola non lasci comunque un segno. Ricordo che Derrida, in un dibattito proprio con Vattimo, gli rimproverava questo termine, che non gli piaceva. Nel pensiero debole ci sono molto spunti interessanti, ma la parola non è felice. Il rischio è che venga a mancare un certo attrito del reale. Manca una riflessione sul trauma, sulla forza, sul potere. Il mio, invece, è un testo sulla forza. Non c'è contrapposizione tra dialogo, conflitto e lotta, per me sono un unicum».
Tu sei una persona di sinistra. Non pensi che troppo spesso a sinistra il corpo atletico sia stato liquidato come un'espressione fascistoide?
«C'è stata una fase, molto contemporanea, dove la sinistra ha tralasciato il corpo e ha ritenuto che l'atletismo fosse una cosa di destra. Il corpo emaciato, invece, passava per una cosa di sinistra. Se ampliamo lo sguardo, tuttavia, vediamo che nella storia della sinistra il tema della forza è ben presente, e anche quello del corpo. Pensiamo solo a Foucault. È la sinistra irenica, politicamente corretta, dei radical chic a pensare che qualsiasi allenamento sia una cosa pericolosa. Ma questa sinistra ridotta alla moralina non interessa quasi più a nessuno. Io, comunque, quando faccio filosofia non penso agli schieramenti politici, infatti cito Nietzsche e Mishima».
Il tuo libro parla molto di mixed martial arts. Poco prima che uscisse, questa disciplina è finita sotto i riflettori per il caso di Colleferro. Cosa hai pensato di come è stato raccontato quell'evento?
«Attraverso questo caso di cronaca molti giornalisti hanno scoperto le Mma, inquadrate però alla luce della tragedia. Molti hanno concluso che sia quel particolare tipo di sport a creare quei soggetti violenti. Personalmente non vedo nessuna connessione tra fare Mma e diventare picchiatori. “Non bisogna incolpare i maestri qualora il pugile, profittando dell'arte del pugilato, se ne serva ingiustamente", dice Platone nel Gorgia».
Il problema non esiste, quindi?
«È evidente che tutti gli sport da combattimento devono porsi il problema della formazione degli atleti. Le Mma, che sono una disciplina recente, devono anch'esse affrontare questa questione. Se tu dai degli strumenti di offesa, devi anche dare la cornice culturale e simbolica per utilizzarli correttamente, ma mi pare che tutti i volti noti delle Mma abbiano mostrato la giusta sensibilità».