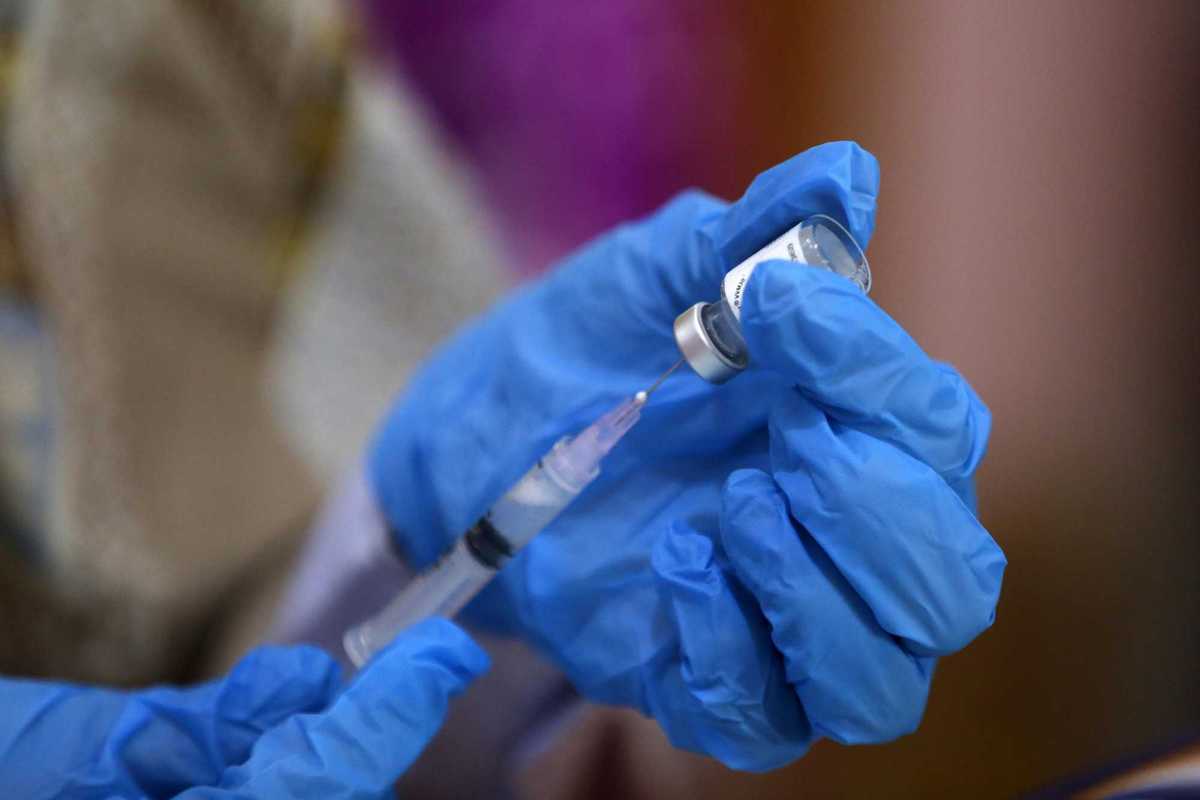True
2022-04-04
La morte dei centri storici
C’era una volta il centro storico. Un tempo cuore pulsante delle città, oggi luoghi dimenticati, perfino bistrattati. Fatte salve le grandi città, nelle quali ancora il turismo rappresenta un’ancora di salvezza, nella provincia italiana i centri storici si sono trasformati in quello che erano una volta le periferie: nella migliore delle ipotesi dormitori, nella peggiore quartier generale della criminalità e dello spaccio di droga. Sempre più anziani, tanti stranieri e meno negozi. Complice la diffusione dello smart working, i giovani preferiscono stabilirsi dove le case costano meno.L’identikit che viene fuori dagli studi più recenti sui centri storici fa venire i brividi. Per decenni la politica ha trascurato questa tematica, permettendo che una parte del nostro patrimonio culturale, architettonico, immobiliare e commerciale perdesse valore. Eppure, non tutto è perduto. La Verità ha intervistato Mariano Bella, direttore dell’Ufficio studi di Confcommercio, e Stefano Storchi, vicepresidente dell’Associazione nazionale centri storico-artistici, per discutere delle possibili soluzioni volte ad arrestare questo declino.
In 10 anni persi 85.000 punti vendita. Chiusi ferramenta, librerie e boutique
Va male, anzi malissimo il commercio nei centri storici italiani. Secondo l’ultimo rapporto Città e demografia d’impresa, presentato a fine febbraio dall’Ufficio studi di Confcommercio, nel decennio 2012-2021 in Italia sono spariti complessivamente 85.000 negozi, con un trend nel periodo (-16,4%) più negativo rispetto agli esercizi con sede fuori dal centro storico (-15,3%). Lo studio, che prende in esame i dati di 110 Comuni di medie dimensioni mette in evidenza una differenza ancora più marcata tra i negozi dei centri storici del Sud, i quali fanno registrare una flessione del 14,4%, rispetto alle unità locali della prima periferia (-12,1%). Se prendiamo in considerazione solo l’ultimo biennio, invece, il commercio al dettaglio in sede fissa dei centri storici fa segnare un -1,2% (contro il -0,7% dei negozi fuori dal centro) e il commercio ambulante un rotondo -3% (in periferia lo stesso settore è calato dell’1,3%).
La forchetta è solo apparentemente esigua perché, fanno notare da Confcommercio, perdere un negozio al centro storico non equivale a perderne uno in periferia. Nel centro, infatti, «le sostituzioni sono tecnicamente molto più difficili», ragion per cui «le riduzioni nei centri pesano di più proprio con riferimento all’eventuale riduzione dei livelli di servizio». C’è settore e settore, ma dall’analisi emerge una vera e propria emorragia dei classici esercizi sotto casa. Crollano i negozi di mobili e ferramenta (-28,2%), libri e giocattoli (-27,9%), vestiario e calzature (-18,9%), ma soffrono perfino gli alimentari (-3,4%) e i tabaccai (-1,3%). «Questi negozi escono dai centri storici, anzi quasi scompaiono, per trasformarsi nell’offerta delle grandi superfici specializzate fuori dalle città, oppure si riaggregano nei centri commerciali ultra-periferici», spiegano allarmati da Confcommercio, «un fenomeno che comporta una minaccia per la vitalità delle nostre città». Discorso diverso per i carburanti (-36%) che per questioni di architettura urbana si spostano verso l’esterno delle città. Risultato in controtendenza, ma comprensibile alla luce di una metamorfosi in atto già da svariati anni, quello fatto segnare dalle farmacie (+18,1%) e dai negozi di telefonia (+15,8%).
«Salute e tecnologia», si legge nella relazione, «sono poli attrattori dei consumi». La pandemia si fa sentire, acuendo i trend di lungo termine con una «precisione chirurgica»: quei settori che «hanno tenuto o che stavano crescendo cresceranno ancora, quelli in declino rischiano proprio di scomparire dai centri storici». Va decisamente meglio il turismo, con una crescita nell’ultimo decennio sia di alberghi (+46,3%) che di bar e ristoranti (+10,5%) a un passo superiore rispetto a quello delle periferie. Con qualche punto di domanda legato al Covid. «Nei centri storici delle città, soprattutto quelle più vocate al turismo», spiegano i relatori, «alla riduzione degli esercizi commerciali la pandemia ha inflitto il fenomeno del tutto nuovo della riduzione degli alberghi favorendo una crescita tumultuosa delle altre attività di alloggio».
Tanti anziani e persone che vivono sole. Si creano nuovi ghetti per gli stranieri
È un ritratto a tinte fosche quello che viene fuori dal rapporto Centri storici e futuro del Paese, a cura dell’Associazione nazionale dei centri storico artistici (Ancsa) e Centro ricerche economiche e sociali del mercato dell’edilizia (Cresme). Uno studio risalente al 2017 e basato sui dati del censimento Istat 2011, ma che rappresenta a tutt’oggi un imprescindibile punto di riferimento per comprendere la trasformazione sociale e demografica in atto nei nuclei delle nostre città. Fa riflettere che questa pubblicazione sia stata preceduta da un buco trentennale in materia di ricerche sulla situazione complessiva dei nostri centri storici.
Eppure, neanche a dirlo, questi luoghi rappresentano «un eccezionale perno economico terziario», oltre che sede della «concentrazione del patrimonio storico-architettonico italiano». Permettere che i centri storici sfioriscano equivale a dissipare una parte importante della ricchezza del nostro Paese. L’analisi mostra come «i centri storici siano segnati da una maggiore presenza di anziani (336.517) e da una minore presenza di giovani con meno di 15 anni (183.578)», segno che il problema dell’invecchiamento della popolazione, già di per sé drammatico, in queste aree si fa sentire ancora di più. Con differenze profonde a seconda della singola realtà analizzata: se a Pescara l’indice di dipendenza anziani è pari al 52% e gli anziani sono cresciuti del 39,9%, a Palermo l’indice di dipendenza è il 28,9% e gli anziani, secondo il censimento, sono diminuiti del 63,9% rispetto al 2001.
Nel complesso, osserva lo studio, «certamente i centri storici si presentano come luoghi dove nascono pochi bambini e […] abitano famiglie con pochi figli». Un capitolo a parte riguarda i cittadini stranieri. Nei centri storici esaminati sono censiti 174.151 residenti stranieri, pari al 3,8% dei 4,6 milioni di stranieri residenti in Italia ma all’11,7% della popolazione residente nei centri storici, contro il 7,9% rispetto alle zone non appartenenti al centro storico. Cifre di fronte alle quali gli autori si trovano costretti ad ammettere che, al netto dei distinguo in materia di immigrazione regolare, i centri storici rappresentano i luoghi «in cui si concentra la popolazione straniera». Anche in questo caso il fenomeno presenta risvolti e intensità diverse a seconda dell’area geografica considerata. Se a Modena, Roma e Brescia gli stranieri rappresentano un quinto degli abitanti del centro storico, in molte città del Centro Sud (da Pescara ad Avellino passando per Potenza e Nuoro), questo rapporto scende a meno di 1 straniero su 20 abitanti.Cambia la demografia e di conseguenza anche il panorama immobiliare. Più di un quinto delle abitazioni (21%) dei centri storici sono vuote, contro appena una su 10 (11,7%) del resto del Comune. Complessivamente, il valore residenziale delle abitazioni di 109 Comuni calcolato dall’Ancsa-Cresme è pari a 224 miliardi di euro, un terzo dei quali riconducibili alle sole città di Milano e Roma. «Quanta qualità con così poche risorse», chiosa mestamente il rapporto, «è proprio una questione di cultura».
«Il decentramento ha creato deserti»
Stefano Storchi, vicepresidente Ancsa e docente all’università di Parma, il vostro studio sulla situazione risale ormai al 2017. Nel frattempo, e non solo per via della pandemia, di acqua sotto ai ponti ne è passata davvero tanta...
«Già nella presentazione avevamo sottolineato il fatto che quel rapporto nasceva dall’esigenza di colmare un vuoto trentennale contrassegnato dalla mancanza di analisi sulla situazione dei centri storici. Si tratta di un lavoro che senza dubbio presentava limiti, ma a suo modo prezioso».
Come vi siete mossi in questi anni?
«Ci siamo posti come obiettivo la creazione di un osservatorio sui centri storici e l’abbiamo attivato su situazioni a campione, come ad esempio Bergamo, Torino e Genova, anche se il lavoro non è ultimato. Ogni città ha le proprie peculiarità, per questioni legate non solo alla morfologia del territorio, ma anche alla composizione economica e sociale. Si possono individuare dei punti in comune, ma esportare ricette universali è difficile».
Si potrebbe partire dalla definizione di centro storico.
«I centri storici sono tutto tranne che realtà omogenee. Pensiamo al centro di Bologna, che ha zone diversamente fruite e in cui assai diversi sono i valori di mercato. Un aspetto che emerge dallo studio del 2017 è per l’appunto la presenza di situazioni contraddittorie all’interno dello stesso centro urbano».
E poi c’è il rapporto con le periferie.
«Questo, paradossalmente, può diventare una risorsa perché c’è un’osmosi continua tra centri e aree contigue. I centri storici hanno mancanze di risorse che possono trovare nelle aree esterne, un po’ come ha fatto Parma a seguito della riqualificazione urbana di fine anni Novanta, dove le strutture culturali collocate appena fuori dal centro alla fine vivono in simbiosi con esso».
Trovare un equilibrio è possibile?
«Ci siamo concentrati per anni sull’esigenza di “ricucire le periferie”, che non è un concetto sbagliato ma non va visto in contrapposizione con i centri storici. La logica del decentramento è stata positiva o negativa? In alcuni casi ha funzionato, altrove ha creato deserti urbani. La verità è che periferie e centri storici vanno visti come un tutt’uno».
Quanto ha inciso la pandemia sul modo di vivere il centro storico?
«L’impatto del Covid è stato su più livelli: da un lato c’è l’esigenza di ripensare gli spazi per i residenti, d’altro canto ci troviamo a dover affrontare la mancanza di utenza esterna legata allo stop di fenomeni fino ad allora in apparenza inarrestabili, come i bed and breakfast e Airbnb. Senza un equilibrio tra l’offerta per i residenti e quella per i turisti non si va da nessuna parte».
Continua a leggereRiduci
Spariscono le botteghe tradizionali (e non solo quelle), i residenti invecchiano, i sindaci pensano a fare soldi con le multe in Ztl, gli urbanisti parlano solo di «ricucire le periferie» e lo smart working ha inferto il colpo definitivo. Erano il cuore delle città, ora il loro destino è segnato.Il vicepresidente Ancsa Stefano Storchi: «Ci siamo concentrati per anni sul tentativo di riqualificare i sobborghi dimenticandoci però di creare servizi per chi vive nelle zone più centrali».Lo speciale contiene quattro articoliC’era una volta il centro storico. Un tempo cuore pulsante delle città, oggi luoghi dimenticati, perfino bistrattati. Fatte salve le grandi città, nelle quali ancora il turismo rappresenta un’ancora di salvezza, nella provincia italiana i centri storici si sono trasformati in quello che erano una volta le periferie: nella migliore delle ipotesi dormitori, nella peggiore quartier generale della criminalità e dello spaccio di droga. Sempre più anziani, tanti stranieri e meno negozi. Complice la diffusione dello smart working, i giovani preferiscono stabilirsi dove le case costano meno.L’identikit che viene fuori dagli studi più recenti sui centri storici fa venire i brividi. Per decenni la politica ha trascurato questa tematica, permettendo che una parte del nostro patrimonio culturale, architettonico, immobiliare e commerciale perdesse valore. Eppure, non tutto è perduto. La Verità ha intervistato Mariano Bella, direttore dell’Ufficio studi di Confcommercio, e Stefano Storchi, vicepresidente dell’Associazione nazionale centri storico-artistici, per discutere delle possibili soluzioni volte ad arrestare questo declino.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-morte-dei-centri-storici-2657086110.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="in-10-anni-persi-85-000-punti-vendita-chiusi-ferramenta-librerie-e-boutique" data-post-id="2657086110" data-published-at="1649012667" data-use-pagination="False"> In 10 anni persi 85.000 punti vendita. Chiusi ferramenta, librerie e boutique Va male, anzi malissimo il commercio nei centri storici italiani. Secondo l’ultimo rapporto Città e demografia d’impresa, presentato a fine febbraio dall’Ufficio studi di Confcommercio, nel decennio 2012-2021 in Italia sono spariti complessivamente 85.000 negozi, con un trend nel periodo (-16,4%) più negativo rispetto agli esercizi con sede fuori dal centro storico (-15,3%). Lo studio, che prende in esame i dati di 110 Comuni di medie dimensioni mette in evidenza una differenza ancora più marcata tra i negozi dei centri storici del Sud, i quali fanno registrare una flessione del 14,4%, rispetto alle unità locali della prima periferia (-12,1%). Se prendiamo in considerazione solo l’ultimo biennio, invece, il commercio al dettaglio in sede fissa dei centri storici fa segnare un -1,2% (contro il -0,7% dei negozi fuori dal centro) e il commercio ambulante un rotondo -3% (in periferia lo stesso settore è calato dell’1,3%). La forchetta è solo apparentemente esigua perché, fanno notare da Confcommercio, perdere un negozio al centro storico non equivale a perderne uno in periferia. Nel centro, infatti, «le sostituzioni sono tecnicamente molto più difficili», ragion per cui «le riduzioni nei centri pesano di più proprio con riferimento all’eventuale riduzione dei livelli di servizio». C’è settore e settore, ma dall’analisi emerge una vera e propria emorragia dei classici esercizi sotto casa. Crollano i negozi di mobili e ferramenta (-28,2%), libri e giocattoli (-27,9%), vestiario e calzature (-18,9%), ma soffrono perfino gli alimentari (-3,4%) e i tabaccai (-1,3%). «Questi negozi escono dai centri storici, anzi quasi scompaiono, per trasformarsi nell’offerta delle grandi superfici specializzate fuori dalle città, oppure si riaggregano nei centri commerciali ultra-periferici», spiegano allarmati da Confcommercio, «un fenomeno che comporta una minaccia per la vitalità delle nostre città». Discorso diverso per i carburanti (-36%) che per questioni di architettura urbana si spostano verso l’esterno delle città. Risultato in controtendenza, ma comprensibile alla luce di una metamorfosi in atto già da svariati anni, quello fatto segnare dalle farmacie (+18,1%) e dai negozi di telefonia (+15,8%). «Salute e tecnologia», si legge nella relazione, «sono poli attrattori dei consumi». La pandemia si fa sentire, acuendo i trend di lungo termine con una «precisione chirurgica»: quei settori che «hanno tenuto o che stavano crescendo cresceranno ancora, quelli in declino rischiano proprio di scomparire dai centri storici». Va decisamente meglio il turismo, con una crescita nell’ultimo decennio sia di alberghi (+46,3%) che di bar e ristoranti (+10,5%) a un passo superiore rispetto a quello delle periferie. Con qualche punto di domanda legato al Covid. «Nei centri storici delle città, soprattutto quelle più vocate al turismo», spiegano i relatori, «alla riduzione degli esercizi commerciali la pandemia ha inflitto il fenomeno del tutto nuovo della riduzione degli alberghi favorendo una crescita tumultuosa delle altre attività di alloggio». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-morte-dei-centri-storici-2657086110.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="tanti-anziani-e-persone-che-vivono-sole-si-creano-nuovi-ghetti-per-gli-stranieri" data-post-id="2657086110" data-published-at="1649012667" data-use-pagination="False"> Tanti anziani e persone che vivono sole. Si creano nuovi ghetti per gli stranieri È un ritratto a tinte fosche quello che viene fuori dal rapporto Centri storici e futuro del Paese, a cura dell’Associazione nazionale dei centri storico artistici (Ancsa) e Centro ricerche economiche e sociali del mercato dell’edilizia (Cresme). Uno studio risalente al 2017 e basato sui dati del censimento Istat 2011, ma che rappresenta a tutt’oggi un imprescindibile punto di riferimento per comprendere la trasformazione sociale e demografica in atto nei nuclei delle nostre città. Fa riflettere che questa pubblicazione sia stata preceduta da un buco trentennale in materia di ricerche sulla situazione complessiva dei nostri centri storici. Eppure, neanche a dirlo, questi luoghi rappresentano «un eccezionale perno economico terziario», oltre che sede della «concentrazione del patrimonio storico-architettonico italiano». Permettere che i centri storici sfioriscano equivale a dissipare una parte importante della ricchezza del nostro Paese. L’analisi mostra come «i centri storici siano segnati da una maggiore presenza di anziani (336.517) e da una minore presenza di giovani con meno di 15 anni (183.578)», segno che il problema dell’invecchiamento della popolazione, già di per sé drammatico, in queste aree si fa sentire ancora di più. Con differenze profonde a seconda della singola realtà analizzata: se a Pescara l’indice di dipendenza anziani è pari al 52% e gli anziani sono cresciuti del 39,9%, a Palermo l’indice di dipendenza è il 28,9% e gli anziani, secondo il censimento, sono diminuiti del 63,9% rispetto al 2001. Nel complesso, osserva lo studio, «certamente i centri storici si presentano come luoghi dove nascono pochi bambini e […] abitano famiglie con pochi figli». Un capitolo a parte riguarda i cittadini stranieri. Nei centri storici esaminati sono censiti 174.151 residenti stranieri, pari al 3,8% dei 4,6 milioni di stranieri residenti in Italia ma all’11,7% della popolazione residente nei centri storici, contro il 7,9% rispetto alle zone non appartenenti al centro storico. Cifre di fronte alle quali gli autori si trovano costretti ad ammettere che, al netto dei distinguo in materia di immigrazione regolare, i centri storici rappresentano i luoghi «in cui si concentra la popolazione straniera». Anche in questo caso il fenomeno presenta risvolti e intensità diverse a seconda dell’area geografica considerata. Se a Modena, Roma e Brescia gli stranieri rappresentano un quinto degli abitanti del centro storico, in molte città del Centro Sud (da Pescara ad Avellino passando per Potenza e Nuoro), questo rapporto scende a meno di 1 straniero su 20 abitanti.Cambia la demografia e di conseguenza anche il panorama immobiliare. Più di un quinto delle abitazioni (21%) dei centri storici sono vuote, contro appena una su 10 (11,7%) del resto del Comune. Complessivamente, il valore residenziale delle abitazioni di 109 Comuni calcolato dall’Ancsa-Cresme è pari a 224 miliardi di euro, un terzo dei quali riconducibili alle sole città di Milano e Roma. «Quanta qualità con così poche risorse», chiosa mestamente il rapporto, «è proprio una questione di cultura». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-morte-dei-centri-storici-2657086110.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="il-decentramento-ha-creato-deserti" data-post-id="2657086110" data-published-at="1649012667" data-use-pagination="False"> «Il decentramento ha creato deserti» Stefano Storchi, vicepresidente Ancsa e docente all’università di Parma, il vostro studio sulla situazione risale ormai al 2017. Nel frattempo, e non solo per via della pandemia, di acqua sotto ai ponti ne è passata davvero tanta... «Già nella presentazione avevamo sottolineato il fatto che quel rapporto nasceva dall’esigenza di colmare un vuoto trentennale contrassegnato dalla mancanza di analisi sulla situazione dei centri storici. Si tratta di un lavoro che senza dubbio presentava limiti, ma a suo modo prezioso». Come vi siete mossi in questi anni? «Ci siamo posti come obiettivo la creazione di un osservatorio sui centri storici e l’abbiamo attivato su situazioni a campione, come ad esempio Bergamo, Torino e Genova, anche se il lavoro non è ultimato. Ogni città ha le proprie peculiarità, per questioni legate non solo alla morfologia del territorio, ma anche alla composizione economica e sociale. Si possono individuare dei punti in comune, ma esportare ricette universali è difficile». Si potrebbe partire dalla definizione di centro storico. «I centri storici sono tutto tranne che realtà omogenee. Pensiamo al centro di Bologna, che ha zone diversamente fruite e in cui assai diversi sono i valori di mercato. Un aspetto che emerge dallo studio del 2017 è per l’appunto la presenza di situazioni contraddittorie all’interno dello stesso centro urbano». E poi c’è il rapporto con le periferie. «Questo, paradossalmente, può diventare una risorsa perché c’è un’osmosi continua tra centri e aree contigue. I centri storici hanno mancanze di risorse che possono trovare nelle aree esterne, un po’ come ha fatto Parma a seguito della riqualificazione urbana di fine anni Novanta, dove le strutture culturali collocate appena fuori dal centro alla fine vivono in simbiosi con esso». Trovare un equilibrio è possibile? «Ci siamo concentrati per anni sull’esigenza di “ricucire le periferie”, che non è un concetto sbagliato ma non va visto in contrapposizione con i centri storici. La logica del decentramento è stata positiva o negativa? In alcuni casi ha funzionato, altrove ha creato deserti urbani. La verità è che periferie e centri storici vanno visti come un tutt’uno». Quanto ha inciso la pandemia sul modo di vivere il centro storico? «L’impatto del Covid è stato su più livelli: da un lato c’è l’esigenza di ripensare gli spazi per i residenti, d’altro canto ci troviamo a dover affrontare la mancanza di utenza esterna legata allo stop di fenomeni fino ad allora in apparenza inarrestabili, come i bed and breakfast e Airbnb. Senza un equilibrio tra l’offerta per i residenti e quella per i turisti non si va da nessuna parte».