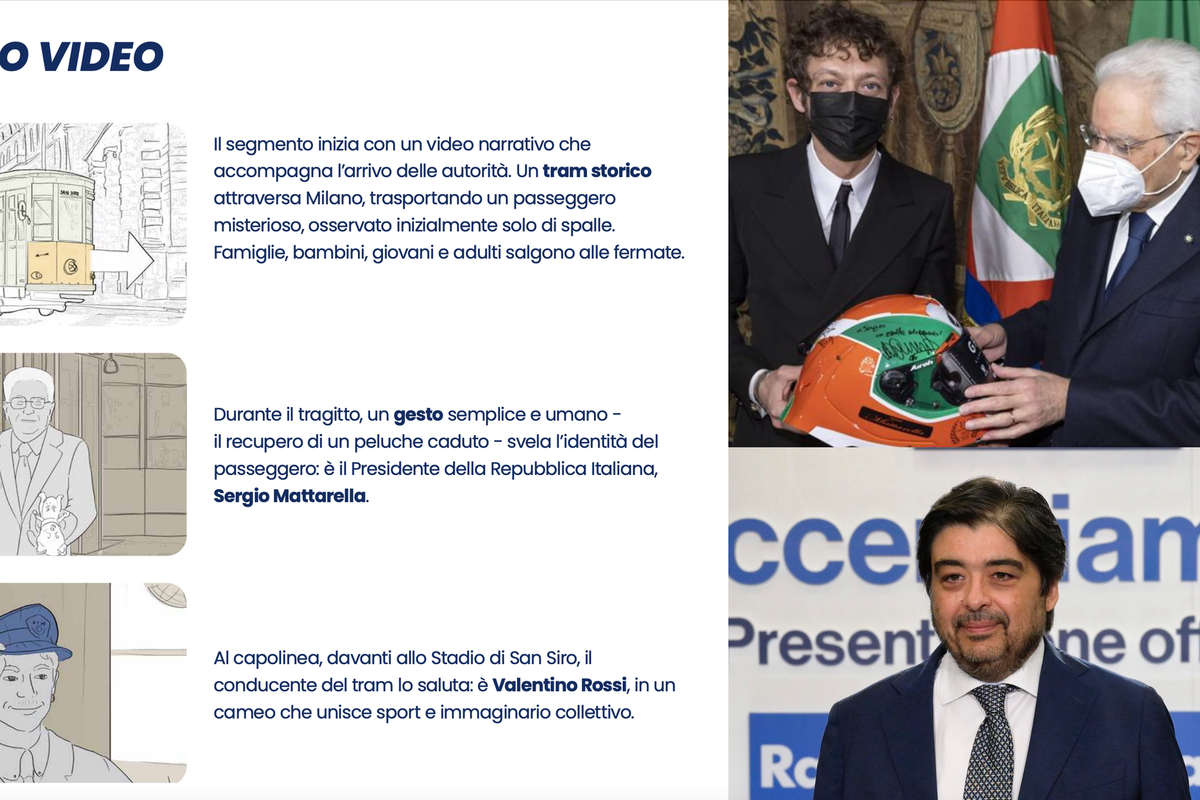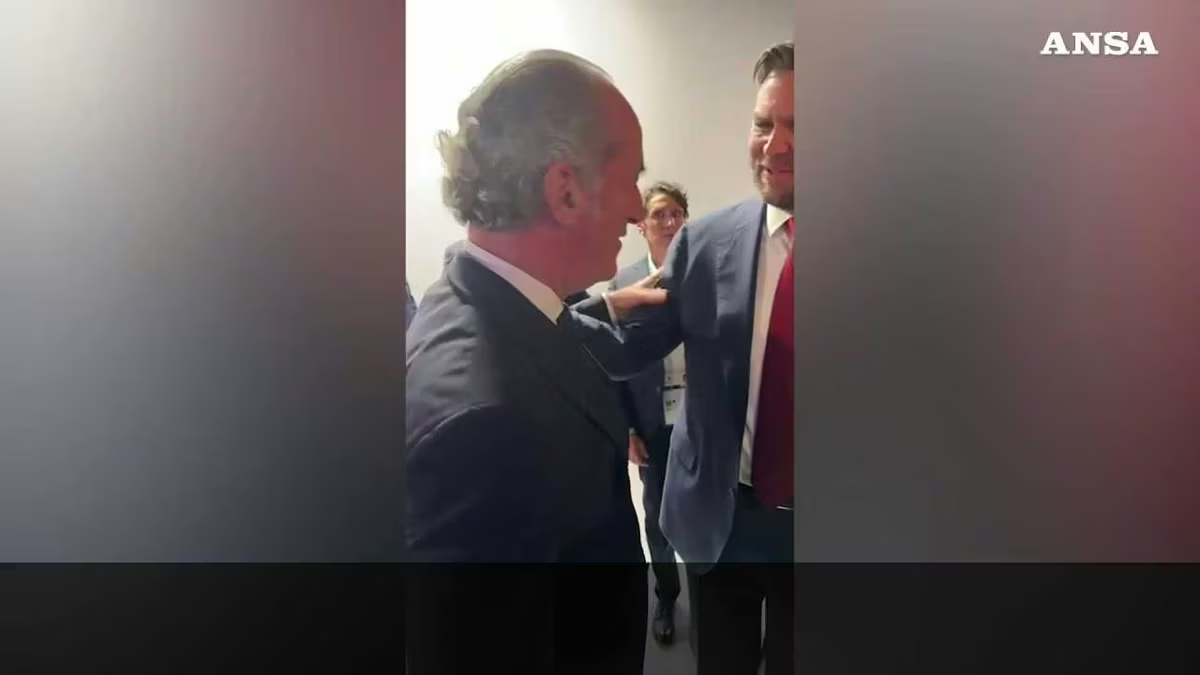Potremmo chiamarla la guerra dei sedici anni: cominciata nel 1982 e conclusa nel 1998, con un prolungamento al 2006 quando Unipol - finanza rossa che ha ampiamente banchettato nella stagione del venditore Romano Prodi -cede a Bnp Paribas il pacchetto di Bnl. È la guerra per banche - Credito italiano, Comit (Banca commerciale italiana) e Banco di Roma, le banche d'interesse nazionale e Mediobanca, con a cascata due terzi del sistema creditizio, che era stato indispensabile per trasformare l'Italia da Paese sconfitto e agricolo in quinta potenza mondiale - condotta dalla Dc. Armò Romano Prodi come burattino, aveva in Beniamino Andreatta il grande burattinaio che riuscì a costruirsi alleanze interessate nel campo di Agramante. Lo stratega di tutto pro domo Bilderberg - i finanzieri senza volto che possono essere rappresentati dalla Goldman Sachs da cui sono passati Mario Draghi, Mario Monti e lo stesso Prodi - fu il rampante Draghi, come intendente s'ebbe Giuliano Amato e come gran cerimoniere Carlo Azeglio Ciampi. È una guerra di continui tradimenti che convinse gli ex Pci che per far cadere la conventio ad excludendum bisognava allearsi con la finanza. Se oggi i piddini sono ultraliberisti si deve proprio a quella guerra disgraziata che ha avuto un solo scopo: depatrimonializzare il sistema Italia per servirlo su un piatto d'argento alla Germania padrona d'Europa, che mal sopporta il protagonismo imprenditoriale di questi meridionali furbi, indebitati e gaudenti che sono gli italiani.
L'Italia è stata offerta da Romano Prodi per pochi spiccioli (solo dagli errori nella privatizzazione delle banche c'è un mancato incasso tra i 10 e i 15 miliardi di euro), ma certo non solo da lui, all'Europa come bottino della guerra per banche. La Dc, già negli anni Ottanta, cominciava ad avere carenza d'intelletto ed eccesso d'appetito nei suoi alti vertici, ma soprattutto mal sopportava che l'imprenditoria diventasse del tutto autonoma dal potere politico. Se oggi il Monte dei Paschi di Siena è stato rinazionalizzato perché la sinistra non si straccia le vesti come fa nell'ipotesi di Autostrade? Perché Confindustria, che dovrebbe guardare meglio i bilanci del Sole 24 Ore sulla banca senese, costata al contribuente più di 5 miliardi, tace e strilla invece in difesa dei Benetton? Se ci sono state le ruberie e gli scandali di Banca Etruria, se la Bce in Italia impera è perché ci sono i frutti avvelenati di quella guerra.
Prodi non la vinse, ma anche il capitalismo italiano ne uscì con le ossa rotte, perché le grandi famiglie - in realtà una sola: gli Agnelli che come i veri reali d'Italia hanno mostrato un eccesso di pavidità -decisero un armistizio e i vassalli si accomodarono in una sorta di pax retribuita. Luigi Abete ne è l'emblema: tipografo che vive di commesse pubbliche, si ritrova presidente di Confindustria nel 1992 per la rinuncia di Cesare Romiti e finirà per diventare presidente di Bnl (Banque national du travail). La Banca nazionale del lavoro è uno degli effetti collaterali.
La guerra per banche si scatenò anche per episodi marginali, ma i conflitti cominciano sempre con uno sparo a Sarajevo. Romano Prodi, per dirne una, aveva un problemino aperto con la neonata Nomisma - il suo think tank bolognese - finanziata da Bnl e controllata dal Tesoro di cui era ministro Beniamino Andreatta, che ricevette un mega contratto dal ministero degli Esteri mentre Prodi era presidente di Iri e di Nomisma stessa. Andreatta doveva evitare che lo scandalo Ambrosiano-Ior travolgesse Giovanni Bazoli, che con il nuovo Banco ambrosiano veneto stava operando per evitare che la finanza vaticana fosse toccata dalle inchieste. Lo stesso Bazoli chiedeva un posto al sole nell'alta finanza. Cominciò così il conflitto che si combatté principalmente attorno a Mediobanca.
Il nemico del sistema Prodi era Enrico Cuccia. Occorrerà dire in premessa che formalmente Mediobanca era un istituto di mediocredito, poi divenuto merchant bank partecipata da Banca commerciale italiana e Banco di Roma (due delle Bin che Prodi privatizzerà, controllate dal'Iri). Non ha mai fatto intermediazione, solo finanziamento. Fu fondata da Enrico Cuccia e da Raffaele Mattioli, che era già presidente di Comit, lo zoccolo duro dell'industria italiana, vero lievito della crescita economica post bellica dell'Italia e dell'intellighenzia economica laica e antifascista: Ugo La Malfa ne era stato un suo alto dirigente. Dopo lo scandalo dell'Ambrosiano (1977-1982) Cuccia voleva a ogni costo sfilare Mediobanca dalle due banche e privatizzarla. La Dc sapeva che se fosse accaduto tutto il sistema industriale privato le sarebbe sfuggito di mano. Tra il 1979 e il 1982 la Dc impose in Mediobanca Fausto Calabria come presidente, la pensione a Cuccia e soprattutto nel 1982 nominò Romano Prodi presidente dell'Iri. Cuccia capì che la privatizzazione non sarebbe passata. Così organizzò una cordata estera, capofila la francese Lazard, e nel 1985 tornò in consiglio di Mediobanca. Nel 1986 Cuccia ripresentò il progetto di privatizzazione: Banco di Roma, dipendente dalla Dc, disse no, Credito italiano disse sì, la Commerciale era divisa e Prodi cacciò il presidente di Comit, ma nel frattempo a presiedere Mediobanca era arrivato Antonio Maccanico, che con l'appoggio di Francesco Cossiga (e le continue minacce dei repubblicani, sia dentro l'Iri con Pietro Armani, sia al governo con Giovanni Spadolini di far saltare il banco), che tesse la tela con il Psi, fu varato il progetto di privatizzazione.
Prodi - il privatizzatore - aveva perso proprio su una privatizzazione. Ma lo schema creditizio immaginato dalla Dc non poteva saltare. E così si riprese a tessere la tela. Prodi si prese, grazie a Mario Draghi e a Giuliano Amato una sua prima rivincita. Draghi da direttore generale del Tesoro affiancò Giuliano Amato nella riscrittura della legge bancaria. È indispensabile in questa fase trovare chi farà credito a chi vuole comprarsi lo spezzatino delle privatizzazioni inventato da Romano Prodi nella sua prima presidenza Iri, quando regalò l'Alfa agli Agnelli - sperando d'ingraziarsi anche Cuccia, che non era uomo da esercitare gratitudine - e tentò di donare la Sme a De Benedetti (che Cuccia non ha mai potuto sopportare). Nel 1990 il nuovo testo della legge bancaria sancisce che la banche diventano Spa e che il controllo passa nella mani delle neonate fondazioni. Due anni più tardi Andreatta avverte che l'Italia avvierà le privatizzazioni: un bottino da 180.000 miliardi.
Gli gnomi della finanza si scaldano: George Soros - il benefattore dei migranti - lancia l'offensiva sulla lira e l'Italia, finite le privatizzazioni, porterà a casa la metà del valore ceduto. Carlo Azeglio Ciampi, allora governatore di Bankitalia, benedice la legge, ma tre anni più tardi farà un passo ulteriore che sfascia di fatto il sistema. Divenuto presidente del Consiglio l'11 giugno del 1993 fa decadere per le banche il divieto di possedere più del 15% del capitale di industrie. Il giorno prima la Banca d'Italia manda a tutti gli istituiti di credito una lettera in cui dice che i prestiti concessi a società dell'Iri sono a rischio zero, perché garantito dallo Stato. È il grimaldello per vendere agli amici degli amici, finanziando le privatizzazioni con i soldi delle banche che peraltro sono di proprietà dell'Iri.
Nel 1993 Romano Prodi torna presidente dell'Iri per finire il lavoro. Lui conosce un solo modo: svendere a pezzi al peggior offerente. Ma nel governo Ciampi ci sono due tosti: Pietro Barucci e Paolo Savona, che resterà per sempre nemico giurato di Prodi. Barucci dice no all'idea di Prodi di creare delle public company (cedere le banche Iri con soglie di possesso di azioni bassissime) e Savona, che è ministro dell'Industria, si oppone fermamente alla cessione a spezzatino. Ciampi farà una mediazione ponendo il tetto al 3%.
Si arriva così alla vendita delle tre banche. Nel dicembre 1993 la prima a passare di mano è il Credito italiano. Neanche a farlo apposta l'advisor è Goldman Sachs, che valuta la banca 2.700 miliardi. Merrill Lynch appena un anno prima l'aveva valutata tra gli 8.000 e i 9.000 miliardi. Cuccia mette insieme una cordata e si piglia la banca. Poi tocca a Comit. Prodi lavora ancora all'idea di public company e prova a venderla in America, per questo chiama i suoi amici della Lehman Brothers, che stimano la banca poco sopra i 2.000 miliardi (due anni prima fu valutata tra i 10.000 e 12.000 miliardi). Ma Ciampi ha fretta e nel 1994, anno del centenario Comit, va all'asta. Stesso schema: Mediobanca fa banco!
Scottato, Prodi fa la finta privatizzazione del Banco di Roma che sarà fuso - grazie agli effetti della legge Amato -con la Cassa di Risparmio di Roma e con il Santo Spirito. Nasce Banca di Roma, il feudo di Cesare Geronzi che finanzierà lo spezzatino della Sme e la vendita di Telecom. Al termine di questa storia succederà che il Credito italiano andrà a rafforzare Unicredit, che poi assorbirà anche Banca di Roma, e Comit finirà complice di Bazoli in Intesa San Paolo, avviando una sorta di bulimia di acquisizioni. Alcune fatali come quella di Mps con Antonveneta.
Al termine di queste svendite anche la Banca d'Italia diventa di fatto privata. Il disegno perfetto di consegnare l'Italia mani e piedi all'Europa è compiuto ricavando dalle banche meno del 20 per cento del loro vero valore. Dirà, al termine delle svendite, Sergio Siglienti, sardo come Savona, presidente della Banca commerciale: «Due sono le versioni: o il presidente dell'Iri era d'accordo con Cuccia o Prodi era ingenuo o qualcosa di più… Io propendo per la seconda».
(2. Continua)