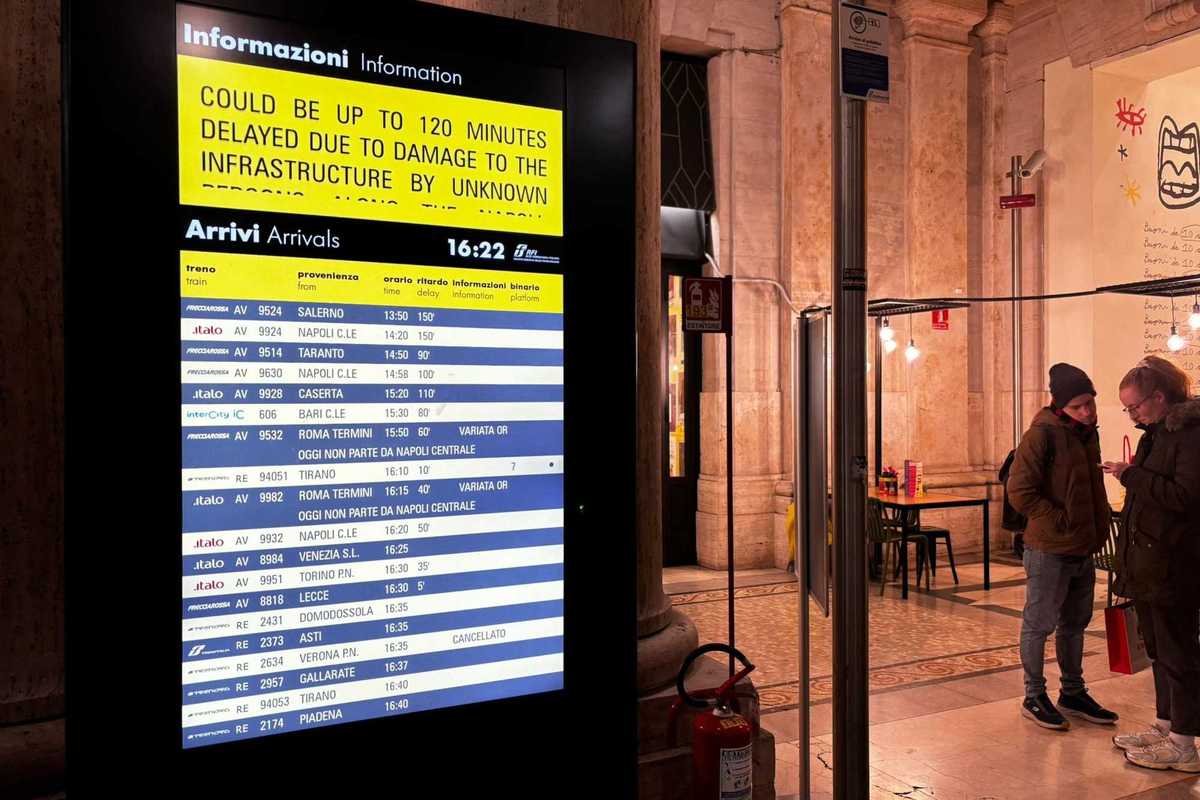La Verità ha già pubblicato due ottimi contributi di Daniele Capezzone e Carlo Tarallo che hanno messo in evidenza le criticità sottese alla sentenza 198 del 2021 della Corte costituzionale che, secondo la vulgata, avrebbe «salvato» i dpcm di Giuseppe Conte. A riguardo ci sentiamo di svolgere alcune riflessioni funzionali a inquadrare nel sistema di giustizia costituzionale italiana la recente pronuncia del giudice delle leggi.
La decisione di Palazzo della Consulta è, com'è noto, al contempo di inammissibilità e di rigetto: di inammissibilità perché il giudice di pace di Frosinone aveva indicato nella sua ordinanza di rimessione alla Corte disposizioni normative del decreto legge numero 6 del 2020 non più applicabili al giudizio pendente davanti a lui, in quanto era intervenuto il decreto-legge 19 del 2020 volto ad uniformare le diverse misure di contenimento per impedire la diffusione dell'agente virale Sars-Cov-2; di rigetto poiché il giudice costituzionale ritiene che non sussista la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione vigente, o meglio che l'attribuzione al presidente del Consiglio dei ministri pro tempore del potere di adottare i dpcm non costituisca una delega anomala, ma semplicemente una modalità di attuazione del decreto legge. La Corte, però, con la sua sentenza, non dichiara la conformità del decreto legge n. 19/2020 a Costituzione, ma si limita a giudicare non fondata l'eccezione di costituzionalità relativamente ai parametri, ossia alle sole norme costituzionali ed alle argomentazioni addotte, che il giudice di pace di Frosinone aveva invocato. Pertanto, nulla vieta a un altro giudice di poter adire la Corte, indicando diversi profili di possibile illegittimità sorretti da motivazioni differenti rispetto a quelle analizzate nella sentenza numero 198 del 2021.
Sarebbe, invece, stato interessante chiedere a Palazzo della Consulta se un provvedimento provvisorio avente forza di legge del governo, fondato sui presupposti giustificativi di straordinarietà, urgenza e necessità ai sensi dell'articolo 77, comma 2 della Costituzione, possa contenere disposizioni normative a efficacia differita (come per i vari decreti legge sul green pass), cioè idonee a produrre i loro effetti a distanza di tempo rispetto alla data della loro entrata in vigore e se un dpcm, un atto formalmente amministrativo non sottoposto ad alcun controllo preventivo (neppure da parte del presidente della Repubblica), abbia titolo per bilanciare interessi costituzionali contrapposti (la salute quale «interesse della collettività» e altri diritti costituzionalmente tutelati) sottraendoli alla valutazione del decisore politico e affidandoli unicamente al presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, anche ammesso che un decreto legge, in alcuni casi, presenti norme non immediatamente applicabili, questo, ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza numero 16 del 2017, può concernere «qualche aspetto» e non certamente interi decreti o una pluralità di misure di contenimento. Il rischio non è quello di legittimare un ulteriore abuso nella già bulimica decretazione legislativa di questo anno e mezzo di pandemia? Dovremmo, allora, rassegnarci all'affermarsi, sul piano sostanziale, di una nuova Costituzione dell'emergenza?