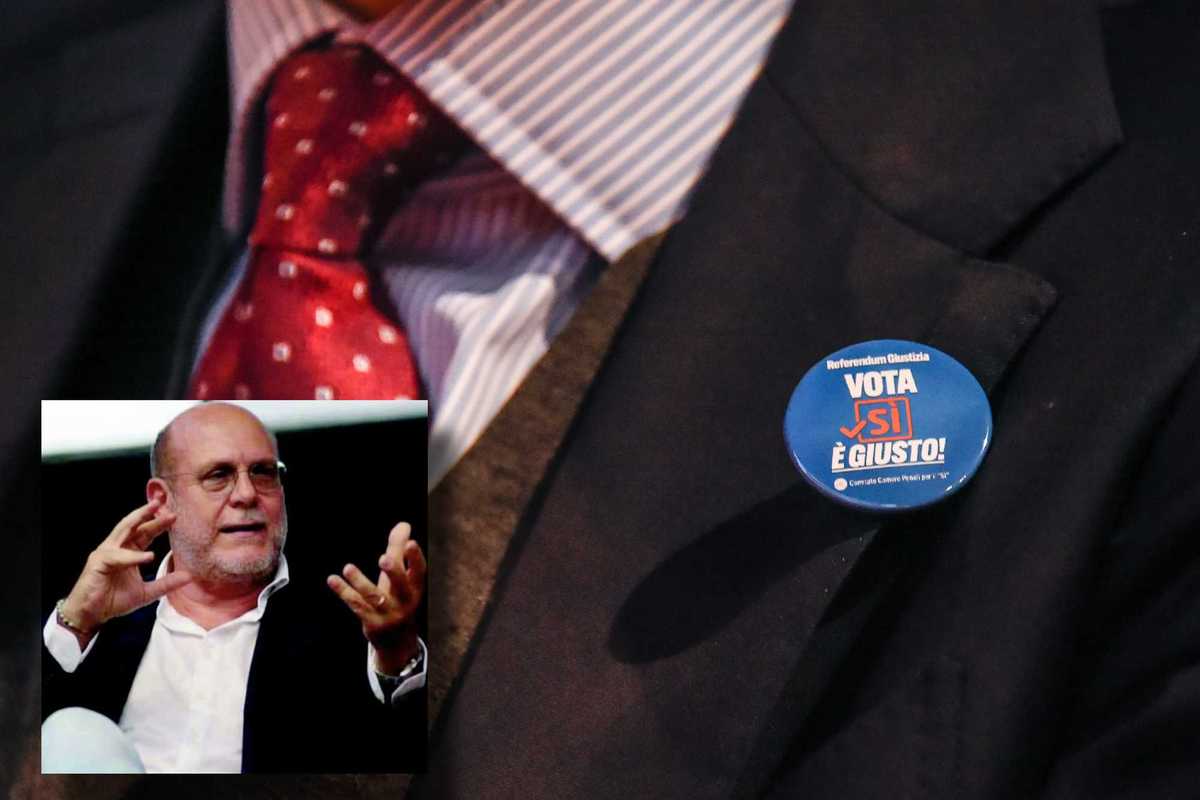True
2019-09-28
La Consulta e i partiti agitano il populismo per agire contro la sovranità popolare
Ansa
Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi.
Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare.
Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo.
Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute.
Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato.
L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. Che qualcuno, appellandosi all'articolo 1 della Costituzione, voglia che almeno una parte di questi fili venga tagliata non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo.
«È nata la “giuristocrazia”: le toghe si credono al di sopra dello Stato»
Agostino Carrino è uno dei più importanti giuristi italiani e studia da anni il rapporto tra politica e potere giudiziario. Un tema che è tornato ad approfondire nel suo recente La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità.
Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia?
«Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento».
No?
«Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni».
Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit.
«A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"».
Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto?
«Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice».
Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto?
«Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario».
Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse?
«Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza».
La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni.
«Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo».
Cioè?
«Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti».
Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo?
«Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è».
Dicono che non si può votare di continuo...
«In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni».
A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato?
«Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza».
Quali sono i rischi?
«Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
Continua a leggereRiduci
La Corte costituzionale crea nuove norme usurpando il ruolo del Parlamento. Il Quirinale sindaca nel merito i decreti legge.«È nata la "giuristocrazia": le toghe si credono al di sopra dello Stato». Lo studioso Agostino Carrino: «La decisione sul caso Cappato genererà sentenze disomogenee finché il Parlamento approverà una norma, che sarà un pessimo compromesso. Ma se i giudici legiferano è pure colpa della politica imbelle».Lo speciale comprende due articoli. Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi. Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare. Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo. Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute. Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato. L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. Che qualcuno, appellandosi all'articolo 1 della Costituzione, voglia che almeno una parte di questi fili venga tagliata non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-consulta-e-i-partiti-agitano-il-populismo-per-agire-contro-la-sovranita-popolare-2640672475.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="e-nata-la-giuristocrazia-le-toghe-si-credono-al-di-sopra-dello-stato" data-post-id="2640672475" data-published-at="1771915445" data-use-pagination="False"> «È nata la “giuristocrazia”: le toghe si credono al di sopra dello Stato» Agostino Carrino è uno dei più importanti giuristi italiani e studia da anni il rapporto tra politica e potere giudiziario. Un tema che è tornato ad approfondire nel suo recente La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità. Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia? «Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento». No? «Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni». Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit. «A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"». Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto? «Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice». Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto? «Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario». Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse? «Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza». La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni. «Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo». Cioè? «Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti». Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo? «Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è». Dicono che non si può votare di continuo... «In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni». A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato? «Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza». Quali sono i rischi? «Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
Vitkor Orbán e Robert Fico (Ansa)
Si apre oggi il quinto anno di guerra in Ucraina, ma le commemorazioni sono segnate dalle tensioni nel Vecchio Continente sul sostegno a Kiev. In occasione dell’anniversario, infatti, arriveranno oggi in Ucraina il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, António Costa, per manifestare «ampio sostegno» al «partner coraggioso e vicino». I due, oltre a incontrare il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, parteciperanno alla cerimonia commemorativa e visiteranno un sito infrastrutturale che porta i segni dei bombardamenti russi. Inoltre, è atteso un intervento da remoto di Zelensky durante la plenaria straordinaria del Parlamento europeo. E se il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha ricordato che dall’inizio della guerra si contano «15.000 morti civili» solo in Ucraina, la Banca mondiale ha fatto il punto sulla ripresa del Paese. Per ricostruirlo saranno necessari «588 miliardi di dollari in un orizzonte temporale di dieci anni, equivalenti a quasi tre volte il Pil dell’Ucraina del 2025». A tirare le somme dopo quattro anni di guerra è anche l’Unione europea: ha ricordato che dall’inizio del conflitto ha stanziato quasi 195 miliardi di euro di aiuti a Kiev. Eppure, le fratture a Bruxelles sono evidenti. Il piano della Commissione Ue di approvare il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, proprio in occasione dell’anniversario, è stato un buco nell’acqua. A opporsi sono state l’Ungheria e la Slovacchia nel Consiglio esteri dell’Ue. Il veto dei due Paesi proseguirà fino a quando non saranno ripristinate le forniture del petrolio russo dall’oleodotto Druzhba: per Kiev è stato danneggiato da Mosca il 27 gennaio, ma l’Ungheria e la Slovacchia hanno accusato l’Ucraina di non voler riavviare l’attività dell’oleodotto di proposito. E Budapest ha anche minacciato di bloccare il prestito di 90 miliardi di euro a Kiev. Intervenendo in merito, il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha dichiarato che è «un diritto sovrano decidere da dove provengano le fonti energetiche». Ha poi paragonato «i fanatici della guerra di Bruxelles» a «un uomo magrolino» che «cerca di mostrare i suoi bicipiti». Sulla stessa linea, il primo ministro slovacco, Robert Fico, che ha annunciato la sospensione delle forniture di energia elettrica di emergenza all’Ucraina. Queste posizioni hanno attirato duri rimproveri: la Germania si è detta «sbalordita», la Polonia ha parlato di «atto di sabotaggio politico», la Lituania è «arrabbiata e frustrata». Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato che «sbaglia chi non vuole fare delle scelte che spingano Mosca a venire a più miti consigli».
Nel tentativo di correre ai ripari, Costa ha già mandato una lettera al primo ministro ungherese, Vitkor Orbán, in merito al prestito da 90 miliardi a Kiev: «Ti invito fortemente a conformarti alla decisione presa al Consiglio europeo di dicembre». E ha fatto presente che oggi con Zelensky discuterà la questione dell’oleodotto. C’è da dire che l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, dopo il flop, ha lanciato un avvertimento: Bruxelles può «sempre lavorare» all’«uso dei beni russi congelati».
Ma le visioni opposte in Europa interessano anche l’eventuale dialogo con Mosca. A bocciare l’iniziativa francese è stato il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul: «È l’approccio sbagliato». A rincarare la dose è stata anche Kallas: «Prima di parlare con Mosca, dovremmo essere chiari su ciò di cui vogliamo discutere».
Tensioni europee a parte, i negoziati tra la Russia, l’Ucraina e gli Stati Uniti proseguono: si svolgeranno entro «la fine di questa settimana», ha detto il capo della squadra negoziale di Kiev, Kyrylo Budanov. Sul tavolo, stando a quanto riferito da Ukrainska Pravda, ci sarà anche il tema della gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. E pare anche che nelle precedenti trattative a Ginevra sia stata discussa, sempre secondo il giornale ucraino, la creazione della zona economica libera di 40 chilometri sotto un’eventuale supervisione del Board of Peace.
Nel frattempo, il presidente russo, Vladimir Putin, durante la consegna della medaglia Eroe della Russia, ha dichiarato che Mosca «sta combattendo per il suo futuro, per l’indipendenza, per la verità e la giustizia». E ha poi avvisato che «la priorità assoluta» rimane «lo sviluppo della triade nucleare». A provocare Kiev è stato invece il vicesegretario del Consiglio di sicurezza, Dmitrij Medvedev: «Il destino di Benito Mussolini e Adolf Hitler costituisce un esempio lampante per le attuali autorità» ucraine. E se la guerra dovesse finire, «nel peggiore dei casi», i leader di Kiev «saranno impiccati dal loro stesso popolo proprio sulla Maidan».
Dall’altra parte, Zelensky in un’intervista alla Bbc, ha accusato lo zar russo di aver già «scatenato una terza guerra mondiale». Il presidente gialloblù ha anche esortato la Nato a «considerare i missili Oreshnik un obiettivo legittimo». Zelensky è infatti convinto che sono stati «portati i veicoli necessari» in Bielorussia. Ma non solo: ha affermato che Minsk è in contatto con Mosca per «esercitazioni militari congiunte» sul territorio bielorusso. Intanto, per affrontare l’emergenza energetica, dall’Italia sono arrivati a Kiev dieci generatori.
Mosca resta la regina del grano
Dopo quattro anni di guerra sul fronte ucraino l’Europa si scopre sempre più debole sul terreno agricolo e l’Italia paga un prezzo altissimo. È la nuova battaglia del grano da cui esce sconfitta la politica agricola comunitaria ed esce a pezzi la cerealicoltura nostra ed emergono enormi ipocrisie.
Chi continua a raccontare che l’economia russa è a pezzi e che gli ucraini sono alla fame non ha fatto i conti con il report del centro studi Divulga, presieduto dal professor Piermichele La Sala, economista agrario - non a caso -dell’Università di Foggia, che ieri ha diffuso uno studio sull’andamento del mercato mondiale del grano. Divulga, che lavora in collaborazione con Coldiretti, lancia un allarme: con l’attuale congiuntura dei prezzi internazionali in Italia produrre grano non è conveniente. Ma non lo è nemmeno nell’Ue: da qui le fortissime pressioni che gli agricoltori polacchi, rumeni, francesi e bulgari hanno fatto affinché si reintroducesse un dazio sul prodotto ucraino. Facendo due conti - osserva Divulga - a gennaio la quotazione del grano duro era di 261,4 euro a tonnellata. Non va diversamente per il grano tenero nazionale: il prezzo medio all’origine ha raggiunto i 231,76 euro a tonnellata a gennaio 2026.
Diamo uno sguardo ai costi di produzione. Si certifica nello studio che per il grano duro «nel centro Italia e in Sicilia il costo medio risulta pari a 318 euro a tonnellata, nel Nord siamo a circa 302 euro a tonnellata; per il grano tenero il costo medio è di poco superiore ai 230 euro a tonnellata. In Italia, di fatto, si coltiva in rimessa. Questo giustifica le massicce importazioni dell’Ucraina. E questo rende palese che - scrive Divulga - la Russia in questi quattro anni di guerra ha consolidato il primato delle esportazioni mondiali di grano (16% su totale export mondiale), ma l’Ucraina, grazie soprattutto all’Unione Europea, non crolla. Dal giorno dell’invasione, le esportazioni mondiali di grano, soprattutto duro, della Russia sono aumentate in Paesi come Kazakhstan (+303%), Arabia Saudita (+1758%), Pakistan (+315%), Kenya (+115%), Brasile (+732%), Cina (+190%), Turchia (+22%).
L’Unione europea, in questi quattro anni, dopo un’impennata nel primo biennio del conflitto, ha visto praticamente azzerarsi gli arrivi diretti da Mosca, ma chi ne ha approfittato è la Turchia, che fa triangolazione e, nonostante sia Paese della Nato, importa da Mosca e rivende in Europa con un’impennata del 600% delle sue esportazioni verso l’Ue.
Peraltro l’export da Kiev verso l’Unione europea di grano, soprattutto tenero, ha visto un incremento del 386% rispetto al periodo pre bellico. L’Ucraina è passata da meno di un milione di tonnellate prima dello scoppio del conflitto a oltre 4,4 milioni di tonnellate nei quattro anni di guerra. Per quel che riguarda l’Italia questo significa che dipendiamo dall’Ucraina per circa un terzo del fabbisogno di tenero (sul milione mezzo di tonnellate) e dal Canada per quasi l’intero stock d’importazione del duro, che supera i 2,5 milioni di tonnellate. Con il Mercosur finiamo per reimportare da Argentina e Brasile il grano duro di Mosca vietato dalle sanzioni. Con Ursula von der Leyen concentrata sul riarmo abbiamo perso di vista che il grano è un’arma strategica. Lo sa benissimo la Cina, che con circa 151 milioni di tonnellate ha 45% delle scorte mondiali di grano, la Russia ha più che raddoppiato i propri stock. Incremento forte delle riserve anche da parte di Usa e India, l’Europa invece - osserva Divulga - «mostra una preoccupante contrazione del 37%, confermando il progressivo indebolimento del proprio peso (meno del 5% delle scorte mondiali) in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche».
In un eventuale conflitto avremo ottimi carri armati tedeschi, in futuro, ma potremmo essere sconfitti dalla fame, perché la guerra del grano è quella che fa più vittime.
Continua a leggereRiduci
È in corso una trasformazione demografica che è sotto gli occhi di tutti — basta guardare le nostre classi elementari — ma la politica sembra accorgersene solo quando può trarne vantaggio alle urne. Chi amministra oggi la verità in Europa? Stiamo vivendo la fine di un'era.
Nel riquadro Carmelo Cinturrino (Ansa)
Sarà l’interrogatorio di garanzia previsto questa mattina a San Vittore, di fronte al gip Domenico Santoro, il primo vero passaggio in cui l’assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino sarà chiamato a rispondere punto per punto non solo dello sparo che il 26 gennaio ha ucciso Abderrahim Mansouri, ma soprattutto di ciò che è accaduto subito dopo, nel boschetto di Rogoredo. È un quadro inquietante quello che gli inquirenti hanno delineato intorno a questo agente nato a Messina il 21 novembre del 1984, accusato di omicidio volontario e difeso dall’avvocato Pietro Porciani. Per la Procura che ha disposto il carcere, oltre al pericolo di fuga, risulta «concreto e attuale» sia il pericolo di inquinamento probatorio sia di reiterazione del reato, «alla luce della circostanza che il fermato ha dimostrato elevatissima capacità criminale».
Nelle carte firmate dal procuratore capo, Marcello Viola, e da Giovanni Tarzia si affaccia infatti anche un’altra ipotesi: che i quattro agenti inizialmente sentiti come persone informate sui fatti possano aver fornito versioni in linea con quella di Cinturrino per timore di essere ammazzati anche loro. Solo dopo - nel corso di interrogatori più approfonditi e alla luce dei riscontri oggettivi - hanno iniziato a dettagliare elementi diversi. È in questo snodo che gli inquirenti collocano il cambio di passo investigativo, frutto di un lavoro definito dagli stessi vertici «rigoroso e senza sconti», portato avanti dalla Procura e dalla Squadra mobile della questura di Milano.
A pesare, secondo gli atti, sarebbero state anche le pressioni attribuite all’assistente capo: Cinturrino avrebbe sollecitato i colleghi a mantenere la versione della legittima difesa. Dai verbali emerge una figura temuta, capace di incutere soggezione. «Avevo paura che potesse spararmi», ha riferito l’agente Davide Picciotto, una percezione confermata da altri testimoni che descrivono comportamenti abitualmente aggressivi, tanto da usare talvolta il martello anche contro i tossicodipendenti.
Il fermo e la richiesta di custodia cautelare si fondano sull’accusa di omicidio volontario: per la Procura, Cinturrino avrebbe sparato consapevolmente a Mansouri senza una minaccia concreta, mentre cercava di fuggire, aggravando la propria posizione alterando la scena e costruendo una versione difensiva non veritiera.
Il quadro cambia radicalmente con il secondo interrogatorio di Picciotto, reso il 19 febbraio. È qui che, secondo gli inquirenti, emergono riscontri decisivi. Picciotto - che al momento dello sparo si trovava alla destra di Cinturrino, due o tre metri più indietro - colloca l’azione a una distanza di circa 20 metri dalla vittima. Racconta di aver visto Mansouri fare un gesto con il braccio destro, «sopra la spalla», come se stesse per lanciare qualcosa. Un gesto che viene collegato alla pietra rinvenuta accanto alla mano del giovane e visibile nelle immagini acquisite.
Ma Picciotto è altrettanto esplicito su un punto centrale: non ha mai avuto timore di essere colpito. Lo dice chiaramente agli inquirenti. La minaccia, secondo il suo racconto, non era concreta né immediata. E soprattutto aggiunge un elemento dirimente: prima dello sparo nessuno ha intimato l’alt, né si è qualificato come polizia.
Dopo il colpo, Mansouri cade prono, con il volto a terra. Le lesioni al viso, l’imbrattamento di terriccio, la posizione del corpo e la traiettoria del proiettile - che entra nella regione parietale destra e si arresta nella zona occipitale - trovano riscontro negli accertamenti medico-legali e balistici dell’università di Milano e della polizia scientifica. È una caduta compatibile con un colpo esploso di lato, mentre la testa era leggermente ruotata, non con un fronteggiamento diretto.
È a questo punto che si innesta la parte più inquietante del racconto. Picciotto riferisce che Cinturrino gli consegna le chiavi della Panda di servizio e gli ordina di andare al commissariato Mecenate a prendere la valigetta degli atti, quella abitualmente utilizzata dai capo pattuglia delle volanti. Non quella di servizio - presente sul posto con la volante Mecenate bis - ma una borsa nera personale, con lo stemma dell’Italia, appartenente allo stesso Cinturrino. Le telecamere documentano l’andata e il ritorno: Picciotto si allontana alle 17.33, rientra al bosco alle 17.48. Quando torna, vede Cinturrino aprire il cofano, prelevare un oggetto nero e correre verso il corpo. Solo dopo, vicino alla mano di Mansouri, compare la pistola a salve.
Il ritardo nei soccorsi - 22-23 minuti - chiude il cerchio. Mansouri non muore sul colpo: dà segni di vita. Eppure il 118 viene chiamato solo alle 17.55. Secondo la Procura, Cinturrino tranquillizza i colleghi, dicendo di aver già avvisato la centrale. Non è vero. Quel lasso di tempo, scrivono i pm, viene utilizzato per modificare la scena.
Sul piano politico il caso riaccende lo scontro sullo scudo penale. Elly Schlein, leader dem, ha accusato Giorgia Meloni e Matteo Salvini di aver strumentalizzato il caso, definendo grave l’uso politico di una vicenda giudiziaria ancora in corso per il referendum. Ha chiesto scuse per i giudici e di rivedere la norma del decreto Sicurezza che introdurrebbe una forma di impunità preventiva. Di segno opposto Salvini, che ribadisce: «Lo scudo non è impunità: se ci sono evidenze di crimine si indaga e si arresta». Il premier Meloni ha avvertito che, se le ipotesi fossero confermate, si tratterebbe di un fatto «gravissimo». Ha espresso «profonda rabbia» all’idea che chi tradisce la divisa possa «sporcare» il lavoro di chi ogni giorno tutela la sicurezza, ringraziando la polizia di Stato per le indagini interne svolte «al solo fine di far emergere la verità». Il presidente del Consiglio ha poi ribadito che «non esiste alcuno scudo penale» e che la giustizia farà il suo corso.
Tra gli alberi c’era chi ha visto tutto
È stata una sequenza di errori a portare Carmelo Cinturrino al centro dell’accusa di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri. Errori che hanno incrinato la versione della legittima difesa e hanno finito per reggere l’impianto accusatorio della Procura di Milano.
Il primo riguarda la pistola. L’arma indicata da Cinturrino come la minaccia che lo avrebbe costretto a sparare non si è rivelata solo una replica a salve. Ma soprattutto, dagli accertamenti della Scientifica, è emerso che su quell’oggetto non erano presenti tracce genetiche della vittima, mentre sono state rinvenute più tracce biologiche dello stesso Cinturrino: sulla guanciola, sul grilletto, sul cane e sull’impugnatura. Un dato che ha smentito l’ipotesi che Mansouri l’avesse mai impugnata e ha rafforzato il sospetto che la pistola fosse stata maneggiata e collocata dopo, per costruire una scena compatibile con la legittima difesa. Il secondo errore ha riguardato i tempi dei soccorsi. Un ritardo che, per l’accusa, non è stato casuale ma funzionale ad alterare la scena. Il terzo è stato non accorgersi dei testimoni. Nel bosco di Rogoredo, quella sera, non c’erano solo poliziotti. Alcuni frequentatori dell’area hanno assistito alle fasi dell’intervento e dello sparo, nascosti nella boscaglia. Tra loro Muhammadi Quadrat Ullah, che ha raccontato di aver visto Mansouri disarmato, con un telefono in una mano e una pietra nell’altra, colpito mentre stava cercando di fuggire. La sua versione è stata ritenuta attendibile anche perché verificata sul posto, in condizioni di luce simili a quelle del pomeriggio del 26 gennaio e perché supportata da riscontri oggettivi: la presenza della pietra accanto alla mano della vittima, il fango sul volto, la posizione prona del corpo.
Tra i riscontri che hanno pesato di più nell’impianto accusatorio c’è il racconto di Mohui Rachid, uno dei frequentatori del boschetto che, secondo gli inquirenti, ha finito per incastrare proprio chi per anni avrebbe incusso timore in quell’area. Rachid ha riferito di essere stato in chiamata Whatsapp con Mansouri negli istanti immediatamente precedenti allo sparo. Una conversazione in tempo reale, durante la quale lo avrebbe avvertito della presenza della polizia invitandolo a scappare. La chiamata, ha raccontato, si è interrotta bruscamente dopo un rumore secco, riconducibile a un colpo d’arma da fuoco. Subito dopo ha tentato di richiamarlo, senza ottenere risposta. Un racconto che ha trovato puntuale riscontro tecnico: l’analisi del cellulare di Mansouri ha confermato una chiamata Whatsapp alle 17.32, collocata a ridosso dell’orario stimato dello sparo. Rachid aveva anche consegnato agli investigatori uno screenshot del registro chiamate, poi verificato dalla Squadra mobile. Un dettaglio ritenuto decisivo perché colloca Mansouri in una situazione incompatibile con la versione della minaccia armata imminente: stava parlando al telefono, non impugnava una pistola. Per la Procura, la testimonianza di Rachid è fondamentale: è uno dei frequentatori del boschetto che, secondo le carte, avrebbero subito per anni intimidazioni da parte di Cinturrino.
Infine, il quarto errore è stato aver confidato in un’impunità costruita nel tempo. Dagli atti emerge un quadro «allarmante»: intimidazioni, violenze e richieste di denaro ai tossici, riferite da più soggetti sentiti dagli investigatori. Intanto Dario Redaelli ha rinunciato all’incarico di consulente della difesa di Cinturrino, affermando di non poter difendere chi ha «preso in giro» lui e l’istituzione a cui ha appartenuto per 40 anni. E ha espresso solidarietà ai poliziotti che ogni giorno onorano la divisa.
Continua a leggereRiduci
Nel riquadro, il Pm Massimo Russo (Imagoeconomica)
Massimo Russo, Pm presso la Procura per i minorenni di Palermo
La mia posizione su questa riforma nasce da una riflessione lunga e anche molto travagliata, che mi ha costretto a fare i conti con la mia storia professionale. Sono entrato in magistratura nel dicembre del 1987. Nei corridoi del Palazzo di giustizia di Palermo incontrai Giovanni Falcone che con altri colleghi poco tempo prima aveva dato vita al Movimento per la giustizia. Alle elezioni del 1990 per il Consiglio superiore della magistratura fui tra i pochi - pochissimi - a votarlo. Fu un insuccesso, ma quell’esperienza segnò profondamente il mio modo di intendere il ruolo del magistrato. Da allora ho continuato l’impegno associativo, riconoscendomi nei valori di quella stagione.
Negli anni ho svolto funzioni diverse: prima giudice, poi pubblico ministero a Marsala e a Palermo, lavorando anche nella Direzione distrettuale antimafia, in prima linea nel contrasto a Cosa nostra nella provincia di Trapani. Ho poi lasciato la toga per una parentesi di impegno politico-amministrativo alla Regione siciliana e sono tornato in magistratura come magistrato di sorveglianza a Napoli. Oggi svolgo le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura per i minorenni di Palermo.
Nei primi anni Duemila sono stato eletto presidente dell’Associazione nazionale magistrati del distretto di Palermo e successivamente ho continuato l’impegno associativo nel Movimento per la giustizia.
Spiegare pubblicamente perché sostengo questa riforma non è stato facile. Per certi versi potrebbe sembrare quasi una smentita del mio passato. In realtà è proprio da quella storia che nasce questa convinzione.
Come magistrato che ha sempre avuto una cultura e una sensibilità progressista, attenta ai diritti e alle garanzie, non posso non ricordare come l’idea di intervenire sull’assetto dell’ordinamento giudiziario non nasce oggi né appartiene a una sola parte politica.
Per anni si è discusso della necessità di superare, dando corso a quanto auspicato dal Costituente con la VII disposizione transitoria della Costituzione, alcuni tratti dell’impianto ordinamentale ereditato dallo Stato fascista, e non pochi esponenti del centrosinistra hanno sostenuto, in diverse stagioni politiche, l’esigenza di rafforzare la distinzione tra accusa e giudice, di intervenire sulle dinamiche dell’autogoverno e di prevedere un Alta Corte disciplinare per i magistrati.
È uno dei paradossi della storia istituzionale italiana che una riforma a lungo invocata da culture politiche riformiste venga oggi portata a compimento da un governo di centrodestra. Ma proprio questo dimostra che la questione non è ideologica: riguarda l’assetto dello Stato e il funzionamento della giurisdizione. Le istituzioni, infatti, non appartengono a una parte. E quando una riforma attraversa culture politiche diverse significa che tocca un nodo reale del sistema.
In tanti anni di magistratura ho imparato una cosa semplice: quando si parla di giustizia il punto di vista decisivo non è quello del magistrato, ma quello dei cittadini. Sono loro che la cercano, che la invocano, che ne hanno bisogno.
La giurisdizione è un bene comune. Non appartiene ai magistrati, non appartiene alla politica. I magistrati ne sono i custodi, gli officianti istituzionali. Ma la legittimazione della giustizia non nasce soltanto dalla norma: nasce dalla fiducia.
È evidente che la fiducia richiede anche una giustizia efficiente, capace di decidere in tempi ragionevoli e sostenuta da riforme organizzative adeguate. Ma il referendum costituzionale riguarda un altro livello: non l’efficienza quotidiana del sistema, bensì la sua architettura istituzionale. È partendo da questo punto di vista che bisogna interrogarsi sullo stato della giustizia nel nostro Paese.
Un dato è difficilmente contestabile: la fiducia dei cittadini si è progressivamente indebolita. La magistratura è sempre più spesso percepita come distante, come un centro di potere autoreferenziale. E mi preoccupa vedere oggi la magistratura organizzata scendere direttamente nel confronto pubblico per chiedere consenso, quasi fosse una parte politica, come se stesse difendendo qualcosa che appartiene a sé stessa e non alla comunità.
È bene ricordare che, in una democrazia rappresentativa, la sovranità appartiene ai cittadini che la esercitano attraverso il Parlamento, al quale spetta fare le leggi. Il giudice, per dettato costituzionale, è soggetto soltanto alla legge: non difende un proprio spazio di potere, ma applica con imparzialità le norme che l’ordinamento democratico si è dato.
Nelle ultime settimane il dibattito pubblico è scivolato verso toni apocalittici: si è parlato di assalto alla Costituzione, di rischio per la democrazia, di sovvertimento dell’equilibrio dei poteri. Quando il linguaggio si fa così estremo, spesso è il segnale che il confronto si è allontanato dal merito. A ben vedere, il filo conduttore della riforma è chiaro e comprensibile: rafforzare la terzietà del sistema giudiziario. Terzietà nel processo, attraverso una distinzione più netta e strutturale tra chi esercita l’azione penale e chi è chiamato a giudicare. Terzietà nell’autogoverno, con due distinti Consigli superiori e meccanismi pensati per ridurre il peso delle logiche correntizie. Terzietà nel sistema disciplinare, affidato a un giudice realmente indipendente.
Tre pilastri, un unico principio: la terzietà.
Non si tratta di indebolire la magistratura. Al contrario, si tratta di rafforzarne l’autorevolezza, restituendo alla giurisdizione ciò che più conta: la fiducia dei cittadini.
Ogni persona che entra in un’aula giudiziaria forma il proprio giudizio non sui principi astratti, ma sull’esperienza concreta: sulla capacità di ascolto, sull’equilibrio, sulla percezione di libertà del giudice.
Sapere, per esempio, che chi accusa e chi giudica appartengono a ruoli realmente distinti rende il cittadino più sereno. Sapere che il giudice non appartiene allo stesso circuito dell’accusa rafforza la fiducia nel processo.
La terzietà, infatti, non è solo una condizione giuridica: è anche una percezione. E quando questa percezione è chiara, aumenta non solo la tranquillità del cittadino, ma soprattutto l’autorevolezza della decisione finale. Perché una decisione appare più giusta quando chi la riceve è convinto che sia stata presa da un giudice realmente terzo e indipendente.
La riforma, del resto, non tocca i pilastri costituzionali del nostro ordinamento: restano l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, l’inamovibilità del magistrato, la sua soggezione soltanto alla legge, l’obbligatorietà dell’azione penale e la disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria. Sono i principi voluti dai padri costituenti a presidio della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Contrariamente a quanto falsamente si sostiene, il pubblico ministero non diventa subordinato al potere politico; al contrario, riceve, per la prima volta, una tutela costituzionale esplicita. Ciò che cambia è l’architettura del sistema: una più netta distinzione dei ruoli, maggiore trasparenza nell’autogoverno, un controllo disciplinare più chiaramente terzo.
Ecco perché votare Sì è, a mio avviso, la scelta giusta. Non perché si tratta di una riforma perfetta, ma perché prova a rafforzare ciò che oggi conta di più: l’autorevolezza della giustizia.
Il cambiamento non nasce contro la Costituzione, ma dentro il suo perimetro. I principi fondamentali restano intatti; ciò che cambia è l’assetto attraverso cui la giurisdizione esercita la propria funzione. In una democrazia matura le istituzioni non si difendono erigendo barriere contro ogni cambiamento. Si difendono trovando la forza di rinnovarle dentro le regole della Costituzione e attraverso la volontà degli elettori. A questo serve il referendum del 22 e 23 marzo: restituire la parola ai cittadini. Perché a loro appartiene la giurisdizione. Ed è alla loro fiducia che ogni riforma della giustizia, in fondo, deve rispondere.
Continua a leggereRiduci