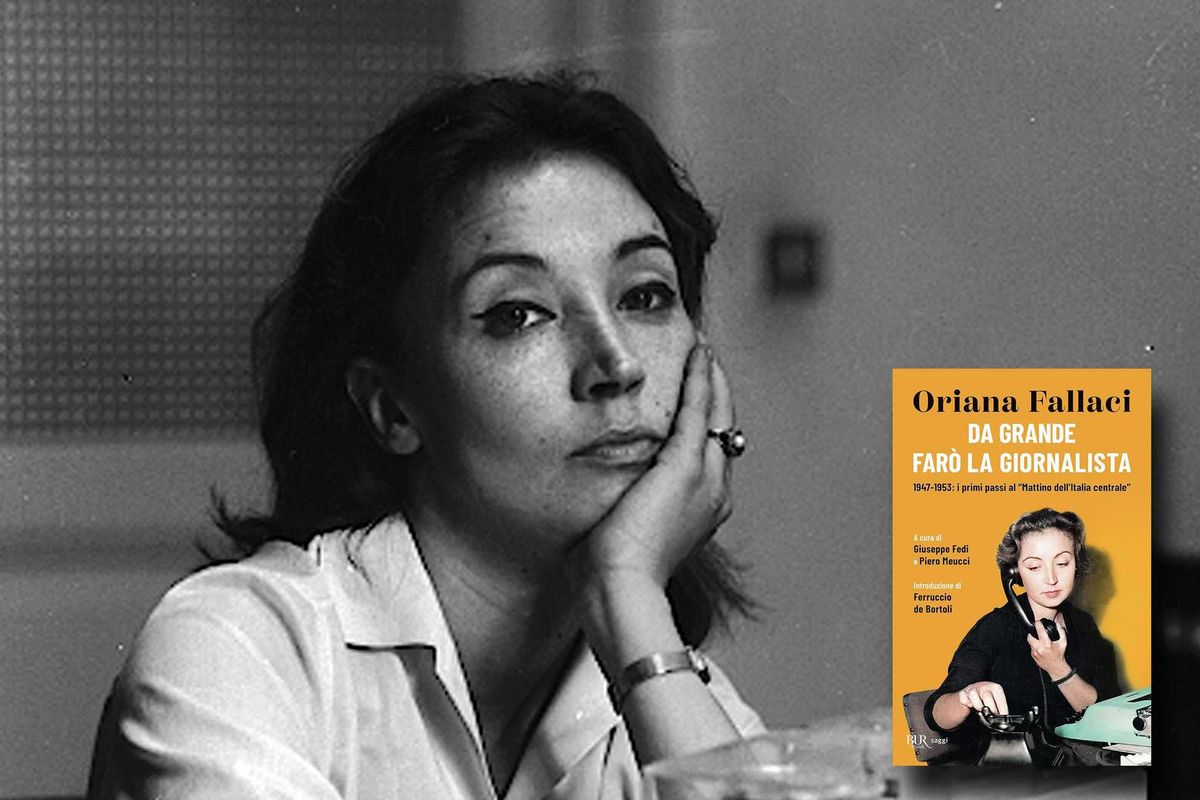L'interesse per il calcio, la necessità di seguire le partite, di vederle, o, comunque, di sapere come erano andate a finire, è cominciato, per me, quando avevo 6 anni, e continua ancora adesso che ne ho 55 ma non è stato costante, nel tempo. Ci son stati degli anni che mi sembrava così interessante, la vita che facevo, che era come se per il calcio non avessi tempo.
È stato negli anni dal 1985 al 2003, più meno, che sono gli anni del mio apprendistato, se così si può dire: nel 1985, a 22 anni, sono andato a lavorare in Algeria, sulle montagne del piccolo Atlante, e lì, come in tutti i Paesi musulmani, il giorno di festa non era la domenica, era il venerdì, e io la domenica avevo altro per la testa che i risultati delle partite di calcio del campionato italiano: bisognava lavorare, era il primo lavoro da grande che facevo nella mia vita, ed ero molto interessato a capire se ero capace di farlo oppure no, e avevo molta paura che no, non sarei stato capace, ed era una paura che mi teneva sveglio e mi faceva star bene.
Due anni e mezzo dopo, nel 1988, ho dato le dimissioni e mi sono iscritto all'università, ho cominciato a studiare lingua e letteratura russa, e continuo ancora adesso, e quei primi anni l'interesse per la lingua e la letteratura russa è stato così esclusivo che anche lì non c'era posto, per dei rivali. Mi ricordo, per esempio, i Mondiali di calcio del 1990, quelli in Italia, io intanto che l'Italia giocava le partite del girone eliminatorio, che faceva dei gran gol Salvatore Schillaci, io di quei gol non ne ho visto neanche uno perché ero al festival del nuovo cinema di Pesaro a vedere dei film la maggior parte dei quali erano muti e sovietici, e, a distanza di quasi 30 anni, credo di aver fatto bene perché sono dei film meravigliosi, primo tra tutti il tanto vituperato La Corazzata Potëmkin, di Sergej Ejsenstejn, che molti, in Italia, a causa del ragionier Ugo Fantozzi, pensano sia un film noiosissimo che dura ore e ore e invece è un film meraviglioso che dura, a misurarli, 64 minuti.
Poi, dopo che mi sono laureato, che ho cominciato a scrivere e che mi sono trasferito a Bologna e che è nata anche mia figlia, dopo che son diventato uno degli innumerevoli padri di famiglia che popolano il globo terracqueo, a un certo momento è stato come se avessi pensato che, dopotutto, a più di 40 anni, ero diventato quasi una persona normale, e una persona normale non doveva per forza sempre occuparsi di cose importanti o importantissime, poteva permettersi anche, ogni tanto, di guardare una partita di calcio, o quasi; perché all'epoca, a Bologna, io non avevo la televisione, quindi le partite di calcio non le guardavo, le sentivo per radio, e la partita di cui voglio parlare oggi è una partita del maggio del 2005 che era un periodo che a casa mia, nel centro di Bologna, avevo ospiti una coppia di amici russi a cui ero molto affezionato ma che erano un po' impegnativi, da ospitare in casa.
Loro, per esempio, che avevano vissuto tutta la vita in una città che si è chiamata con tre nomi diversi, San Pietroburgo, Pietrogrado, Leningrado e ancora San Pietroburgo, e avevano conosciuto, in quella città, molti di quelli che si erano occupati di letteratura, e con alcuni di questi non avevano un rapporto molto amichevole, e di uno di questi, in particolare, uno scrittore russo che si chiama Sergej Dovlatov dicevano che era, cito: «Una merda», loro, quando ho saputo che sarebbero venuti ospiti in casa mia, io, che avevo all'epoca una ventina di libri di e su Sergej Dovlatov, che è uno scrittore che mi piaceva e mi piace ancora moltissimo, io mi ricordo che avevo pensato che non potevo far loro lo sgarbo di fargli trovare nella stanza dove dormivano dei libri di Sergej Dovlatov che loro consideravano, cito ancora: «Una merda», e avevo trovato un nascondiglio temporaneo per quella ventina di libri che ancora oggi ho qui davanti a me nella mia libreria.
Ma cosa c'entra il calcio?, direte forse voi.
Ci arrivo.
Il caso ha voluto che i miei due amici russi fossero ancora ospiti a casa mia il 25 maggio del 2005, che è il giorno in cui c'è stata la finale della Champions league tra Milan e Liverpool. Io, da giovane, prima di ridurmi come adesso, a tener solo per il Parma, tenevo anche per il Milan, e quel 25 maggio del 2005, se non avessi avuto a casa mia quei due letterati russi, probabilmente sarei andato a casa di un mio amico italiano non letterato a vedere la partita con la sua televisione, ma allora, sentendomi responsabile del soggiorno bolognese dei miei cari amici russi, ero rimasto a casa con loro, e, durante una cena e un dopocena nel corso dei quali amabilmente conversavamo di cinema e letteratura russi e sovietici, io, a basso volume, avevo tenuto accesa la radio che dava la radiocronaca della finale di Champions league, che era cominciata benissimo, per noi che, un po', tenevamo per il Milan: al primo minuto del primo tempo aveva segnato Paolo Maldini, al 38' del primo tempo aveva raddoppiato Hernán Jorge Crespo, al 44' del primo tempo aveva triplicato Crespo. Tre a zero. Con due gol di Crespo che aveva giocato anche nel Parma. Io stavo benissimo. Mi sentivo un po' Fantozzi, a sentir la partita senza farmi accorgermene, ma stavo benissimo lo stesso. Poi è cominciato il secondo tempo. Steven Gerrard, Vladimir Smicer, Xabi Alonso. Tre a tre. Tre gol in sei minuti. E poi niente. Fino alla fine. Supplementari. E niente neanche nei supplementari. Rigori. Ecco.
Sentire perdere il Milan ai rigori la finale di Coppa dei campioni, dopo essere stato in vantaggio 3 a 0, e facendo finta di continuare a essere di ottimo umore, a distanza di 13 anni lo posso confessare, non è stato bello, e credo di poter confessare anche un'altra cosa, che io, i gol di quella partita lì, quello di Maldini, i due di Crespo, quello di Gerrard, di Smicer e di Alonso e i nove rigori che hanno tirato alla fine, tre gol e un errore del Liverpool, due gol e tre errori del Milan, io non li ho mai visti e credo che non li vedrò mai in vita mia.
Anche per scrivere questa serie sulle dieci partite più interessanti tra tutte quelle che ho visto (o sentito) nella mia vita, io di solito, per le partite delle quali ho parlato finora, andavo a rivedere le fasi salienti, come si dice, su Youtube, per questa, no, non so come mai. Ho tanti di quei libri da leggere, in questo periodo. Sarà forse per quello. Ho un sacco di cose da fare. Sono così impegnato.
(6. Continua)