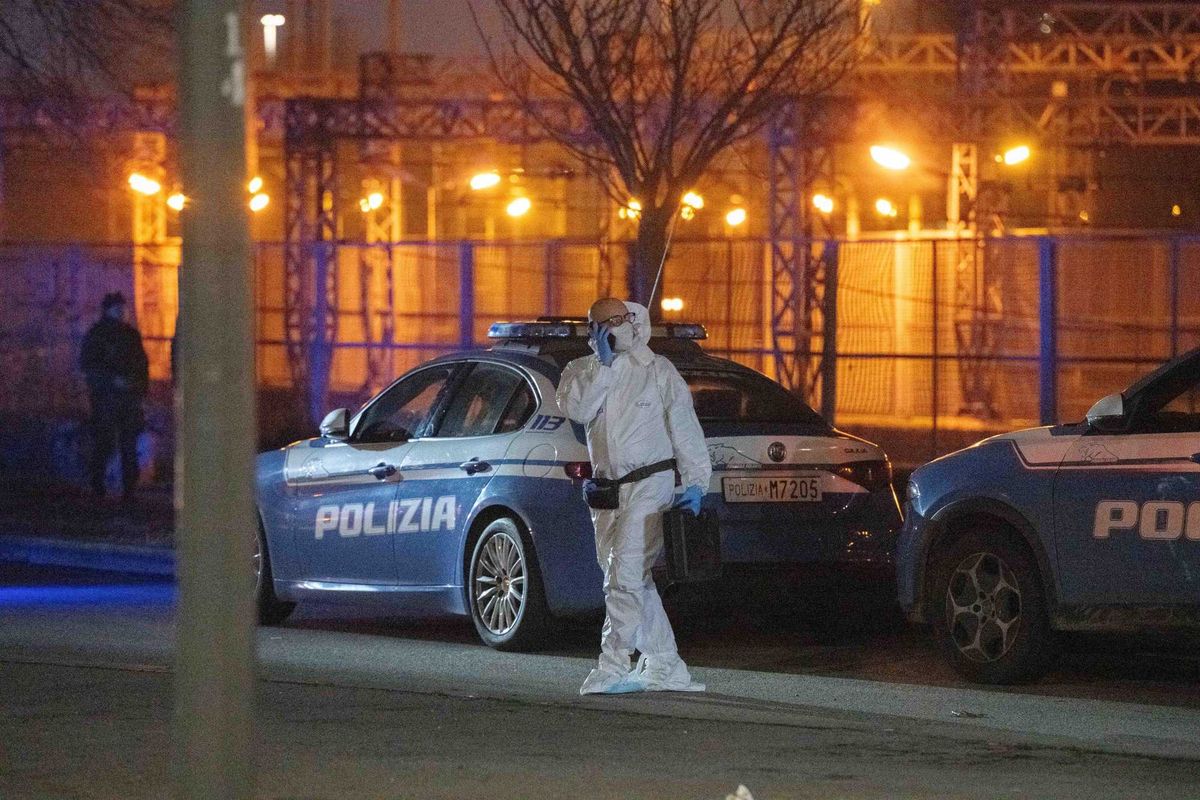Kallas e Zelensky gufano su Budapest. I bulgari: «Putin voli sui nostri cieli»

«I prezzi dell’energia in Europa sono significativamente più alti che negli Stati Uniti e in Cina. Sebbene quelli del gas siano oggi più di dieci volte inferiori rispetto al picco della crisi energetica, sono ancora circa il doppio rispetto a prima della crisi». La diagnosi arriva da Ursula von der Leyen, cioè da colei che la malattia l’ha provocata, spingendo per fermare le importazioni di metano russo. Alle quali l’Ue dirà definitivamente addio entro il 2028: da gennaio prossimo sarà vietato firmare nuovi contratti, il 17 giugno 2026 dovranno terminare quelli in corso e il 31 dicembre 2027 dovranno esaurirsi quelli a lungo termine. La presidente della Commissione crede di sopperire con «una nuova capacità di esportazione di Gnl, il che dovrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi». E poi se la prende con gli oneri di sistema. Per ora, le imprese lavorano con una zavorra e le famiglie si svenano. Gli unici a opporsi, invano, all’harakiri del Vecchio continente, sono i premier di Ungheria e Slovacchia, Viktor Orbán e Robert Fico. Temono di rimanere al gelo, benché la Polonia prometta di aiutarli.
Chi già fa la doccia fredda è Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Unione. Un getto glaciale le è arrivato proprio da Varsavia: mentre lei mugugnava sul vertice a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin («Non è bello che una persona sottoposta a un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale si rechi in un Paese membro dell’Ue»), il viceministro degli Esteri polacco le faceva notare che «è difficile immaginare» la cattura dello zar, atteso dai magiari «su invito del presidente degli Stati Uniti». La Bulgaria, peraltro, si è offerta di garantire un corridoio aereo a Putin.
Bruxelles potrebbe guardare in faccia la realtà: sono gli Usa ad avere in mano il pallino della guerra e della pace. La Kallas recita la sua parte, certo. Ma quando afferma che «da questi incontri non può venire fuori nulla se l’Ucraina o l’Europa non ne fanno parte» e che a spingere Putin a un accordo sarà il diciannovesimo pacchetto di sanzioni, viene da domandarsi se le sia toccato un ruolo tragico o comico.
Tanto più che le ambizioni della funzionaria estone finiscono in frigo anche per ciò che riguarda l’utilizzo degli asset russi. «C’è un ampio sostegno», ha giurato ieri pomeriggio, dopo essersi presentata al Consiglio Esteri a Lussemburgo ammettendo che «i Paesi membri non hanno ancora raggiunto un accordo su un nuovo prestito all’Ucraina garantito da beni russi congelati». Non è una questione secondaria. Volodymyr Zelensky, deluso da Trump sui Tomahawk, ha ripresentato la lista della spesa all’Europa: 25 sistemi Patriot per la difesa aerea. Dato che Washington non regalerà più nulla, il presidente ucraino ha chiesto di pagarli o impegnando gli asset della Federazione, o in virtù dei patti bilaterali stretti con gli alleati, Italia inclusa. Chissà come andrà a finire...
Sul controverso progetto che riguarda le risorse sequestrate pesano le obiezioni del Belgio, particolarmente esposto, poiché i 170 miliardi in gioco sono custoditi da Euroclear, società con sede a Bruxelles. Ai timori di perdere una «gallina dalle uova d’oro», come ha chiamato gli interessi sui depositi il premier Bart De Wever, si sono aggiunte le minacce dell’ambasciatore russo a Roma per l’eventuale «complicità dell’Italia in un reato finanziario», che comprometterebbe «in modo sostanziale» il ripristino postbellico delle relazioni.
Ma intanto, al dopoguerra bisogna arrivarci. Secondo il Cremlino, disposto a congelare l’attuale linea del fronte, l’incontro di Budapest potrà aiutare a «compiere progressi», anche se «non è stato ancora avviato il lavoro di squadra necessario per creare le condizioni adeguate a negoziati su larga scala» e «i preparativi per il vertice non sono ancora veramente iniziati». È un gioco di nervi: la fretta di The Donald, la logorante flemma di Mad Vlad. Berlino ha auspicato che, al summit dei capi di governo di giovedì e venerdì, si concordi su un «chiaro segnale di sostegno» a Kiev e si prenda una «decisione politica» sugli asset congelati.
Kallas bofonchia; Emmanuel Macron pretende che a Budapest siano ammessi ucraini ed europei; idem i baltici; nel frattempo, le diplomazie si muovono. Oggi, il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, sarà nella capitale Usa. Giovedì, è possibile si vedano Sergej Lavrov e Marco Rubio, che ieri ha sentito al telefono il russo, per un confronto sulla «collaborazione» tra Mosca e Washington in vista del bilaterale tra presidenti. Zelensky è scettico. «Non credo che un primo ministro che blocca l’Ucraina ovunque possa fare qualcosa di positivo per gli ucraini, o almeno qualcosa di equilibrato», ha commentato, riferendosi ai veti di Orbán sull’ingresso di Kiev nell’Unione. La verità è che, per lui, la fine delle ostilità è un’incognita. Dovrà rendere conto degli errori; sottostare al bilancio di una sconfitta almeno parziale; quasi di sicuro, giustificare lo smembramento della nazione, dal quale non potranno salvarlo i proclami della Kallas sulla necessità di preservarne «l’integrità territoriale». Ecco perché il comandante in capo si aggrappa al prossimo vertice dei redivivi volenterosi, a Londra, fra tre giorni, e propone di allungare di tre mesi la legge marziale.
Trump non scommette sull’Ucraina («Potrebbe ancora vincere, ma dubito ci riuscirà»), eppure resta fiducioso sull’armistizio: «Penso ci arriveremo», ha detto ieri, confermando di aver domandato a Putin di interrompere i raid sui civili. «Se non faremo un accordo, un sacco di persone pagheranno un grande prezzo». Al «nuovo Churchill», forse, costerebbe di più la pace.