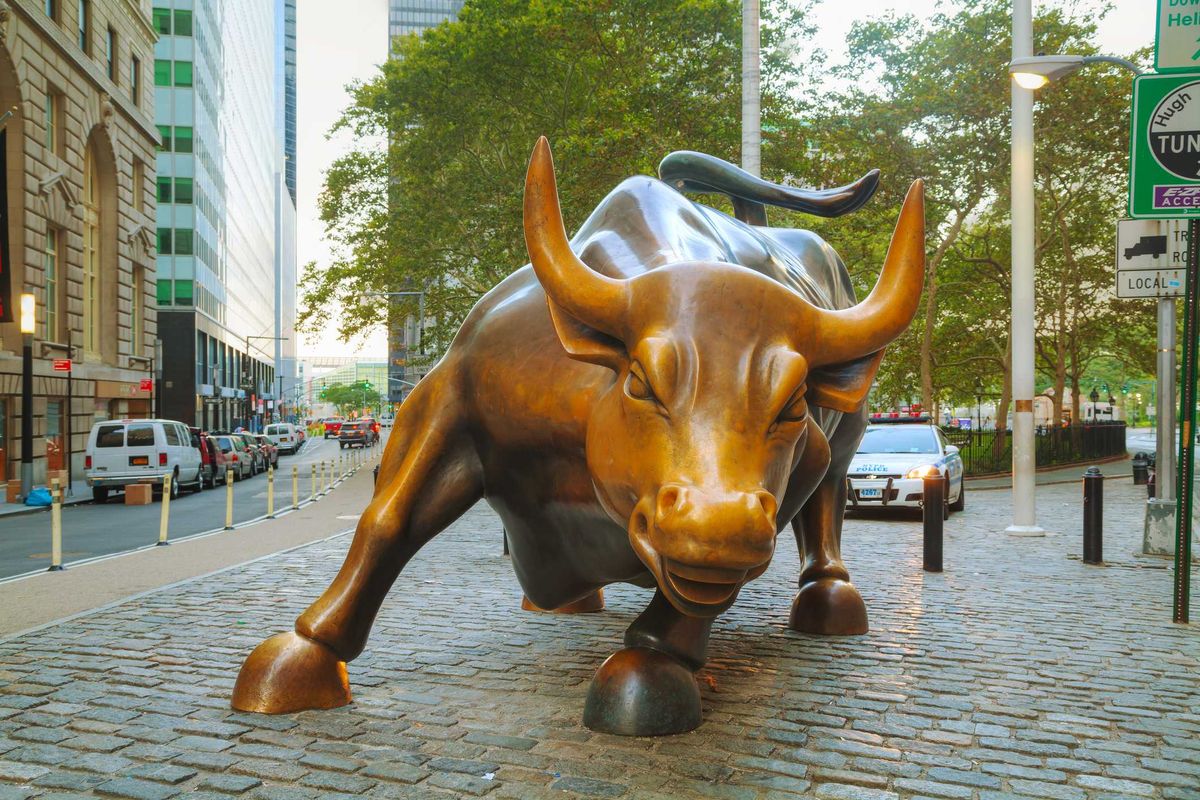2021-12-06
Italia: pizza, mandolino e pasta (all’uovo però)
Diffidate delle varianti esotiche nemiche delle tradizioni. E basta criminalizzare i carboidrati Per «fare pasto» buono e nutriente non c’è niente come la regina delle specialità tricoloreL’ideatore della boutique bolognese di Eataly Daniele Capozzi: «Fu Bonilli, papà del “Gambero rosso”, a darmi questo compito. Così sono diventato un talebano del prodotto artigianale»Lo speciale contiene due articoliEsiste qualcosa di più buono e identitario della pasta per un italiano? E anche per chi, non italiano, adori la pasta? Sì, esiste: la pasta all’uovo. Però è una risposta affermativa col trucco, perché la pasta all’uovo è un tipo di pasta, quindi il primato di bontà della pasta resta insuperato da qualcosa che pasta non sia. I tipi di pasta sono tanti: fresca e secca, di sole acqua e farina di grano tenero o semola di grano duro (che è quella alla quale ci si riferisce con la denominazione «pasta»), all’uovo, ripiena. Si dice sempre che la pasta di semola di grano duro sia tipica del Sud e la pasta all’uovo e farina di grano tenero lo sia del Nord Italia. Come spiega bene anche Paste fresche e gnocchi (Giunti e Slow Food editori), il Sud come «patria del grano duro e quindi delle paste di sola semola e acqua» e il Nord «imperniato sul binomio farina e uova» sono più stereotipi che immutabili fotografie. È vero che tante farine di frumento tenero meridionali sono poco proteiche e ciò, nel tempo, ha radicato l’uso del grano duro - più proteico - in alternativa all’uovo come agente proteinizzante dell’impasto. Ma è anche vero che la semola è sempre stata nota nei luoghi di accesso al Nord come le città portuali, l’uso dell’uovo è sempre stato collegato alla sua disponibilità e si afferma sempre più il binomio uovo+farina e semola al posto del solo uovo+farina. A parte queste piccole evoluzioni o varianti spontanee, ci sono quelle macroscopiche e imposte. Nella grande risciacquatura in Arno transumanista che oggi tocca a tutto, non solo al cibo, sono arrivate sugli scaffali dei supermercati le paste modificate iperproteiche. Ci sono quelle aggiunte di proteine, quelle preparate con aggiunta di farine di legumi, sul modello di quella tradizionale cinese di soia, quelle che non contengono affatto farina come la pasta di konjac, gli shirataki noodles nipponici composti di acqua e fibra (il glucomannano): oltre al desiderio di manipolare la tradizione fino a cancellarla, queste paste soddisfano l’imperativo dietetico che criminalizza i carboidrati. Ma la versione più proteica e più ricca di fibre della pasta esiste già ed è quella all’uovo. La consuetudine vuole che la pasta sia la regola ordinaria e la pasta all’uovo sia l’eccezione festaiola, fatte salve regioni dove la pasta all’uovo è un’istituzione, in primo luogo l’Emilia Romagna. Di norma, la pasta all’uovo si prepara con 100 grammi di farina di grano tenero e 1 uovo. Sempre più spesso, tuttavia, ci si trova di fronte a ricette che prevedono 50 grammi di semola di grano duro e 50 grammi di farina di grano tenero. L’apporto calorico della pasta secca è di 353 calorie ogni 100 grammi. Essa contiene per il 74% carboidrati, proteine dal 7 al 10% in funzione del tipo di farina usata (la farina integrale, la semola di grano duro e il grano tenero manitoba, per esempio, hanno più proteine delle altre farine), 1,4% di grassi. La pasta all’uovo fresca, invece, ha 366 calorie e presenta la stessa quota di carboidrati, ma più proteine (13%), più acidi grassi (2,4% di cui 73 milligrammi di colesterolo su 100 grammi) e più fibre, il 3,2% contro il 2,7% della pasta secca. Aumentano ancora proteine e grassi nella pasta che oltre che all’uovo è ripiena, come per esempio i tortellini, che anche per questo possono perfettamente svolgere il ruolo di pasto completo, affiancati a una porzione di verdura. Questa possibilità di «fare pasto» appartiene anche alla pasta all'uovo non ripiena, mentre nel caso della pasta manca l’elemento proteico animale e da sola non si può considerare pasto esaustivo. La pasta fresca contiene il 30% di acqua in più rispetto a quella secca, quindi la classica porzione da 80 grammi di pasta secca va aumentata a 120 grammi se fresca all’uovo: in cottura quest’ultima, già idratata, assorbirà meno acqua rispetto alla pasta secca, rendendo come quella secca. Rispetto all’impasto di acqua e semola o farina oppure entrambe, l’impasto che sostituisce l’acqua con l’uovo sfrutta le caratteristiche nutrizionali e fisiche proprie del prodotto della gallina. Nella pasta, l’impasto di semola (o farina) e acqua fa sì che le glutenine e le gliadine, le proteine non solubili dello sfarinato, creino il glutine, che imprigiona acqua e amido. La farina di grano tenero ha meno glutine e quindi, in fase di modellaggio e cottura, la pasta sarà meno plastica e resistente, non a caso la pasta di grano tenero intorbidisce l’acqua di cottura perdendo amido e si usa molto nei formati per minestra, piatto nel quale la consistenza meno tenace non è un problema. Impastando con acqua calda invece che fredda la struttura glutinica della pasta migliora sensibilmente perché l’acqua riscaldata gelifica l’amido. Infatti nelle ricette del Sud di formati di pasta da mangiare asciutti vi capiterà spesso di trovare l’indicazione di usare l’acqua calda, suggerimento che non troverete per paste da mangiare in brodo. L’impasto, poi, migliora ancora di più con semola di grano duro, ma mai come quando alla farina o alla semola si aggiungono le uova e non l’acqua. Insomma, se cercate una pasta gradevole al gusto e performante in termini di proteine e fibre, provate più spesso - magari impastandola con le vostre mani - la pasta all’uovo.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/italia-pizza-mandolino-e-pasta-alluovo-pero-2655923435.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="ho-una-missione-nella-vita-portare-il-miglior-tortellino-a-quanta-piu-gente-possibile" data-post-id="2655923435" data-published-at="1638719868" data-use-pagination="False"> «Ho una missione nella vita: portare il miglior tortellino a quanta più gente possibile» Abbiamo intervistato Daniele Capozzi, ideatore e responsabile di Pasta zalla, la «mini boutique dell’autentico tortellino di Bologna» (e delle altre paste emiliano-romagnole, dai passatelli ai garganelli) presso Eataly di Oscar Farinetti. La parola «zalla» in bolognese vuol dire «gialla», come la tipica colorazione della pasta all’uovo. «Selezioniamo i migliori tortellini artigianali bolognesi e li portiamo ovunque agli appassionati», recita il sito zalla.it dedicato al «turtlèn». Daniele, ci racconta la storia di Pasta zalla? «È una storia strana e divertente perché io non vengo dalla pasta, non ho tradizioni familiari, ero un pubblicitario. Ho fatto una bella esperienza con Radio 105 dal 1987 al 2000, gli anni d’oro delle radio private, un momento pazzesco e bellissimo, poi sono passato alla tv lavorando dieci anni in quella che si chiamava Sipra, oggi è Rai Pubblicità, un’esperienza che mi ha formato dal punto di vista del marketing. Nel 2010, crisi. Cambio mestiere. Succede». Hai dovuto cambiare? «Sì, ho dovuto cambiare. A quel tempo avevo 50 anni». È un problema che hanno in tanti, sempre più persone. Raccontaci come hai fatto tu. «Natale 2011, vivevo a Roma, con la persona con cui avevamo messo su famiglia a Roma decidemmo di preparare un pranzo di Natale con delle cose sia di Roma che di Bologna. Una mia ex impiegata di qualche anno prima aveva rilevato un laboratorio di tortellini a Bologna e ci ero rimasto in contatto. Accadde una cosa stranissima: sul tavolo del pranzo di Natale le cose di Roma, fantastiche, rimasero un po’ da parte e la novità delle cose di Bologna venne gradita moltissimo. Feci una ricerca e capii che a Roma non c’erano cose di Bologna. Quei giorni leggevo un articolo di Stefano Bonilli, grande giornalista, fondatore del Gambero rosso, dove lui parlava di tortellini, un articolo rimasto nella storia, una specie di testamento spirituale che lui ha lasciato sui tortellini artigianali. L’insieme di queste due cose ha fatto sì che un anno dopo aprissi una bottega di tortellini artigianali fatti a Bologna e trasportati a Roma. Tre, quattro anni così, belli, poi è arrivata la chiamata di Eataly e abbiamo aperto un corner dentro Eataly Roma. La cosa è andata molto bene e due anni dopo, facendo accordi con i laboratori, cercando di migliorare l’artigianato in artigianato organizzato, come l’hanno definito Uliassi e Niko Romito, grandi chef che si occupano di cibo in maniera un po’ moderna, sono riuscito a portare i tortellini da Bologna in tutta Italia e anche a Monaco, dentro tutti i punti vendita di Farinetti». Artigianato organizzato? «Ci sono delle realtà di artigianato organizzato, tantissime in Italia, con codice Ateco 1073, “produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili”, dipendenti sotto i 15, metà delle lavorazioni rigorosamente artigianali e non meccaniche, questo identifica l’impresa artigiana. Poi c’è quello che si chiama artigianato casalingo». La sfoglina? «La sfoglina o la zia o la nonna, che dal punto di vista normativo non possono andare fuori provincia. Io sono il migliore ambasciatore e difensore talebano di quel tipo di artigianato, però ha dei limiti oggettivi nell’esportare il prodotto fuori provincia». Attività come la tua difendono l’artigianato. C’è questo stereotipo della produzione artigianale di alta quantità, quasi industriale, che sarebbe sempre «assassina» della produzione individuale e artigianale. Ma ci sono tante aziende che, come la tua, producono un prodotto artigianale, semplicemente in maggiore quantità. «Cito Niko Romito, grande chef in Italia e nel mondo, che nell’ultimo Identità golose (congresso internazionale di chef, ndr) ha detto: “Dobbiamo smetterla di pensare che ‘fatto in casa’ sia meglio di ‘artigianato organizzato’”. Riusciamo a fare un prodotto di qualità artigianale (cioè con materie prime di qualità, di produttori che sono vicino al laboratorio, dei quali conosciamo la storia aziendale, e in questo modo il prodotto rimane artigianale perché le materie e le lavorazioni lo sono) con caratteristiche che ci permettono di portarlo un po’ lontano dal luogo di produzione». E al grande pubblico. «Sì e le lavorazioni non sono industriali. Grande rispetto per la grande industria alimentare italiana, però industria vuol dire che non c’è quasi l’intervento dell’uomo. Nel nostro caso c’è in almeno metà delle lavorazioni». Dell’uomo e neanche del luogo, mi viene da dire. Molto spesso la Gdo prende materie prime che non sono del territorio. «Noi teniamo la filiera stretta, coesa, con rapporti coi fornitori di lungo periodo: galline di allevamenti emiliani, Parmigiano Reggiano di un caseificio di Zocca di cui prendiamo quasi tutta la produzione». Sembra la quadratura del cerchio tra estremismo sovranista, per cui uno deve mangiare esclusivamente quello che gli cresce spontaneamente vicino, ed estremismo progressista, per cui si importa tutto dall’altro capo del mondo, rinnegando completamente ciò che effettivamente mi cresce intorno o tralasciando di far lavorare aziende della mia nazione, invece che quelle di un’altra... «I grandi hanno detto: “Non parliamo di chilometro zero ma di chilometro buono”. Chiunque mangi in una città lo spaghetto alle vongole non può pretendere il chilometro zero». Con Pasta zalla io posso mangiare il vero tortellino bolognese pur non recandomi a Bologna. «Stefano Bonilli, fondatore e editore del Gambero rosso, morto, purtroppo, nel 2014, ci ha lasciato un grande vuoto perché era il più grande giornalista enogastronomico vivente. Quando l’ho conosciuto - ho avuto la fortuna di averlo come cliente nella mia bottega a Roma - mi disse: “Ti do una mission: cerca di realizzare il miglior tortellino possibile e di portarlo al maggior numero di persone possibile”. Questo è un regalo meraviglioso che mi ha fatto». È una questione di identità del piatto. Spesso la Gdo sceglie di esportare un prodotto locale neutralizzandone alcune caratteristiche: il supplì «alla romana», ma senza carne; le polpette di melanzane «calabresi», ma senza aglio e cipolla; il panettone decurtato della sua milanesità. Può andar bene per chi non sa nemmeno che esistono questi e altri piatti locali, lo scopre e poi cerca gli originali, ma sarebbe più onesto, da un punto di vista culturale e commerciale, portare il vero prodotto. «Ci sono due parole chiave: tradimento e esperienza gastronomica. Tradire l’aspettativa della persona a cui hai detto: “Questo è il tortellino di Bologna”, è un delitto. Fai un torto al cliente, a te azienda, alla bolognesità cui ti ispiri». Ci dici alcune regole del tortellino bolognese? «A Bologna si usa assaggiarlo crudo nei laboratori per assaporare la materia prima. E io ho pensato di farlo fare fuori Bologna. Quando metto il cartello “Hai mai assaggiato un tortellino crudo?”, offrendo l’assaggio ai clienti, 8 su 10 dicono che non l’hanno mai fatto. Poi, la regola del brodo. Come dice Bruno Barbieri, “il tortellino deve morire annegato nel brodo”. È diventata una frase cult. Il tortellino non deve vedere l’acqua, perché l’acqua gli toglie metà del sapore. Va cotto sempre e solo in brodo». G. Gae.
Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali.