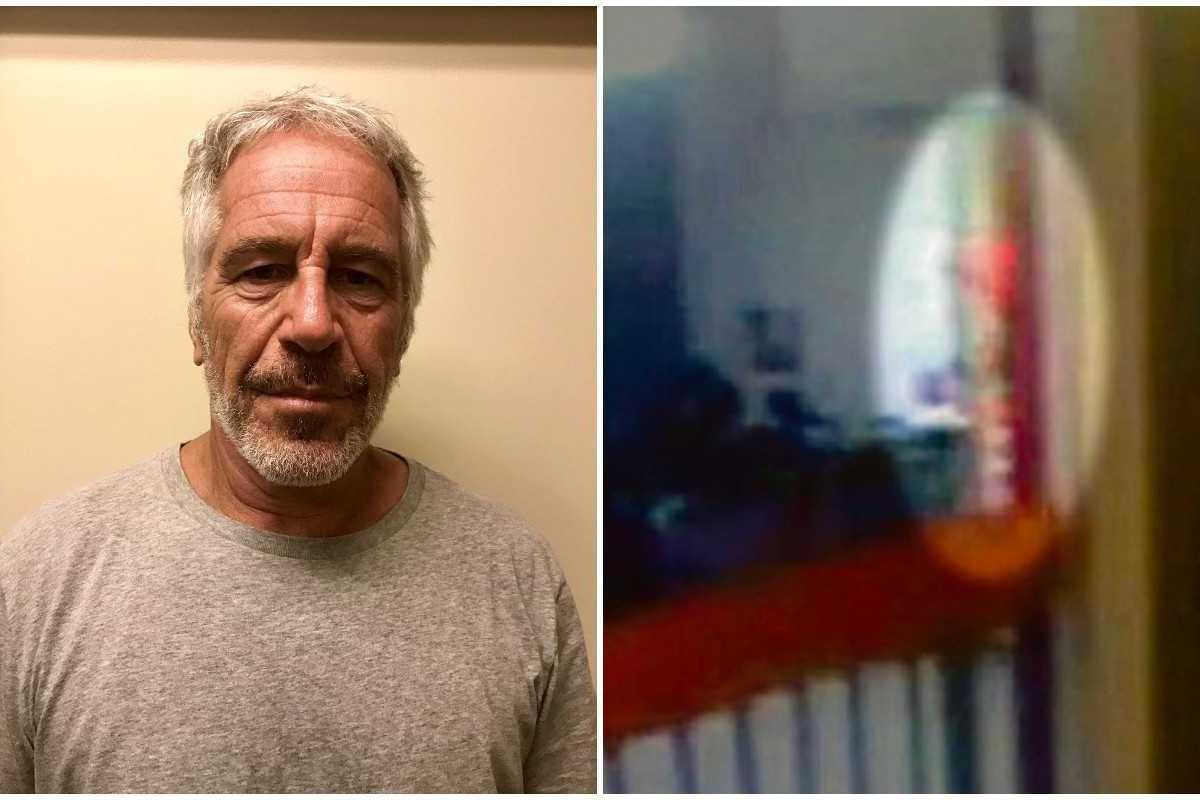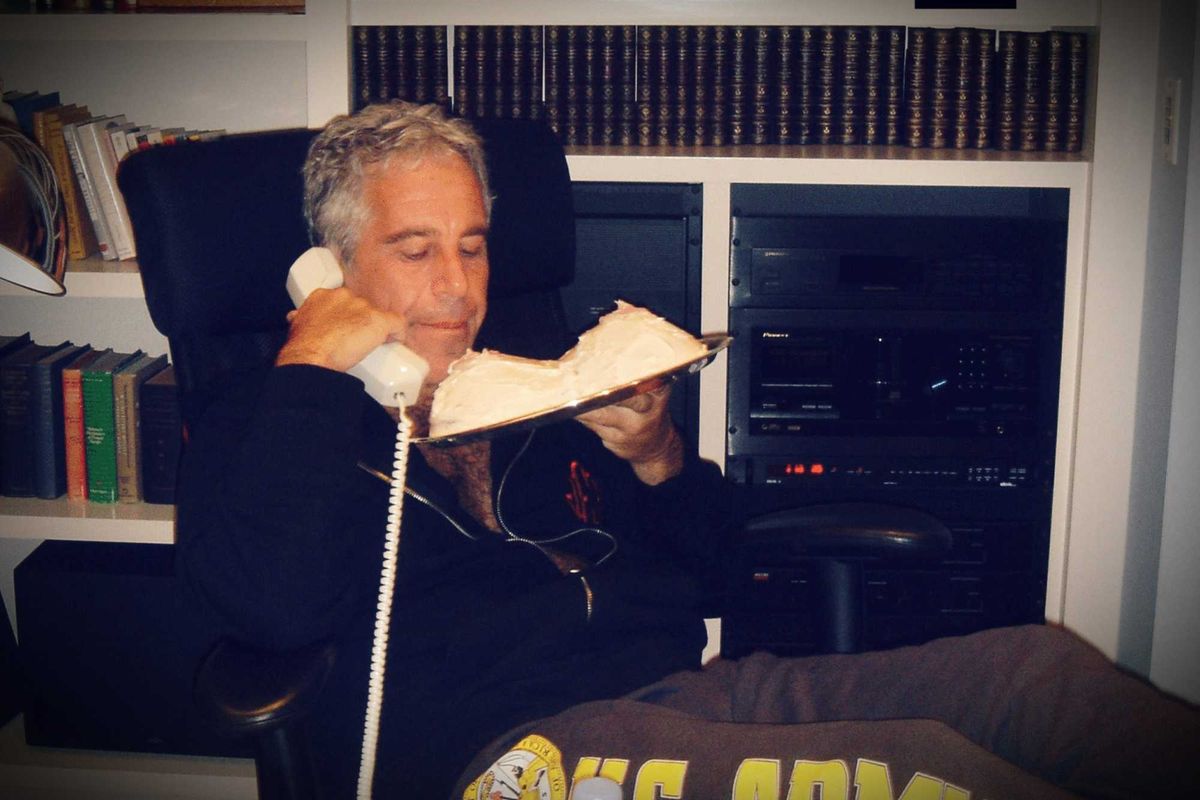Batacchi: «Leonardo, Lockheed, Boeing. Ecco chi avrà più ordini dalla corsa agli armamenti»

«L’industria italiana ha solo da avvantaggiarsi dall’aumento degli investimenti in difesa. Gruppi come Leonardo, MBDA, ELT Group, Avio Aero, tutta la filiera aereonautica come Magnaghi, poi Iveco Defence Vehicles che già sono eccellenze a livello internazionale, diventerebbero ancora più competitive. E questo vuol dire commesse in tutto il mondo, più ricerca e sviluppo e più occupazione. Senza contare poi le ricadute sul settore civile poiché le infrastrutture militarmente strategiche sono anche a uso civile». Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana Difesa, traccia uno scenario dell’impatto che l’accordo scaturito dal vertice della Nato a L’Aia, avrà per l’industria militare europea e italiana in particolare e sul sistema Paese. Un accordo che segna una svolta per l’alleanza atlantica con l’impegno dei 32 Stati membri ad aumentare la spesa per la difesa entro il 2035 fino al 5% del Pil ma che è stato accompagnato da aspre polemiche soprattutto dalla sinistra.
Innanzitutto questo 5% come sarà ripartito?
«Un 3,5% della spesa andrà a investimenti di ammodernamento, per il personale che è la componente più grossa, la manutenzione dei mezzi, l’addestramento e tutte quelle attività che consentono di mantenere in efficienza l’apparato militare. Questa categoria è strutturalmente bassa. Negli ultimi tre anni in Italia, abbiamo visto un aumento delle spese per ammodernamento, quelle per il personale sono rimaste più o meno stabili ma quelle per il mantenimento di efficienza dello strumento militare sono rimaste basse. Quest’anno addirittura inferiori a 2 miliardi l’anno. Sono numeri preoccupanti. Poi c’è l’1,5% dedicato a spese collaterali, come le infrastrutture strategiche, ovvero i ponti, le strade, i sistemi ferroviari. Questi hanno una spiccata natura duale, cioè consentono in caso di guerra di spostare uomini e mezzi con rapidità ma in pace servono ai trasporti civili. Poi abbiamo un po’ di spese per la cyber, per la protezione da attacchi cibernetici, la tutela delle infrastrutture critiche come le condutture sottomarine che portano gas. Nell’1,5% c’è una parte significativa di investimenti di cui ne beneficiano le nostre industrie».
Eppure c’è chi a sinistra sostiene che gli investimenti in difesa tolgono fondi al welfare, alla sanità. In sostanza impoveriscono il Paese.
«È un ragionamento demagogico che ha come unico obiettivo di coltivare il proprio orticello elettorale, ma gli uomini di Stato devono guardare al futuro del sistema Paese. E tra i settori strategici del futuro, c’è la difesa. Senza sicurezza non c’è benessere. Quel welfare, modello europeo di cui tanto si parla, è stato possibile grazie alla garanzia politico militare della Nato, grazie al fatto che i Paesi europei durante la Guerra Fredda dedicarono una parte significativa del Pil alle spese militari. Questo consentì di creare un perimetro di sicurezza dentro il quale è stato possibile sviluppare ricchezza e stato sociale».
E adesso cos’è successo? «La Nato, sulla spinta dell’amministrazione Trump ha deciso di aumentare le spese militari anche a causa degli avvenimenti internazionali. C’è il pericolo russo, l’instabilità nel Mediterraneo, nel Medio Oriente. La questione centrale è quella della supply chain, delle grandi catene di approvvigionamento soggette a instabilità. Per proteggere le fonti di approvvigionamento e le grandi vie di comunicazione, occorrono strumenti adeguati che sono militari ad alta tecnologia in grado di monitorare e fare da deterrente. Più un Paese ha potere dissuasivo e meno mette a rischio la sua sicurezza e i suoi interessi».
Questa massa di investimenti non finirà per avvantaggiare l’industria bellica tedesca e francese più che quella italiana?
«Direi di no. Ne beneficerà anche il nostro aerospazio da difesa che in Europa è secondo solo a quello francese. Oggi questo comparto è al vertice strategico dell’industria manifatturiera considerando anche la crisi dell’automotive. È un’industria assolutamente competitiva, che è in grado di competere a livello internazionale, mentre tanti settori della manifattura non lo sono più. Noi saremmo dunque beneficiari di tali investimenti. Si avvantaggeranno non solo colossi quali Leonardo, Fincantieri, MBDA, ELT Group, Avio Aero ma anche tutta la filiera di centinaia piccole e medie imprese, custodi di competenze e tecnologie».
Chi polemizza sostiene che i maggiori vantaggi li avranno gli Stati Uniti. All’Italia andranno le briciole?
«Non credo. È chiaro che oggi l’industria militare americana è la più forte e sviluppata perché ha sempre investito. Penso ai colossi Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing Defence, RTX (nata dalla fusione nel 2020 di United Technologies e Raytheon Company, ndr). Ma ne beneficeranno anche l’Europa e l’Italia.
Per esempio?
«Recentemente l’Italia ha acquistato 25 nuovi caccia Eurofighter il cui valore per il 36% dipende da Leonardo che realizza importanti componenti strutturali e elettronici. Dire che i vantaggi saranno solo per gli americani è un esercizio di retorica. In Italia oggi è in corso un potenziamento della supply chain dello spazio e difesa molto importante e questo dipende dal fatto che ci saranno gli investimenti. Altrimenti compreremo solo dagli americani, ma non è così».