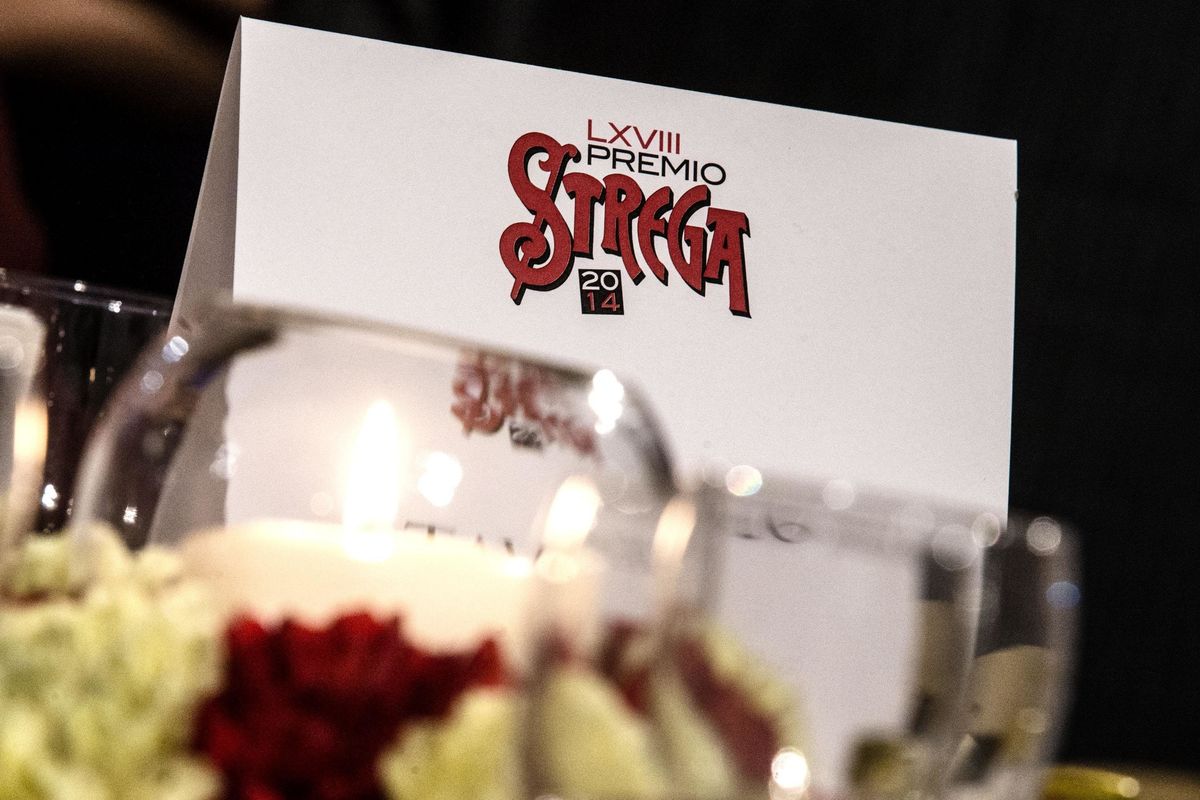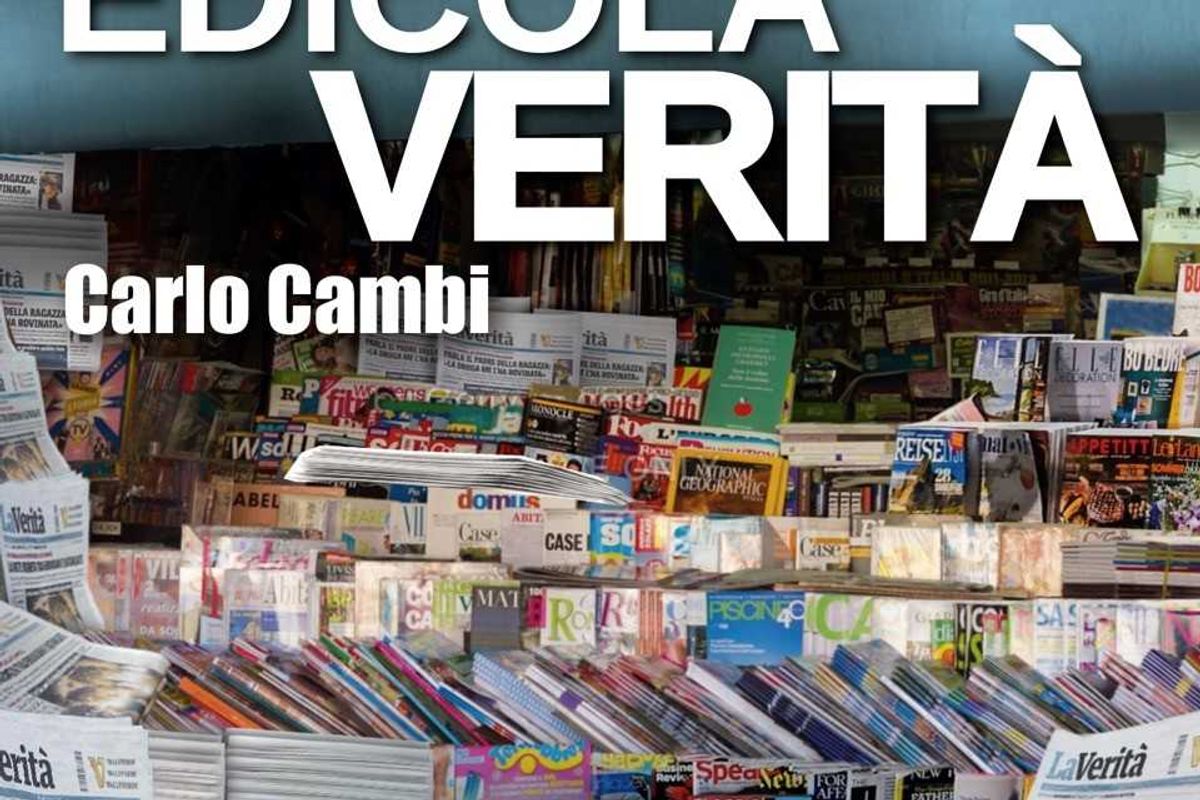2018-04-21
Il pianto delle scrittrici a caccia dello Strega
Nemmeno il premio più famoso del salotto letterario italiano sfugge all'ira delle femministe. Le narratrici nostrane rivendicano il diritto di vincere, al di là della qualità del loro lavoro. Alla giuria non è bastato tutelarsi mandando in finale sei donne su dodici. Facciamo così: cambiamo nome alla competizione. Rendiamo tutto più diretto e trasparente. Chiamiamolo premio Streghe (perché una non basta) e facciamo partecipare e vincere soltanto donne. Speriamo che, in questo modo, i piagnistei finiscano e le scrittrici italiane possano finalmente dedicarsi a sfornare testi che non siano appelli lacrimevoli. Le autrici di casa nostra - appresa la lezione del Me too e delle Furie statunitensi che lo animano - hanno deciso di battere cassa. Se ne fregano della parità, loro vogliono i premi, i gagliardetti, le coccarde. Vogliono più inviti ai festival, più celebrazioni e - ovviamente - più incassi. Poco importa se l'immenso Thomas Bernhard sosteneva che, per uno scrittore, ritirare un premio è come farsi defecare in testa. Bernhard era pur sempre un maschio, che poteva mai saperne? «Le donne sono sfavorite nei premi», lamenta su Repubblica Helena Janeczek. «E per le scrittrici è più facile finire nel dimenticatoio, non rientrare nel canone». E dire che i giurati dello Strega pensavano di essersi messi al riparo dalle critiche. Nell'anno della psicosi molestie, hanno rispettato a puntino le quote. Dei 12 autori finalisti, la metà esatta sono donne. Per di più, i libri che propongono sono un tripudio di impegno sociale e cause umanitarie. C'è, appunto, la Janeczek con La ragazza con la Leica (Guanda), sulla vita di Gerda Taro, compagna del celebre fotografo Robert Capa. «Per me Gerda è il prototipo della donna libera, emancipata pur senza rinunciare ai suoi lati frivoli», spiega l'autrice. «Pare che molte delle foto firmate a nome Capa siano state scattate da lei, forse anche quella del miliziano colpito a morte». Ovvio: gli uomini sono sempre ladri, persino quando si tratta di noti artisti progressisti. Tra le finaliste compare poi Francesca Melandri, il cui Sangue giusto (Rizzoli) è stato incensato come «il romanzo dello ius soli». La madre di Eva (Neo edizioni) di Silvia Ferreri, invece, parla di transessualità, mettendo in scena una madre che segue la giovane figlia intenzionata a diventare uomo. Il figlio prediletto (Neri Pozza) di Angela Nanetti tratta di «omosessualità e della condizione femminile nella Calabria degli anni Settanta e di oggi». Chiudono il battagliero manipolo Sandra Petrignani con La Corsara, un ritratto di Natalia Ginzburg (che lo Strega lo vinse nel 1963) edito da Neri Pozza e Lia Levi, con un affresco dell'Italia all'epoca delle leggi razziali (Questa sera è già domani, edizioni e/o). Non manca nulla, no? Tutte le «minoranze discriminate» sono rappresentate, ogni sentiero di militanza possibile è battuto. Ma ancora non basta. No: serve il premio. «Allo Strega cercasi vincitrice disperatamente», titola Repubblica. «È strano che il mondo editoriale parli tenacemente maschile», scrive Raffaella De Santis, «visto che le lettrici sono soprattutto donne e che adorano i personaggi femminili». A perorare la causa giunge pure Maddalena Vianello, «fra le organizzatrici di Inquiete, festival di scrittrici nato a Roma lo scorso anno». Proprio Inquiete, assieme a Book pride e al Salone del libro di Torino, ha sponsorizzato «l'Osservatorio su uomini e donne nell'editoria» curato dalla rivista online Ingenere.it. Secondo tale osservatorio, lo Strega sarebbe un lampante esempio di discriminazione. «Dall'istituzione del premio», dice la Vianello, «sono solo dieci le donne ad averlo vinto. [...] Sono quindici anni che una scrittrice non vince il premio Strega: l'ultima è stata Melania Mazzucco nel 2003». Non che il resto del mondo letterario sia meglio: «Le scrittrici più in generale rappresentano spesso una minoranza nei festival letterari, relegate in orari poco appetibili. Come i buoni programmi televisivi che finiscono in seconda serata. E nei consigli di lettura per le vacanze di Natale o per l'estate sono costantemente sottorappresentate». Capito? Persino la scuola discrimina le autrici. Curioso, visto che quasi l'80% del corpo insegnante, in Italia, è costituito da donne. Si vede che nemmeno maestre e professoresse consigliano romanzi scritti da donne. Ah, che traditrici della causa! «Il soffitto di cristallo», conclude la Vianello, «quindi esiste e anche le scrittrici sembrano picchiarci dolorosamente la testa». E allora che si rompa il vetro, che si assegnino riconoscimenti a pioggia. La qualità dei romanzi, del resto, è un fattore assolutamente secondario. In fondo, lo Strega ormai da anni (e forse da sempre) è una specie di giochettino di potere riservato ai grandi gruppi editoriali, mica un certificato di eccellenza. Le scrittrici, semplicemente, vogliono la loro fetta di torta, bramano la bandella avvoltolata attorno al romanzo come una fetta di pancetta, capace di garantire qualche migliaio di copie vendute in più. Alla fine della fiera, è tutta una questione di soldi e di visibilità, ammantata da battaglia per i diritti. Un classico esempio di «dirittismo», moda progressista che confonde le pretese individuali e le rivendicazioni sociali. Le gentili signore non vogliono solo il diritto di partecipare e di competere ad armi pari. Vogliono il «diritto di vincere». E non perché sono brave, ma perché sono donne. Conviene allora rileggersi ciò che ha scritto, non molti giorni fa, il premio Nobel Mario Vargas Llosa: «Attualmente il più risoluto nemico della letteratura, che pretende di depurarla dal maschilismo, da molteplici pregiudizi e immoralità, è il femminismo. Non tutte le femministe, naturalmente, ma le più radicali, e con loro ampi settori che, paralizzati dal timore di essere considerati reazionari, intolleranti e fallocrati, appoggiano apertamente questa offensiva antiletteraria e anticulturale». Già, qui siamo nel campo dell'antiletteratura, siamo nel pieno di quella che il critico letterario Harold Bloom chiamava «scuola del risentimento». La razza, il sesso, l'appartenenza politica e religiosa contano più delle opere. Vargas Llosa, nello specifico, se la prendeva con il «decalogo per la scuola di genere» stilato dalle militanti del sindacato spagnolo Ccoo. Un testo che, spiega l'agenzia di stampa Agi, «chiedeva il divieto del calcio nei cortili scolastici, la femminilizzazione delle discipline storiche, scientifiche, letterarie e chiede tuttora l'abolizione dalle letture obbligatorie di autori “maschilisti e misogini"». Tra questi scrittori nemici delle donne ci sarebbero, per dire, Pablo Neruda, Javier Marías, Arturo Pérez-Reverte. Vargas Llosa ha polemizzato pure con la scrittrice Laura Freixas, una che ha avuto il fegato di massacrare Lolita di Vladimir Nabokov: «Ha spiegato che il protagonista era un pedofilo incestuoso stupratore di una bambina, per colmo sua figlia e sua sposa. (Dimenticò di dire che è, per inciso, uno dei migliori romanzi del ventesimo secolo)». Le autrici italiane non sono ancora giunte a simili eccessi, ma la strada che hanno imboccato è la medesima. Non resta che accontentarle, queste sindacaliste della narrativa. Che la loro caccia allo Strega vada a buon fine. Si tengano gli allori, si godano la vetrina, si accaparrino l'agognata poltroncina nel salotto dei letterati di regime. Diventino, una volta per tutte, personaggi degni di un romanzo di Bernhard o di Edward St Aubyn: così, almeno, avranno finalmente qualcosa a che fare con la grande letteratura.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast dell'11 novembre con Carlo Cambi
Da sinistra: Piero De Luca, segretario regionale pd della Campania, il leader del M5s Giuseppe Conte e l’economista Carlo Cottarelli (Ansa)
Jannik Sinner (Ansa)
All’Inalpi Arena di Torino esordio positivo per l’altoatesino, che supera in due set Felix Auger-Aliassime confermando la sua solidità. Giornata amara invece per Lorenzo Musetti che paga le fatiche di Atene e l’emozione per l’esordio nel torneo. Il carrarino è stato battuto da un Taylor Fritz più incisivo nei momenti chiave.
Agostino Ghiglia e Sigfrido Ranucci (Imagoeconomica)