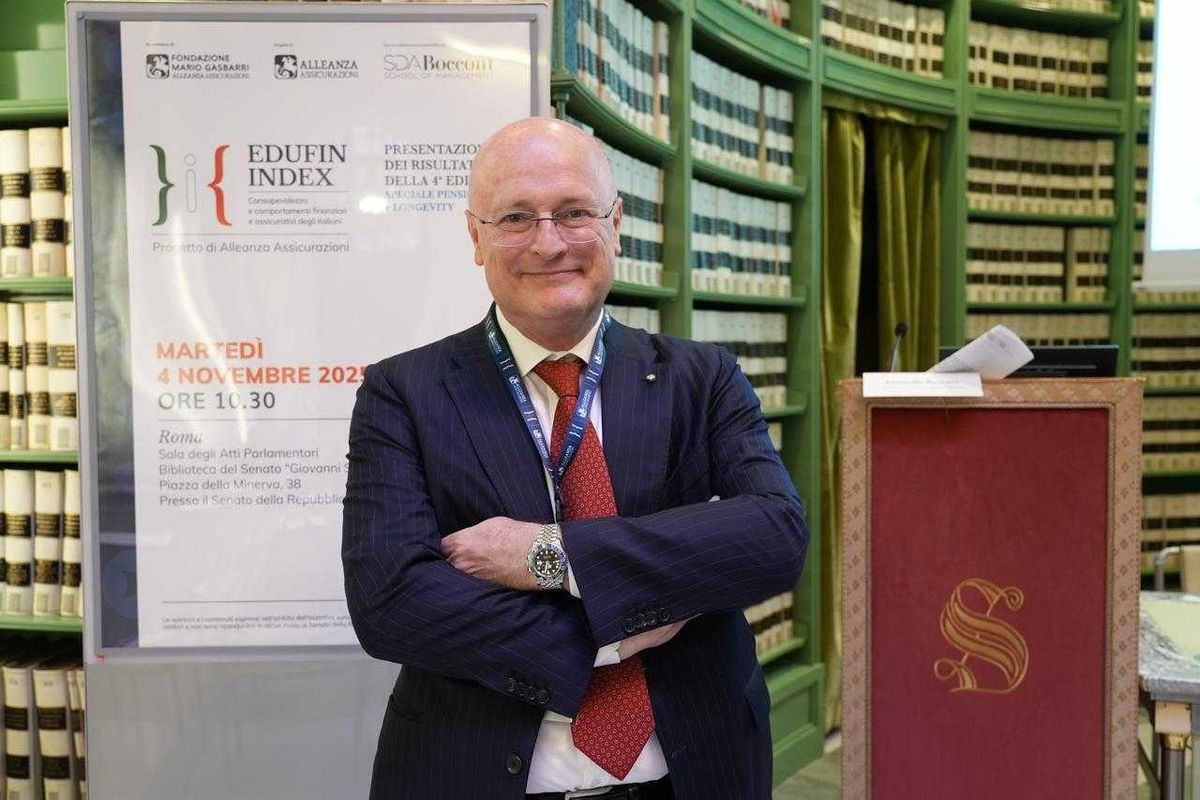Le mostre permanenti sul cibo richiamano nel mondo milioni di persone. Una nuova forma di turismo culturale che dà valore ai prodotti e al territorio. In Italia i visitatori sono in aumento, ma all'estero le strutture sono anche all'avanguardia e fanno rete.Possono un pezzo di parmigiano reggiano, o 'na tazzulella 'e cafè, diventare opera d'arte? Hanno le carte in regola per accedere all'Olimpo della cultura al pari di sculture e dipinti? La risposta è affermativa, se si guarda al boom che in Italia, ma anche nel resto del mondo, sta coinvolgendo i musei dedicati al cibo. L'ultimo, in ordine di tempo, verrà inaugurato a ottobre a New York ed è rivolto a una delle eccellenze del Made in Italy, nonché simbolo dell'immaginario collettivo: la pizza. Si chiama Mopi. Una scelta che ha portato con sé inevitabili perplessità, ma anche la consapevolezza che il nostro patrimonio enogastronomico merita un posto d'onore nelle gallerie d'arte. La tendenza è in crescita, come dimostra il museo che a Dublino mette in mostra la famosissima birra Guinness e che ogni anno richiama circa un milione di visitatori. Ma anche il caso dell'Heineken Experience di Amsterdam, frequentato da 600.000 persone ogni anno.Nel frattempo il nostro Paese non è rimasto a guardare, forte di una moltitudine di distretti del cibo spesso accompagnati da esposizioni e gallerie dedicate. È il caso, per esempio, del museo del parmigiano reggiano di Soragna, vicino a Parma, o della nuovissima Nuvola Lavazza, lo spazio recentemente inaugurato a Torino per raccontare la storia del caffè. Realtà come queste non hanno solo il vantaggio di valorizzare e difendere i prodotti che rappresentano, ma anche di contribuire allo sviluppo del territorio. Spesso piccoli borghi, che diventano mete turistiche. «Lo sviluppo dei musei dedicati al cibo in Italia ha subito una decisa accelerata negli ultimi 15 anni», spiega Guido Guerzoni, docente di Museum mangement all'università Bocconi di Milano. «Ci sono numerosi esempi virtuosi come per esempio il Wimu, il museo del vino di Barolo». A spingere questa nuova forma di turismo e di cultura è una trasformazione radicale nelle abitudini dei consumatori. Sempre più attenti alla qualità, alla scoperta delle tradizioni, all'importanza dei territori. Slow food docet. Sono sorti così il distretto del Franciacorta, che oggi può contare su alcuni fra i migliori enologi del mondo e su cantine hi-tech. Così come quello del parmigiano reggiano e del prosciutto a Parma, quello del vino Barolo in Piemonte, quello della carne di cinghiale, del Chianti e del pecorino in Toscana. A formalizzare la nascita di queste realtà è stato recentemente il ministero delle Politiche agricole e forestali, con l'istituzione del registro nazionale dei distretti del cibo. Un passo importante per difendere il nostro patrimonio enogastronomico, che da solo vale il 15% del Pil: 1 euro su 6, di quelli prodotti in Italia, arriva proprio dall'agroalimentare. Solo nel 2016 la crescita del comparto è stata del 9% rispetto all'anno precedente, a fronte del meno 21% registrato dall'industria. Mentre il saldo fra import ed export ha superato i 10 milioni di euro. Numeri, quelli resi noti dall'Istat, che hanno portato, nel corso del 2017, a 132 milioni di euro di fatturato, con 6.850 imprese e 385.000 addetti coinvolti. «I musei del cibo nascono con l'intento di raccontare i prodotti a 360 gradi, ma anche di divulgare fra i visitatori un'educazione alimentare positiva», prosegue Guerzoni. La maggior parte di queste realtà si trova proprio nei cosiddetti food district. È il caso, per esempio, del museo di Sulmona dedicato ai confetti, e di quello creato per la liquirizia a Rossano Calabro. Attraversando lo Stivale si incontra anche il museo del prosciutto di Langhirano, quello della pasta e del pomodoro di Collecchio, quello dell'olio di oliva di Alberobello. E ancora il museo del salame di Castello di Felino, il museo del vino di Greve in Chianti e perfino quello dedicato alla dieta mediterranea di Pollica, in provincia di Salerno. «Gli alimenti stanno entrando a pieno titolo nel mondo dei musei e questo aspetto piace moltissimo al pubblico, spinto anche dalla forza mediatica che la cucina sta dimostrando negli ultimi anni. Tutto questo ha implicazioni importantissimi anche dal punto di vista turistico», continua a spiegare il docente della Bocconi. «I visitatori entrano in questi luoghi per la loro bellezza architettonica, ma anche per scoprire il mondo che si cela dietro a determinate produzioni. In questo modo scoprono anche luoghi nei quali diversamente forse non sarebbero andati». Basti pensare al caso di Spilamberto, nei pressi di Modena, diventato meta privilegiata di chi voglia scoprire il museo dedicato all'aceto balsamico tradizionale. Questo nonostante alcuni limiti che lasciano il nostro Paese ancora indietro rispetto ad altre eccellenze internazionali. «L'Italia ha un grandissimo potenziale, ancora parzialmente inespresso. I musei dedicati al cibo non sono ancora in rete fra loro e si affidano ad allestimenti ancora troppo tradizionali. Questo produce numeri importanti, ma ancora lontanissimi da quelli registrati oltre confine», conclude Guerzoni. In media, in Italia, ognuna di queste realtà non supera i 20.000 visitatori l'anno, con la sola eccezione delle strutture più all'avanguardia. All'estero c'è invece maggiore respiro, come dimostra per esempio l'utilizzo di strumenti multimediali in grado di creare esperienze percettive, che richiamano e divertono i visitatori. Insomma, i margini di crescita non mancano. Ma occorre fare un passo più deciso verso l'innovazione.
Zohran Mamdani (Ansa)
Dalle politiche sociali ai limiti dell’esproprio alla città come «santuario» per i gay Mamdani rappresenta la radicalizzazione dei dem. Ma anche una bella grana
Da più parti, la vittoria di Zohran Mamdani alle elezioni municipali di New York City è stata descritta (se non addirittura salutata) come uno «schiaffo» a Donald Trump. Ora, a prima vista, le cose sembrerebbero stare effettivamente così: il prossimo primo cittadino della Grande Mela, che entrerà in carica a gennaio, sembra quanto di più lontano possa esserci dal presidente americano. Tanto che, alla vigilia del voto, lo stesso Trump aveva dato il proprio endorsement al suo principale sfidante: il candidato indipendente, nonché ex governatore dem dello Stato di New York, Andrew Cuomo.
Rifugiati attraversano il confine dal Darfur, in Sudan, verso il Ciad (Getty Images)
Dopo 18 mesi d’assedio, i paramilitari di Hemeti hanno conquistato al Fasher, ultima roccaforte governativa del Darfur. Migliaia i civili uccisi e stupri di massa. L’Onu parla della peggior catastrofe umanitaria del pianeta.