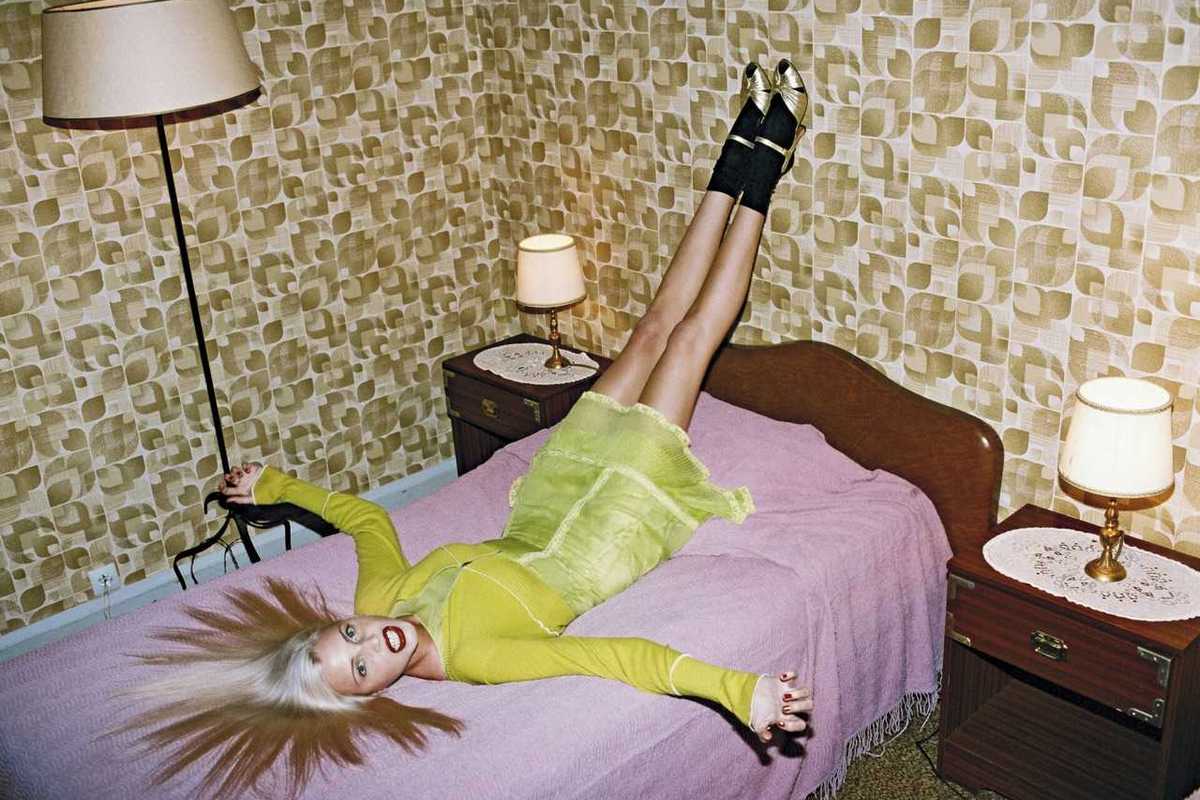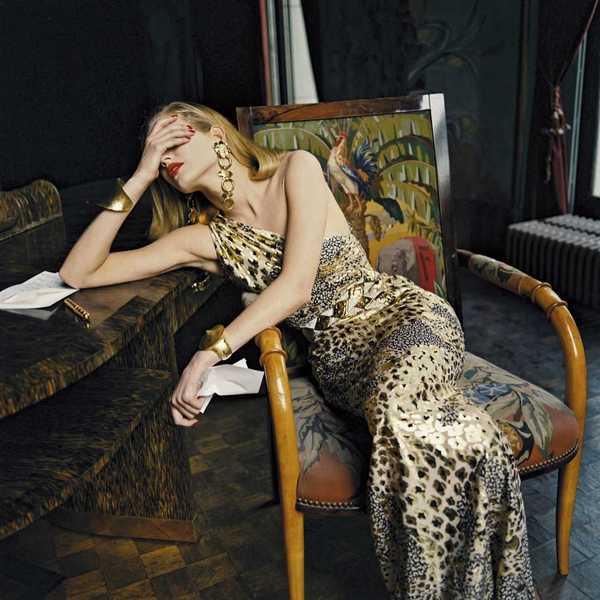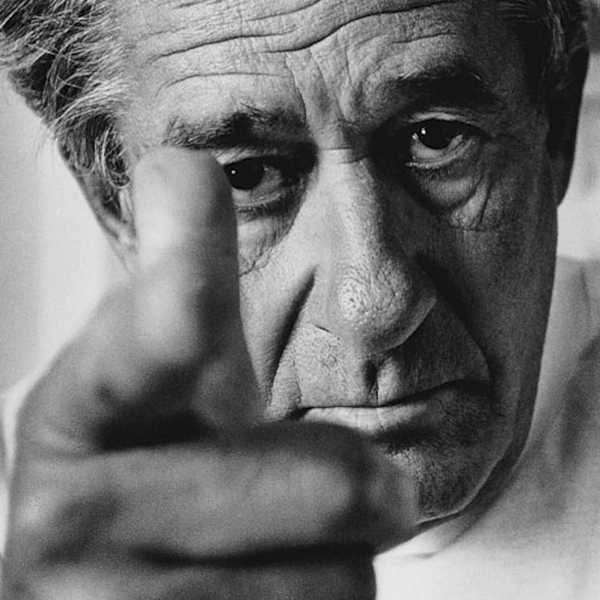Bella sorpresa, riscoprire quel pezzo di verità nascosto nelle pieghe dei detti popolari. «Italiani popolo di santi, poeti e navigatori», per esempio. Di santi ne sono rimasti pochi, di poeti qualcuno - ma la poesia non sempre dà pane -, restano i navigatori, una schiatta di individui che conserva pure qualcosa di poetico nell'animo e la pazienza, se non di un santo, almeno di un aspirante certosino. Lo hanno ben dimostrato a Tokyo Ruggero Tita e Caterina Banti, dominatori incontrastati della vela mista sui loro catamarani volanti classe Nacra 17.
L'oro dei due campioni delle onde è un balsamo per il medagliere azzurro: dopo aver collezionato bronzo e argento, la bacheca si sta rimpinguando anche col metallo più prezioso. L'Italia della vela attendeva un podio da 13 anni, l'ultima medaglia risaliva al bronzo conquistato da Diego Romero nella classe Laser, correva l'anno 2008, le Olimpiadi si svolgevano a Pechino. E però il sapore di quest'impresa è inebriante, non c'è confronto con il passato. La coppia Tita-Banti ha affrontato l'ultima tappa della Medal race con la consapevolezza di chi sa di amministrare un cospicuo vantaggio - 12 punti sulla coppia britannica e 24 su quella tedesca - facendo della razionalità senza strappi un privilegio stilistico. Ieri sarebbe stato sufficiente un sesto posto per portare a casa l'oro, tallonando gli inglesi John Gimson e Anna Burnet, imitandone le virate, rimanendo loro attaccati come era solito fare Il colombre raccontato da Dino Buzzati, il pesce messaggero destinato a rincorrere i marinai di ogni tempo e ogni mare. Così è accaduto. La regata dall'approccio conservativo vedeva nelle battute iniziali i britannici al settimo posto, gli italiani ottavi. Poi la flotta anglosassone ha allungato la marcia, piazzandosi quinta, senza sconvolgere gli orizzonti del duo nostrano, collocatosi in sesta piazza, l'obiettivo minimo per chiudere in bellezza la gara.
Il traguardo veniva tagliato dagli argentini Santiago Raul Lange e Cecilia Carranza Saroli, campioni olimpici a Rio 2016, che hanno preceduto i danesi di 19 secondi e gli americani. A virate concluse, la classifica emetteva un verdetto trionfale: italiani primi nel computo generale con 35 punti, scartando come peggior risultato un ottavo posto in una tappa precedente. Significa oro, seguito dall'argento per Gimson e Burnet e dal bronzo per i tedeschi Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer. Pallottolliere alla mano, è la medaglia olimpica numero 16 nella storia della vela nazionale, e il quarto primo posto dopo Sensini nel 2000, Strulino-Rode nel 1952 e Leone Reggio nel 1936. Ma è anche la prima appannaggio di una flotta mista, un successo arrivato a corredo di un periodo esplosivo per il duo, che ha già arraffato un bronzo ai Mondiali 2017 e un oro nel 2018, oltre a essersi affermati due volte come campioni europei.
Il loro affiatamento ha radici lontane. Ruggero Tita da Rovereto, terra che la vulgata vorrebbe come generatrice di provetti sciatori più che di timonieri come lui, nasce nel 1992, si appassiona allo sport da subito e, come da copione, alle scuole elementari indossa per la prima volta un paio di sci. Ma il fuoco sacro - anzi, l'acqua sacra - della passione per la vela lo conquista poco dopo, quando si trova con la famiglia presso l'Associazione velica trentina. Il resto lo fa il talento, capace di condurlo verso precoci soddisfazioni agonistiche. Laureato in ingegneria informatica, abbraccia con passione ogni genere di sport estremo.
Caterina Banti nasce invece a Roma 34 primavere fa, sale per la prima volta su una barca all'età di 13 anni, il fratello è già un esperto navigatore. Il colpo di fulmine non giunge immediato. Si dedica alla scherma, all'equitazione, alla danza, si iscrive all'università, facoltà di Studi orientali, si laureerà col massimo dei voti in Studi islamici. Siccome però i grandi amori, cantava Antonello Venditti, «fanno grandi giri e poi ritornano», verso i 20 anni rimette piede su una barca a vela. Individuato in Ruggero il suo alter ego agonistico perfetto, non ha più smesso.
Basta guardarli all'opera, per cogliere in loro quel genere di sintonia che offre allo spettatore, magari a chi di imbarcazioni e vento non ne capisce niente, la bellezza dello straordinario nel gesto ordinario. Lo diceva il grande velista dei record Giovanni Soldini: «La barca a vela riproduce in piccolo tutti i problemi e le peculiarità del mondo». E le soluzioni soddisfacenti, ovviamente.