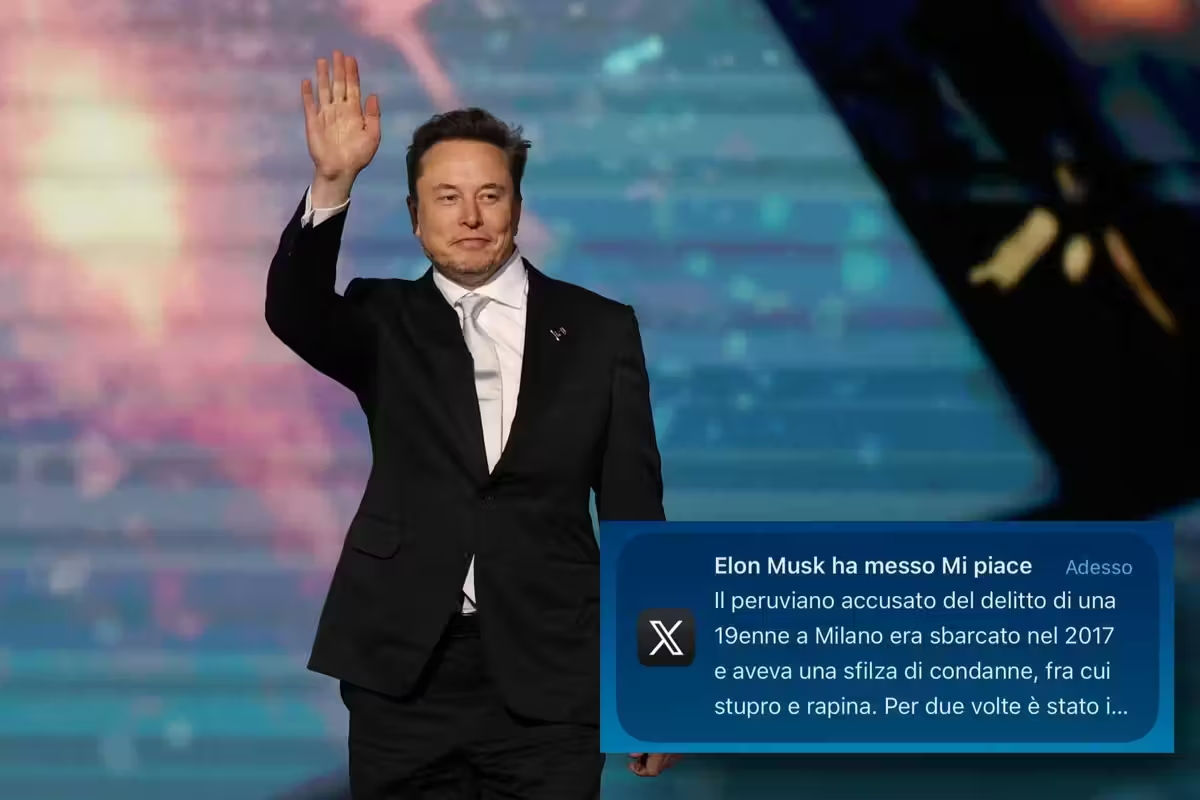Quel miscredente di Luigi Pulci, poeta umanista fiorentino morto in odor di eresia (gli rifiutarono la sepoltura in terra consacrata), fa rispondere da Margutte a Morgante che gli chiede se sia cristiano o saraceno: «Io non credo più al nero che all'azzurro/ ma nel cappone lesso o vuogli arrosto».
In Toscana vogliono molto bene al cappone, ma l'unico altare sul quale lo innalzano- il cappone ne farebbe volentieri a meno-, è quello del pranzo di Natale. C'è tutto un rito culinario da seguire: prima lo si massaggia ben bene dentro e fuori con sale, pepe, salvia, rosmarino, alloro e aglio; poi gli si dà una bella verniciata di strutto; infine lo si stende amorevolmente su un letto di patate e si inforna. Molti abitanti dell'antica Etruria, in obbedienza alle antiche tradizioni, lo fanno ripieno. Particolarmente gradita è la farcitura di castagne che dà al cappone un gusto tutto particolare, appenninico.
Il cappone è il re della tavola natalizia in quasi tutte le regioni d'Italia. Anche in Piemonte e Lombardia («Natal senza capon, Natal nient bon») lo amano ripieno. A Mantova, dove un proverbio recita «capun d'invèran e pulàstar d'istà» (cappone in inverno, pollo in estate), c'è una venerazione per il gallo castrato. Lo mettono in pentola per ricavarne il gustosissimo brodo del Sorbir d'agnoli, la fumante minestra con gli agnolini che «aggiusta» lo stomaco prima del pranzo di Natale. Con il petto lesso si prepara ancora l'insalata suggerita 350 anni fa da Bartolomeo Stefani, cuoco della corte gonzaghesca, che prevedeva di condire la carne del volatile con uvetta, chicchi di melograno, cedro candito, pinoli, extravergine d'oliva, aceto di mele, sale e pepe quanto basta. «I metodi di cottura sono cambiati», dice Claudio Somenzi dell'omonima trattoria di Grazie, in riva al Mincio, che cuoce il petto del cappone sottovuoto a bassa temperatura, «ma la ricetta è sempre quella». A San Giacomo delle Segnate, pochi chilometri sotto il Po, Gianfranco Cantadori alleva i capponi liberi, nel bosco dell'azienda, per otto mesi, come si faceva al tempo dei Gonzaga. «Faccio mangiare il cappone», proclama, «con lo stesso gusto con il quale lo mangiavano i Signori di Mantova secoli fa».
A Milano, un tempo, le famiglie benestanti seguivano la regola del quattro, tanti erano i capponi che allevavano: uno per Sant'Ambrogio, uno per Natale, uno per Capodanno e l'ultimo per l'Epifania. Alessandro Manzoni che conosceva bene le usanze della sua terra- e la bontà dei capponi- nei Promessi Sposi mette in mano a Renzo quattro capponi vivi, dei quali Agnese aveva riunito «... le otto gambe come se facesse un mazzetto di fiori», da portare in dono all'avvocato Azzecca-garbugli.
In Salento è tipico il cappone al tegame cotto con gli stessi odori toscani, ma con la cipolla al posto dell'aglio e con l'aggiunta di pomodori ciliegini. Nel cappone alla siciliana è previsto, nella casseruola, anche un bel bicchiere di marsala secco. In Veneto il cappone va rigorosamente bollito. I puristi lo cuociono alla canevéra, «Va mondato accuratamente», spiega Costanzo Compri, gastronomo-macellaio di Buttapietra in provincia di Verona, «salato e pepato dentro e fuori, farcito con tutti gli odori e un battuto di cipolla, carota, sedano, aglio. Poi s'infila in una vescica di maiale- se non si trova questa, in un sacchetto di plastica alimentare- che si chiude con un filo intorno a una canna (la canevéra). Lo si immerge nell'acqua della pentola badando che la canna emerga un bel po' perché durante la cottura deve sfiatare il vapore che, altrimenti farebbe scoppiare la vescica. È un procedimento complesso, ma il cappone risulterà di una bontà unica».
Lo conferma Pellegrino Artusi nella ricetta 367, Cappone in vescica, confessando, nella Scienza in cucina e l'arte del mangiar bene, che per ben quattro volte la vescica, bollendo, gli s'è rotta. «È un piatto, però, che merita di occuparsene visto che il cappone, già ottimo per sé stesso, diventa squisito cotto in tale maniera». Artusi confessa l'amore per il cappone in altre due ricette: Cappone arrosto tartufato e Cappone in galantina, «fatto a casa mia e servito a un pranzo di dieci persone, ma poteva bastare per venti». Credo bene. Il padre della cucina regionale italiana riempì la «belva», che vuotata e disossata pesava sette etti, con 200 grammi di vitella da latte, 200 di maiale, mezzo petto di pollastra, lardone, lingua salata, prosciutto, tartufi neri, pistacchi.
In Romagna non è Natale se in tavola manca il classico piatto di cappelletti cotti e serviti con il brodo di cappone. Gli abruzzesi nel brodo di cappone immergono le scrippelle, frittatine preparate con farina, acqua e uova. Umbria, Marche, Campania, Lazio... Il cappone è d'obbligo a Natale. C'è chi lo bollisce, chi lo prepara in galantina con il tartufo, chi lo farcisce con i marroni, chi con le prugne, con il macinato di manzo o di vitello, con la salsiccia, con le erbe di campo o con ogni altro tipo di verdura. Attenzione alla Liguria dove, per Natale, si prepara il tradizionale cappone bollito e servito con la mostarda e il cappun magru che in origine si preparava, a strati sovrapposti, con lo scorfano rosso (il pesce cappone, appunto), altri pesci poveri e con il cosiddetto capòn de galera, la galletta del marinaio messa in ammollo con acqua e aceto. Oggidì il cappon magro ligure, alla faccia del pesce povero, si prepara con gamberi, mitili e molluschi ricercati, pesce costoso e, perfino, aragosta.
Il cappone volatile è conosciuto fin dall'antichità. Il nome deriva dal greco kòptein che significa tagliare, «una chiara allusione», commentò lo scrittore Cesare Marchi, «alla sua benefica (per noi) mutilazione». I latini tradussero il greco in capo (caponis al genitivo) e il nome rimase attraverso i millenni. La Cucina Italiana, storico mensile di cultura gastronomica e di ricette che esce da 90 anni, parlando del cappone natalizio insegna che fin dal medioevo il brodo di cappone veniva regolarmente consumato nelle festività di dicembre in occasione del solstizio d'inverno: «In queste notti di veglia intorno al camino si raccontavano storie mangiando cibi particolarmente nutrienti e sostanziosi». Almeno chi poteva farlo. Adesso che in tanti possiamo permetterci il cappone il consumo del galletto senza più gli zebedei si è moltiplicato incredibilmente. Secondo Unaitalia, l'associazione de i principali produttori di carni avicole (Aia, Amadori, Fileni) i capponi sulle tavole degli italiani a Natale saranno 1,5 milioni.
Vincenzo Cervio, maestro nell'arte di tagliare le carni, al servizio di Alessandro Farnese nella seconda metà del Cinquecento, insegna nel libro Il trinciante, come affettare le carni con suprema maestria, tra le altre quelle del cappone. Descrivendo un banchetto con decine e decine di portate racconta che nel primo servizio di credenza (29 portate) furono serviti «Capponi grossi salpimentati (conditi) freddi»; nel terzo servizio di cucina (16 portate) «Capponi allessati dentro le carrafe in bagnomaria» e nel quarto e ultimo servizio di carne «Capponi grassi arostiti coperti di fette di pan dorato». Sessant'anni dopo Mattia Giengher, trinciante in Padova, ne Li tre trattati descrive, stagione per stagione, le portate da mettere in tavola suggerendo per l'inverno, tra una dovizia di cibi, i capponi arrosto da servire con «melangole» (arance amare).
Figurarsi quanto sgolosava il popolo affamato di fronte a tanto bendidìo. Non per niente nell'iconografia del favoloso e vagheggiato Paese di chucagna stampata a Bassano del Grappa dai Remondini c'è una tavola con cinque commensali che guardano piovere volatili dal cielo. Da acquolina in bocca la didascalia: «Qui stando a tavola piove caponi e pernice e ogni sorta di salsicine». Simbolo di tanta abbondanza è stato per secoli l'albero della cuccagna, arrampicata con premi in voga fino al primo dopoguerra. Tra i cibi appesi nella ruota in alto, c'erano salami, salsicce, polli, stecche di baccalà e gli ambitissimi capponi.