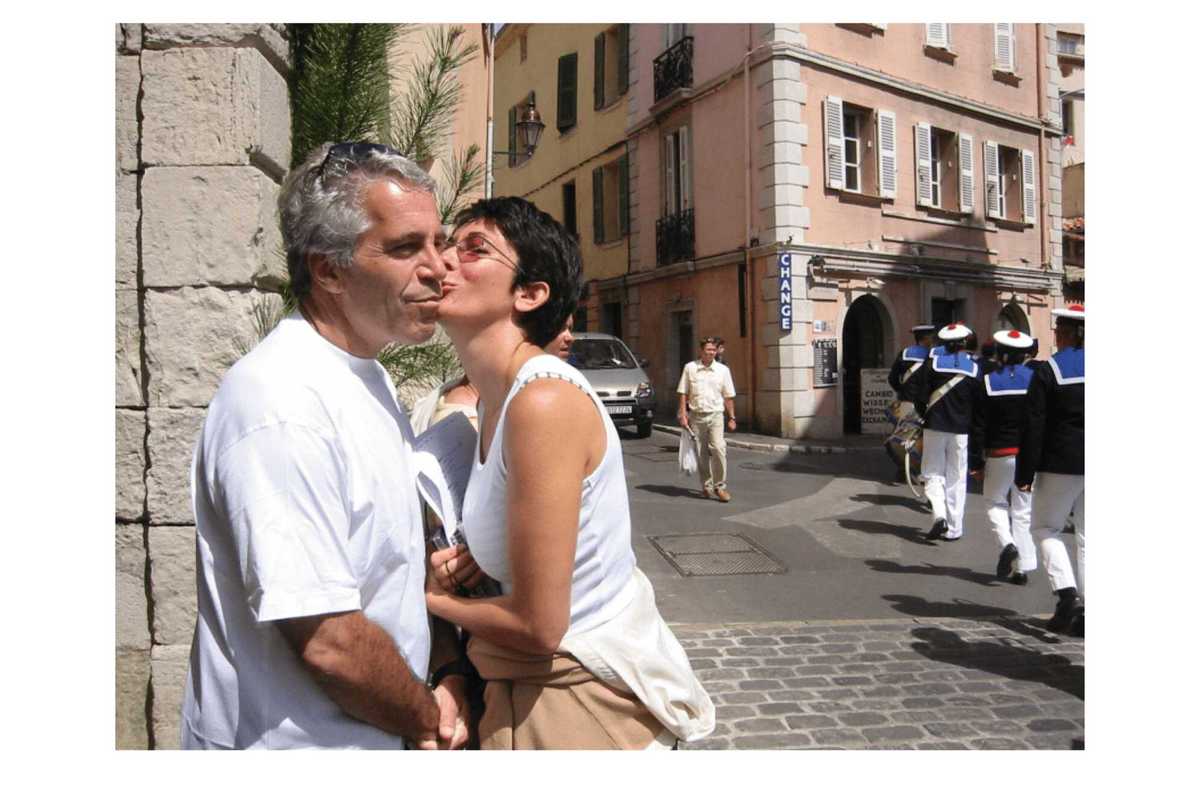- Quelli che hanno dominato la scena dopo il Concilio vanno in pensione. E le nuove leve non sono per nulla attratte dalle sirene progressiste, come mostrano molte ricerche negli Usa e in Europa.
- Il sociologo Leonardo Allodi: «Una fase di degrado morale come questa si accompagna sempre a una riscoperta del senso del sacro».
Lo speciale contiene due articoli
Giovani con tendenze omosessuali ammessi in seminario sì o no? Nelle ultime due settimane, dopo l’uscita sulla «frociaggine» (o «froceria» dato che le fonti divergono, ha osservato il vaticanista del Foglio, Matteo Matzuzzi) di papa Francesco, questo dilemma ha riacquistato attualità, e ci si è un po’ tutti dimenticati di due cose. La prima è che le norme in materia sono e restano chiarissime e difficilmente le cambierà il pontefice argentino che peraltro, dialogando coi vescovi italiani, già nel 2018 si era espresso chiaramente sui ragazzi omosessuali interessati al seminario: «Nel dubbio, meglio che non entrino». Ma soprattutto, ecco il punto, ciò di cui si sta parlando rischia di essere un falso problema, dato che, se da una parte certamente esiste una quota omosessuale nel clero, dall’altra essa pare contenuta e, soprattutto, destinata ad assottigliarsi nel clero giovane di oggi e di domani, che peraltro tutto si candida ad essere fuorché progressista.
Si prenda l’Africa, dove già oggi vive il 20% dei cattolici e dove tra non molti anni, alla luce delle tendenze demografiche, vivrà un cattolico su tre: da quelle parti la pratica omosessuale – come mostra pure la ferma reazione dei vescovi a Fiducia Supplicans, il documento sulle benedizioni delle coppie gay – non è esattamente ben vista; ed è dura possa esserlo in futuro, visti anche quali sono i riferimenti della Chiesa africana. Come per esempio ha scritto il mese scorso su Civiltà Cattolica Paul Béré, gesuita del Burkina Faso, «il primo dei martiri dell’Uganda, Joseph Mukasa, maggiordomo e uomo stimato dalla comunità cristiana» - proclamato santo da papa Montini nel 1964 - «ha mostrato l’eroismo della sua fede» proprio «resistendo alle pratiche omosessuali del re Mwanga». Significativo e da tenere a mente, anche perché l’Africa, a differenza dell’Occidente, di seminaristi e giovani preti ne ha parecchi.
Tuttavia, anche in Occidente il clero sta vivendo una silenziosa quanto netta metamorfosi che lo distanzia dal progressismo, e questo anche al di là, attenzione, di quanto non sia già oggi riscontrabile nel collegio cardinalizio. Il caso più documentato è quello degli Stati Uniti. Era il febbraio del 1994 quando il giornalista Larry B. Stammer, sulle colonne del Los Angeles Times, sottolineava come «scoperta più grande l’ortodossia da parte dei nuovi e più giovani sacerdoti, più conservatori dei preti di mezza età che furono ordinati e maturarono il sacerdozio negli anni Sessanta ai tempi del Concilio Vaticano II». Parole che hanno poi trovato conferma in un lavoro di Paul J. Levesque e Stephen M. Siptroth uscito nel 2005 sulla rivista Sociology of Religion.
Più recentemente, il 1° maggio scorso, l’Associated Press ha pubblicato un lungo servizio di Tim Sullivan e Jessie Wardarski in cui si legge che «i preti progressisti che hanno dominato la Chiesa statunitense negli anni successivi al Concilio Vaticano II», di fatto, «ora hanno tra i 70 e gli 80 anni. Molti sono in pensione. Alcuni sono morti. I preti più giovani sono molto più conservatori». «Stanno solo aspettando di seppellirci», ha commentato con amarezza un prete di 72 anni sentito nell’inchiesta, che poggia su basi robuste.
A fine 2023, infatti, sei ricercatori – Brandon Vaidyanathan, Christopher Jacobi, Chelsea Rae Kelly, Tricia C. Bruce, Stephen White e Sara Perla – hanno reso noto, per la Catholic University of America, quello che è lo studio più vasto degli ultimi 50 anni condotto sui preti cattolici: ne sono stati interpellati 10.000. Un lavoro che ha fotografato il clero americano da prima degli anni Sessanta ad oggi riscontrando da una parte come il conservatorismo dei sacerdoti sia molto accentuato e, dall’altra, come viceversa il vento progressista si sia bruscamente arrestato. Tanto che oggi l’85% dei giovani preti si definisce «conservatore» e, tra gli ordinati dopo il 2020, non uno si dice «molto progressista». Neppure uno: è eloquente.
In questo quadro negli Usa, secondo le analisi del sacerdote e sociologo Donald Sullins, anche la percentuale di sacerdoti omosessuali – che aveva toccato l’apice, il 23%, negli anni di ordinazione 1971-1980 - si è molto ridotta, risultando ora inferiore al 5%. Sono dati che tracciano con fedeltà ascesa e declino del fenomeno che anche papa Benedetto XVI ha denunciato nel suo libro postumo, Che cos’è il cristianesimo (Mondadori); negli anni Sessanta, ha scritto Ratzinger, «si formarono club omosessuali che agivano più o meno apertamente e che chiaramente trasformarono il clima nei seminari». Quei «club» oggi non sono scomparsi, anzi è plausibile siano ben radicati tra i religiosi più maturi - e quindi gerarchicamente meglio inseriti -, ma sono inevitabilmente destinati indebolirsi con le nuove generazioni di preti, assai meno inclini delle precedenti a scender a patti con la morale mondana.
Certo, si potrebbe ribattere che il vento conservatore sarà pure un fenomeno nel clero africano ed americano, ma non europeo. In realtà non è così. Anche nel Vecchio Continente, flagellato dal vento della secolarizzazione, qualcosa sta cambiando. Se n’è accorto, in Francia, il quotidiano La Croix, che il dicembre scorso ha diffuso «Qui sont les prêtres de demain?» («Chi sono i preti di domani?»), un’inchiesta esclusiva realizzata sondando 600 seminaristi (su 673 censiti dalla Conferenza episcopale d’Oltralpe) riunitisi a Parigi. Ebbene, la sorpresa non deve essere stata piccola nel registrare come quasi un seminarista su due (il 47%) frequenti regolarmente o occasionalmente una parrocchia o comunità tradizionalista e più di uno su tre (il 34%) non abbia nulla contro la messa tradizionale invisa a tanti vescovi. Beninteso: sarebbe sbagliato pensare questi seminaristi scismatici, dato che meno di uno su cinque fra costoro (17%) dichiara poca simpatia verso papa Francesco; semplicemente, ha rilevato il giornalista di La Croix Arnaud Bevilacqua, sono aspiranti sacerdoti che «dimostrano un fortissimo attaccamento alla Chiesa e alla dottrina».
Non è finita. Perfino nella Germania dove il vento progressista soffia ancora impetuoso nelle gerarchie ecclesiastiche, oggi, c’è qualche sorpresa. Un recentissimo studio tedesco reso noto a maggio e realizzato sondando gli 847 sacerdoti ordinati dal 2010 al 2021, infatti, ha rilevato come i temi così cari all’agenda sinodale teutonica – quali, ad esempio, l’ammissione all’ordinazione delle donne e la maggiore partecipazione dei laici alle scelte ecclesiastiche – trovino un consenso limitato, che arriva al massimo al 36%, mentre ben di più (il 76%) risultano quanti ritengono prioritario prestare attenzione ai contenuti religiosi e a come trasmetterli. La maggior parte di questi sacerdoti, ha commentano non senza delusione Matthias Sellmann, il teologo responsabile dello studio, «sembra non avere familiarità con gli ambienti e i valori della società moderna».
Sarà. Sta di fatto che anche in Italia il sacerdote di una volta, per così dire, è un modello che resta attrattivo. In una ricerca di qualche anno compiuta in uno Istituto di scienze religiose, alla domanda «Le piacerebbe avere in parrocchia un prete come don Camillo?», ha risposto il 90%. Una maggioranza schiacciante che, sommata ai dati internazionali poc’anzi ricordati, prova come silenziosamente la Chiesa stia cambiando pelle, dando in fin dei conti ragione a quanto nel 1990 l’allora cardinal Ratzinger evidenziò intervenendo al Meeting di Rimini: «Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, ma di una Chiesa più divina. Solo allora essa sarà veramente umana».
«La fede che attrae le giovani generazioni è quella più esigente»
Tra i più attenti osservatori delle dinamiche religiose, non solo italiane, c’è da tempo Leonardo Allodi, professore associato di Sociologia dei processi culturali all’Università di Bologna, autore e curatore di numerosi volumi, tra cui il recentissimo Sociologia comparata delle civiltà (Rubbettino, 2024). La Verità l’ha contattato per capire meglio le dinamiche di cambiamento che attraversano oggi la Chiesa.
Professore, negli Stati Uniti, ma anche in Francia e Germania, secondo diverse ricerche i sacerdoti risultano conservatori, spesso più del passato. La sorprende?
«I risultati di queste recenti indagini sociologiche non mi sorprendono affatto. È confermato da tempo, anche empiricamente, come laddove il credere si fa più esigente ha successo ed è attrattivo, come accade ad esempio negli Ordini contemplativi. Ora anche molti sacerdoti e parroci “secolari” si rendono contro di questo: laddove la fede viene semplificata e resa meno esigente attrae sempre meno, lascia insoddisfatta l’esigenza religiosa delle persone. In questo senso l’antropologia dell’homo religiosus, la sua nostalgia per l’Assoluto e il Totalmente Altro, non muterà mai. E, come dice uno dei massimi pensatori cattolici del nostro tempo, Robert Spaemann, le cose ultime, il perché e il da dove dell’uomo non potranno mai essere illuminate da alcun illuminismo. Sempre più si comprende come la religione apra uno spazio al pensiero e alla vita, in grado di trascendere la morte. Chi ormai oggi offre questo, se non una fede autentica, una devozione vera, una vita fecondata dai sacramenti? I sacerdoti sono i primi ad esserne consapevoli».
Come si spiega questo processo?
«Questa esigenza, questo bisogno naturale e spontaneo di consolidamento di una fides ortodoxa, di ritorno ad un ethos e ad una sensibilità tradizionali, al cui centro vi sia senso della devozione e senso dell’adorazione del Mistero di Dio, si inscrive in un processo più ampio che il grande sociologo Pitirim A. Sorokin - “cristiano, anarchico e conservatore”, si definiva -, di origini russe e professore ad Harvard, ha preconizzato fin dagli anni Sessanta del secolo scorso. Nell’opera La rivoluzione sessuale americana (Cantagalli, 2021), parla di una legge della polarizzazione, secondo cui quando una società sperimenta un crescente degrado morale, una volta raggiunta la sua fase sensistico-cinica, la massa dei suoi membri, che in una situazione normale non sono né troppo santi né troppo peccatori, tende a dividersi e a polarizzarsi, alcuni diventano più religiosi, più morali e santi, mentre altri più irreligiosi, cinici, sensuali e criminali. In questo modo, dice Sorokin, la maggioranza eticamente mediocre dei tempi normali si muove verso i poli opposti di nobilitazione e degradazione religiosa e morale. Siamo entrati in un’epoca di polarizzazione positiva e negativa. E questo non risparmierà neppure, al proprio interno, la Chiesa stessa. Se si saprà edificare una tale “polarizzazione positiva”, le speranze di una rinascita diventeranno realtà».
È realistico pensare che questa metamorfosi del clero, per così dire, che si osserva negli Usa si possa verificare anche altrove, nel mondo occidentale?
«In un’intervista in uscita sul prossimo numero del mensile Il Timone, Martin Mosebach osserva come la situazione culturale - o non culturale - contemporanea riveli sempre più, in tutte le sue forme di manifestazioni, quelli che lui definisce “sintomi ippocratici”. Sempre più uomini sensibili comprendono come la situazione di degradazione nella quale il continente europeo risulta immerso da tempo nella forma più estrema, “non sia più associata alla speranza e che la sua incontestabile forza sia soprattutto distruttiva”. Per tale ragione, sempre più e diffusamente, si cerca una via d’uscita da una civilizzazione “che agisce in modo soffocante sull’umanità”, avvertendo con gratitudine “che il culto tradizionale rappresenta un contro-mondo, risparmiato dal soffio pestilenziale del nostro tempo”».
Anche nell’Europa scristianizzata, ci sono fenomeni in controtendenza: in Francia il pellegrinaggio di Chartres quest’anno ha raccolto 18.000 pellegrini: +12% rispetto all’anno scorso. Perché iniziative così continuano ad affascinare?
«La devozione popolare ha sempre preservato manifestazioni che rendono sperimentabile la fede. Le processioni, i pellegrinaggi, il contatto con immagini sacre, sono tutti espressioni di una devozione popolare autentica che rinasce e si risveglia di continuo, a dispetto del cinismo e del sarcasmo con cui si è pensato di poterle abolire o ridicolizzare. Tale risveglio, già evidente ad esempio nel nostro Paese - penso alla crescente “riscoperta” e diffusione dell’adorazione eucaristica nelle parrocchie -, è un segno di quel processo in atto di polarizzazione positiva a cui accennavo prima».
In Occidente la religione ha però indubbiamente perso rilevanza sociale. Tuttavia, in questi stessi decenni anche il futuro demografico occidentale pare incerto. Forse, assieme alla fede, se ne sta andando anche la speranza?
«L’affievolimento della fede, soprattutto in Europa, è del tutto evidente e innegabile. Perché è accaduto? La risposta del già citato Spaemann, è: “Secondo Wittgenstein una ruota che non gira non fa parte della macchina. Nel mondo moderno, la macchina gira senza che la ruota religiosa sia inserita, senza che essa giri”. Come aveva ben compreso Romano Guardini, la slealtà moderna consiste nel volere frutti cristiani facendo a meno del cristianesimo. La fede può quindi eclissarsi, ma non scomparire. Essa rimane una esigenza insopprimibile di ogni uomo e di ogni società».