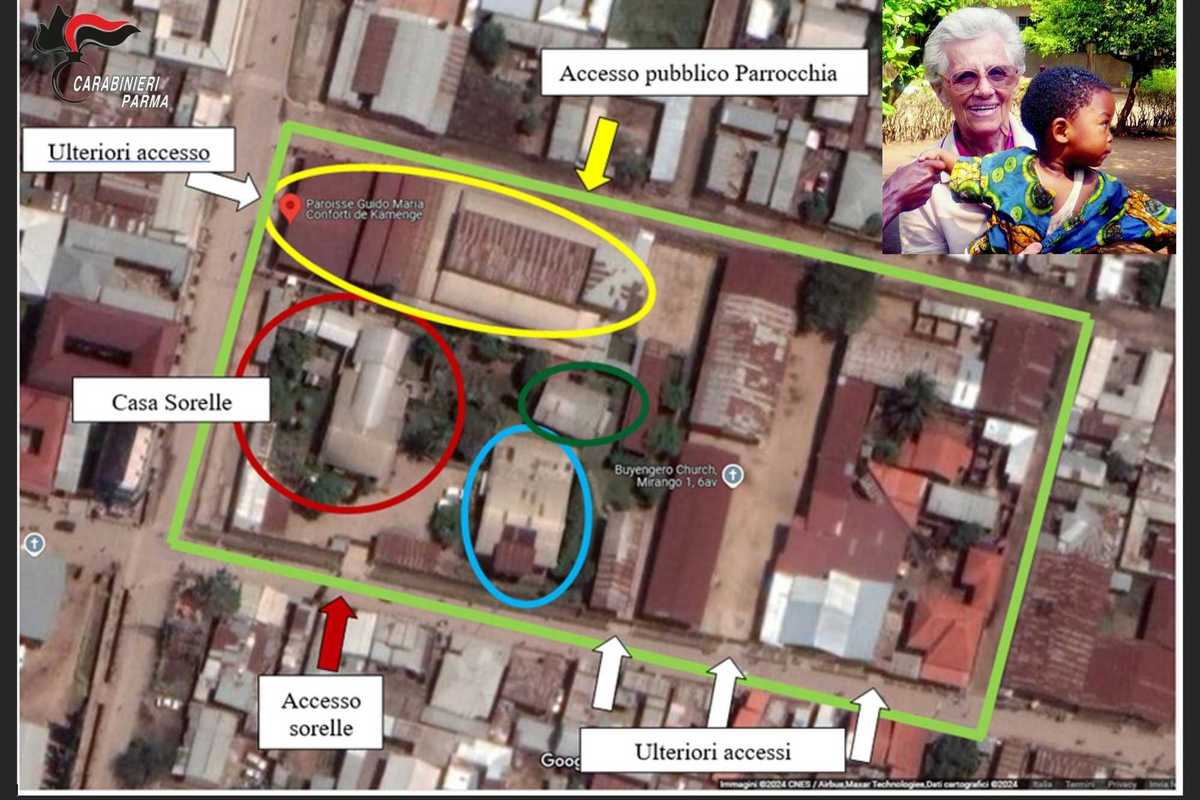Oggi si parla molto del «ritiro sociale» degli adolescenti. Moltissimi di loro non partecipano in alcun modo alla società, se non per affermare la loro estraneità, indifferenza o avversione, come le bande di minorenni che imperversano a Venezia e nel mestrino. «Ritirati socialmente», infatti non sono solo i milioni di hikikomori giapponesi, seguiti a ruota da quelli dell'Italia, seconda al mondo nel fenomeno dei ragazzi autoreclusi nella propria cameretta, dalla quale comunicano col mondo esclusivamente via Internet. Le forme del ritiro sono moltissime, e spesso molto più drammatiche, a volte estreme.
Pochi giorni fa ad esempio, a poche ore una dall'altra, due ragazzine si sono ritirate dalla vita. Evaelle, undicenne di Herblay, Francia, straordinariamente sensibile e per questo accusata da una professoressa di essere «pazza» ed emarginata da molti compagni, si è impiccata al letto nella sua camera. Jessica, 18 anni, di Meldreth (un paese vicino a Cambridge), si è gettata sotto un treno dopo essere stata distrutta fisicamente e psichicamente da una cura a base di triptorelina e psicofarmaci per farla diventare maschio (come La Verità ha raccontato nell'edizione del 3 luglio).
L'esperienza di chi scrive è che molti ragazzi si «ritirano», in modi più o meno drammatici, perché hanno l'impressione che la società attorno (quella industriale avanzata), non abbia alcuna vera proposta per loro se non quella dei padri «alla giapponese» (molti anche italiani) che tornano a casa la sera tardi schiantati dal lavoro e i figli non li vedono mai. Come racconta ad esempio Il ritiro sociale degli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa a cura di Matteo Lancini (Raffaello Cortina editore). È un fenomeno la cui origini sono politiche e storiche prima che psicologiche. Le reazioni psichiche ne sono la conseguenza. Il fatto è che (l'essere umano l'ha sempre saputo) ogni società per vivere e continuare deve dare degli obiettivi ai suoi figli. Questi non possono essere soltanto materiali e individuali, ma anche trascendenti e collettivi. A cominciare dal poter identificarsi con l'immagine della patria. Che non è un'astrazione, ma la realtà molto concreta di un territorio, un popolo, una cultura e una storia con cui identificarsi. Un oggetto d'amore condiviso nei secoli con chi ti ha preceduto. Non è niente di astratto: è più frequente il suicidio in chi non sa cosa amare rispetto a chi perde i soldi.
Il mito corrente è che denaro e successo siano tutto; ma la maggior parte di noi, soprattutto da piccoli, sente il forte bisogno che gli si parli e gli si proponga altro: l'amore, la cura e la difesa dello spazio attorno, la terra, la giustizia, la verità. Questo è ciò che emoziona e muove le energie profonde. È su quei temi forti che poggia l'educazione, se c'è. Il resto sono suggerimenti per tirare a campare, fino a quando la prossima rivoluzione tecnologica cambierà le carte in tavola; ma il gioco è scoperto, e la prospettiva entusiasma pochi. Solo sui terreni più elevati si gioca l'educazione personale, la partecipazione attiva alla società, e buona parte dello sviluppo della personalità. È vero che quei valori sono diventati «strani» dopo due secoli in cui sono stati sostituiti dai soldi, l'immagine e la tecnica, ma è anche vero che la società occidentale ha perso con questa scelta ogni suo primato e non sa più da dove ripartire.
È attraverso i suoi simboli che ogni società costruisce l'identità e la forza dei suoi cittadini; senza i valori unificanti da essi illustrati i gruppi e gli individui restano divisi, sparsi e rancorosi, nella situazione caotica delle società ancora in formazione, o in disfacimento, come ricordano il politologo Lucien Sfez (La symbolique politique, Puf edizioni), lo storico Remi Brague e le scienze politiche e sociali. Le attuali democrazie occidentali sono le sole società (tranne quelle del comunismo reale) dove si è rimosso e dimenticato il sistema simbolico della memoria storica, con la devozione agli eroi nazionali e ai miti fondatori, per sostituirlo con dei fai da te vuoti di senso e destinati al giorno per giorno. Ciò non basta per impegnarsi nella battaglia della vita e i giovani si ritirano. O se ne vanno: più spesso in Inghilterra che con la Brexit ha detto no proprio a questa scelta omologante e nichilista, in nome della fedeltà alla propria identità, passato e prospettive future (tra la supponente derisione dei commentatori europei). Come notava ancora il politologo Sfez, la società europea contemporanea «ammalata per aver rotto con i suoi valori fondatori non si riconosce più... l'identità nazionale, la proprietà, la famiglia, l'avvenire, tutto è incerto e confuso». La struttura sociale si indebolisce e i contemporanei finiscono ad assomigliare agli uomini primitivi: inermi e minacciati. Lo scenario dell'Europa contemporanea comincia ad assomigliare a quello della Cambogia comunista che «cancella i nomi, i quartieri, e dove si deportano interi popoli».
La narrazione identitaria di un Paese non è una merendina di buoni sentimenti ma un'immagine rappresentativa della realtà e della storia, per motivare l'impegno nel futuro. Senza sentimentalismi interessati. Come scrive Bruno Bettelheim, lo psicoanalista delle saghe e leggende per i giovani: «Il racconto deve essere duro, crudele, per fare riconoscere il bene e il male e contrapporli l'uno all'altro affinché il bambino riconosca la propria identità fra questi opposti, e quindi venire motivato». In Italia e Europa oggi invece (la vicenda della capitana Carola è esemplare), le contraddizioni vengono annegate in una bontà di parata e leggi e doveri calpestate a favore della retorica dei diritti, che dissolve di ogni costruzione sociale. Anche se è scomodo, però, (come notava già Max Weber) è sempre l'identificazione di un «altro», esterno alla società e alla nazione, che la compatta e le consente di riconoscersi e di proiettarsi nel futuro. È indispensabile riconoscere chi sono «gli altri» per capire chi siamo noi. Il cosmopolitismo può avere un senso dialogico, ma non costruisce nessuna struttura vivente, né comunità né nazioni.
La globalizzazione cosmopolita non può riconoscere le diversità, tracciare confini, sviluppare identità forti perché ciò metterebbe in crisi il suo relativismo, la sua indifferenza morale, la sua passione per il denaro e il potere fine a sé stesso. Anche per questo non si studia più la storia che proprio sul riconoscimento delle diversità e delle vocazioni ha costruito le civiltà e le personalità dei cittadini che vi partecipano. Ma come ha scritto Giacomo Leopardi (e ricita Giulio Tremonti): «Quando tutto il mondo è patria non c'è più patria». Senza patria però, senza il padre, la sua terra, la sua legge e la sua difesa, non c'è più società e non si può che «ritirarsi». Almeno così pensano molti giovani, che non riescono a fare altro. Finché altri giovani, forse, cambieranno la situazione e ci mostreranno il ritorno di nuovi padri, patria, storia e confini.