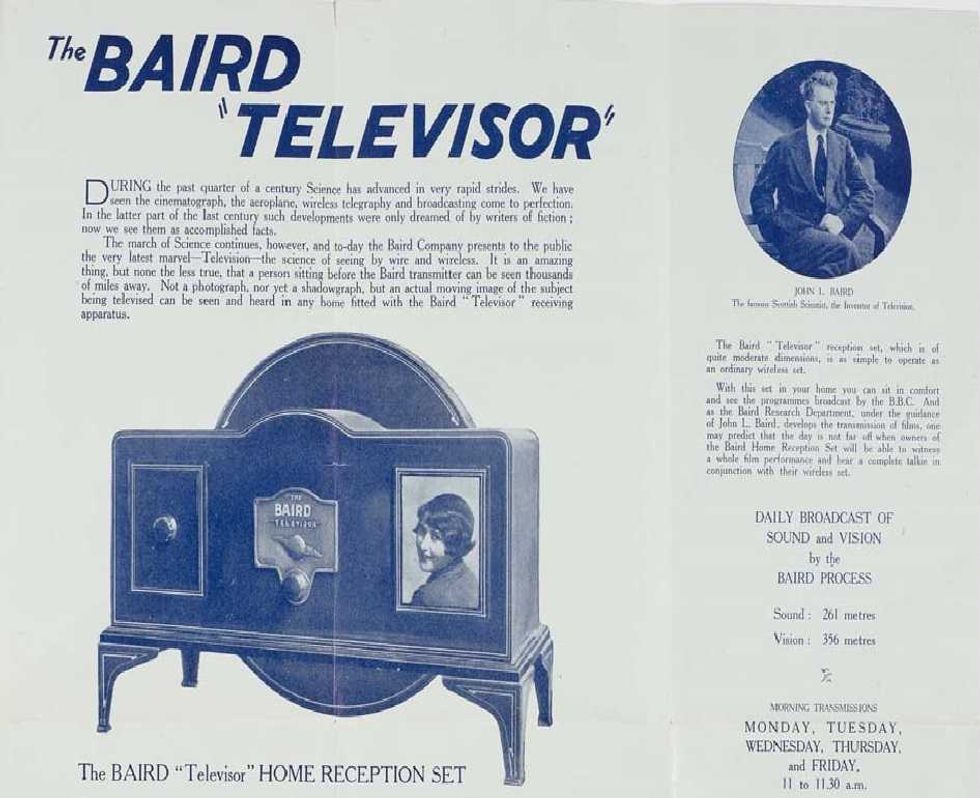I camerati oramai non ci sono più. La sinistra è costretta a inventarseli

Il fascismo come ossessione. No, non dei cosiddetti nostalgici fanatici, che nel Paese sono minoranza, per quanto «rumorosa». Ma degli altri, i democraticiantifascisti - una sola parola, mi raccomando - in servizio permanente effettivo, quelli per cui il 25 aprile (giorno in cui i camerati, pateticamente, si vestono a lutto) dura tutto l'anno, perché il fascismo è «eterno», come da pamphlet di Umberto Eco, e i barbari, si sa, sono sempre alle porte. Sentimento diffuso a sinistra, con qualche eccezione: «Parlo da uomo cresciuto nel culto dei valori della Resistenza: proprio per questo dico che agitare lo spettro del fascismo dilagante come espediente per ottenere legittimazione politica è un alibi per una sinistra che vuole scansare la fatica del governo». Parola di Carlo Calenda, che di destra certo non è, ma è stato accusato - anche lui - di essere in odore di fascismo. Da chi? Dalla sinistra tendenza Capalbio, amena località in cui può capitare che ex sindacalisti della Cgil diventino proprietari terrieri e girino così tanti soldi che uno se li ritrova pure nelle cucce dei cani, naturalmente «a sua insaputa». E perché quella lettera scarlatta, anzi nera? Perché il leghista Giancarlo Giorgetti, con un singolare endorsement, lo aveva gratificato di un complimento: «Al netto delle esuberanze, mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come Roma». Esuberanze che si sono riproposte ieri, quando Calenda si è accapigliato su Twitter con Guido Crosetto cui ha chiesto - dopo avergli rinfacciato il «buonismo acchiappa tweet» - di dimostrarsi intransigente con l'«accozzaglia di incompetenti e criptofascisti di Fratelli d'Italia» (al che, fossi stato Crosetto, gli avrei simpaticamente replicato: «Carlo, deciditi: o sono buonista o sono fascista»).
Se non altro, Calenda nei confronti del candidato della destra romana Enrico Michetti, che se la vedrà con Roberto Gualtieri del Pd nella sfida finale per il Campidoglio, non ha mai usato il termine «neofascista», dichiarando anzi di non considerarlo neppure tale (e meno male). Espressione su cui invece è inciampata - intenzionalmente ma rovinosamente - Lilli Gruber, quando riferendosi a Michetti nel suo programma tv su La7, lo ha scomunicato, dal sacro soglio del giornalismo «de sinistra» - tendenza questa volta Bilderberg - offrendone il seguente ritratto: «Viene da un mondo dalla destra destra destra, forse anche un po' neofascista». Un po'. Forse. Al che Michetti, lamentando l'attacco «vergognoso, sono state dette cose infondate e false», ha avuto buon gioco nel replicare, annunciando querela: «Sono nato in oratorio, sono stato nell'Azione cattolica, ho militato nella Democrazia cristiana». Ma intanto Michetti era stato «mascariato»: la sua estrazione sarebbe «forse anche un po' neofascista», e tanto basta. E uso il termine siciliano «mascariare» - sporcare l'avversario con uno schizzo di fango per delegittimarlo - ripensando a quanto scritto da Leonardo Sciascia in Nero su Nero, un suo libello del 1979: «Il più bello esemplare di fascista in cui ci si possa oggi imbattere è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dar del fascista a chi fascista non è». E dire che, a un certo punto, nel mio piccolo avevo considerato la questione archiviata quando l'ex-Pci Luciano Violante, nel suo discorso d'investitura come presidente della Camera nel maggio 1996, a 51 anni dalla caduta del fascismo, aveva osato l'inosabile: parlare di pacificazione nazionale per chiudere definitivamente quel doloroso passaggio della nostra storia («senza revisionismi falsificanti...e l'inaccettabile parificazione tra le parti»), «sforzandosi di capire i motivi per i quali migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e delle libertà». Esternazione che gli procurò l'applauso financo dalle fila di Alleanza nazionale, ma che gli costerà lo sdegno dei comunisti, vecchi o post, ma sempre duri e puri. Sono passati 25 anni da quel discorso. Invano, visto che il pedigree antifascista è ancora richiesto, e questo nonostante sia anche arrivato il libro di Antonio Padellaro, tra i fondatori del Fatto quotidiano, a far luce su una strana «relazione pericolosa»: Il gesto di Almirante e Berlinguer. Libro che parte dal 1984, quando il segretario del Msi, «fucilatore di partigiani», andò a Botteghe Oscure a rendere omaggio alla salma del segretario del Pci: «Sono venuto a rendere omaggio a un uomo da cui mi ha diviso tutto ma che ho sempre apprezzato e stimato». Avrebbe anche potuto aggiungere «e con cui m'incontravo in segreto per parlare di politica, soprattutto negli anni di piombo», come il libro ricostruisce. Padellaro in apertura cita l'Iliade: «La grazia suprema delle guerre, è l'amicizia che sorge nei cuori di nemici mortali», e riprende il concetto in chiusura, con una duplice esortazione: prevalga «al posto dell'odio, il rispetto»; e si dedichi in qualche città ai due avversari, udite udite la bestemmia!, «Piazza Almirante e Berlinguer». Perché c'è sempre bisogno di gesti di riconciliazione. Uno dei quali, se si vuole, è anche quello che si è consumato nel settembre 2019 in occasione di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, dove il libro citato è stato presentato con un confronto tra Massimo Magliaro, storico portavoce di Almirante, Bianca Berlinguer, Ignazio La Russa e Walter Veltroni.
Ps. Giorgia Meloni, la «ducetta» a cui si richiede un'abiura quotidiana e continua, rinfacciandole supposte reticenze e omertà per non aver mai preso esplicitamente le distanze dal ventennio, tanto da usare subdolamente la parola «patrioti» che starebbe per «fascisti», ha dichiarato: «Mussolini ha fatto diversi errori, le leggi razziali, l'ingresso in guerra, e comunque il suo era un sistema autoritario. Storicamente ha anche prodotto tanto, ma questo non lo salva... Ci sono principi che valgono di più. La libertà, i diritti civili valgono di più della bonifica delle paludi pontine, tanto per intenderci».
L'ha detto nel 2006 a Sette, il supplemento del Corriere della Sera.
Dubito abbia cambiato idea in questi 15 anni.
Lei è andata avanti.
Non di tutti i suoi avversari si può dire altrettanto.