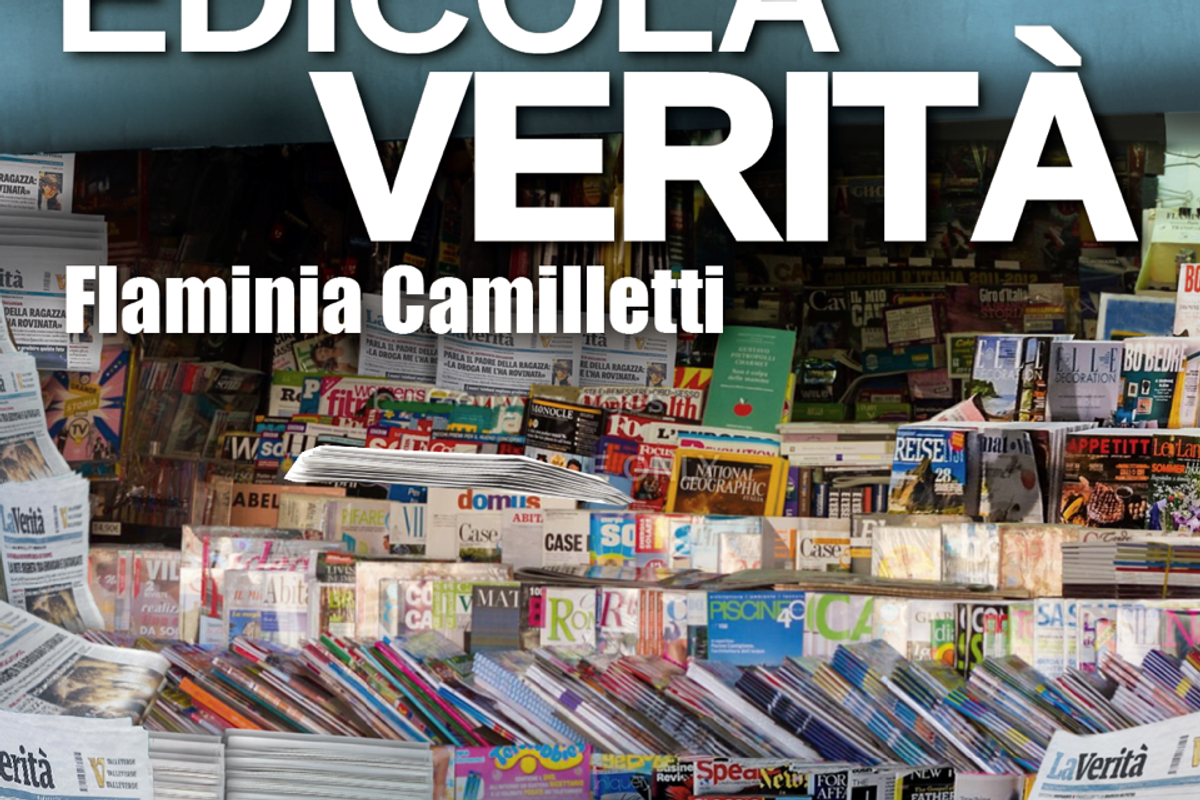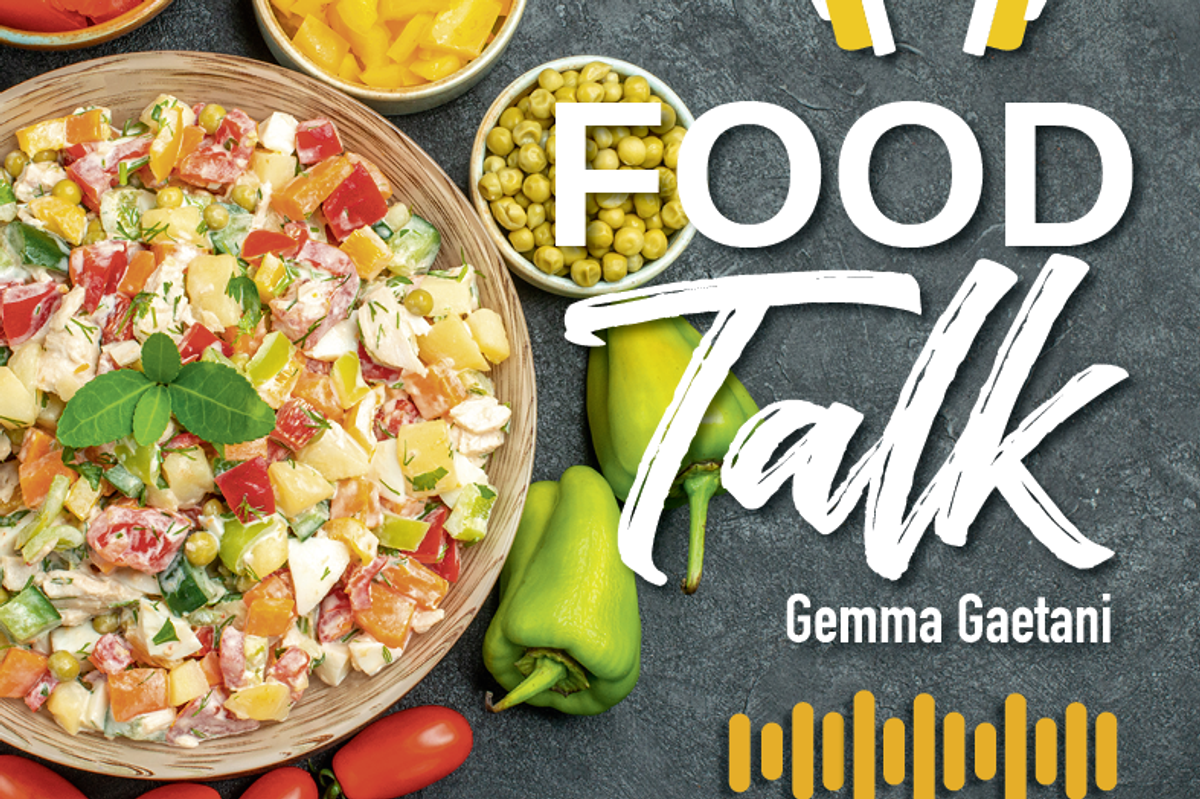True
2024-06-03
La guerra ha aumentato il rischio di fughe radioattive nell’Artico
Le tragiche conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina avranno ripercussioni che si protrarranno per molte generazioni, lasciando un segno indelebile sul Paese. Ma oltre ai campi di battaglia, nel remoto nord-ovest della Russia, si profilano minacce radioattive che rimangono parzialmente contrastate e largamente ignorate. L’Artico russo è destinato a diventare uno dei luoghi più contaminati del pianeta, con vecchie basi dei sottomarini nucleari sovietici, cantieri di manutenzione a terra, reattori dismessi, rifiuti radioattivi e, in alcuni casi, interi sottomarini nucleari deliberatamente affondati in mare. Tuttavia, questa non era la destinazione prevista per la regione.
Dopo il crollo dell’Urss, un consorzio di governi occidentali si era impegnato a contribuire alla decontaminazione dei resti della flotta di sottomarini nucleari sovietici, un tempo temuta. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo, sono stati smantellati in sicurezza 198 sottomarini arrugginiti e abbandonati, ancora carichi di combustibile a base di uranio esaurito, attraverso accordi di finanziamento bilaterali e scambi scientifici con i Paesi europei. Tuttavia, con l’entrata dei carri armati russi in Ucraina nel febbraio 2022, tale cooperazione è cessata. Nonostante le assicurazioni del Cremlino che sarebbe stato in grado di proseguire autonomamente la pulizia nucleare, la leadership di Mosca durante il conflitto ha mostrato di avere scarsa volontà, o scarse risorse finanziarie, per portare a termine il lavoro. La situazione nella baia di Andreyeva, un’ex area di manutenzione dei sottomarini situata a nord-ovest di Murmansk, nei pressi del confine norvegese, è estremamente allarmante. Nel corso degli anni, il sito è diventato una sorta di deposito per circa 22.000 gruppi di combustibile nucleare esausto provenienti da oltre 100 sottomarini.
Molti di questi materiali sono stati conservati in contenitori arrugginiti all’aria aperta, con evidenti rischi per la sicurezza e l’ambiente. Le gravi carenze nella gestione dei materiali nucleari nella baia di Andreyeva sono emerse nel 1982, quando si verificò una fuga di 600.000 tonnellate di acqua contaminata nel Mare di Barents.
Dopo anni di pressioni da parte di Bellona Environmental Foundation, nel 2017 è iniziata la pulizia della baia di Andreyeva. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, rimangono ancora numerose barre di combustibile danneggiate nel sito, conservate in edifici contaminati che richiedono anch’essi smantellamento e smaltimento. Inizialmente, il progetto, per il quale la sola Norvegia ha investito circa 30 milioni di euro (32,6 milioni di dollari), doveva essere completato entro il 2028. Tuttavia, a causa dell’inizio della guerra, Mosca ha posticipato la scadenza agli anni 2030, senza fornire prove dei progressi compiuti.
Al di sotto della superficie oceanica, altre minacce attendono di essere affrontate. Il più recente piano di sviluppo dell’Artico di Mosca ha delineato gli sforzi per rimuovere una serie di rifiuti nucleari affondati dai sovietici nei mari di Barents e Kara, inclusi i sottomarini nucleari K-27 e K-159, entro il 2035. Questi sottomarini rappresentano una delle sfide più impegnative per l’operazione di pulizia, contenendo complessivamente un milione di curie di radiazioni, pari a circa un quarto di quelle rilasciate nel primo mese del disastro di Fukushima. Il K-27, varato nel 1962, subì una perdita di radiazioni in uno dei suoi reattori sperimentali raffreddati a metallo liquido dopo soli tre giorni in mare. Nonostante i tentativi della Marina sovietica di riparare o sostituire i reattori nei successivi anni, nel 1979 si arresero e decisero di dismettere il sottomarino. A causa del suo livello di radioattività troppo elevato per essere smantellato convenzionalmente, nel 1982 il K-27 fu rimorchiato nel poligono di test nucleari artici di Novaya Zemlya e affondato in uno dei fiordi dell’arcipelago. Affondare il K-27 a una profondità di soli 33 metri ha richiesto uno sforzo considerevole. Il sottomarino è stato pesantemente appesantito con asfalto per sigillare i reattori pieni di carburante, mentre è stato praticato un foro nel serbatoio di zavorra di poppa. Tuttavia, questa soluzione è temporanea. Il sigillante intorno al reattore è progettato per prevenire perdite di radiazioni fino al 2032, ma dopo tale data, il rischio di contaminazione potrebbe aumentare significativamente.
L’altro sottomarino, il K-159, è stato classificato come uno dei sottomarini tossici nel 2003. Situato a nord di Murmansk, proprio nelle vicinanze di alcune delle zone di pesca più ricche del Mare di Barents e delle rotte di navigazione più trafficate, il K-159 è motivo di particolare preoccupazione. Questo gigante arrugginito lungo 305 piedi, già abbandonato da anni, affondò a 240 metri mentre veniva trainato verso un cantiere navale di Murmansk per il suo smantellamento, causando la perdita di nove marinai che erano a bordo per aiutare nel trasporto dell’acqua. A differenza del K-27, per il K-159 non furono adottate misure di sicurezza per proteggere i suoi due reattori prima dell’affondamento, il che significa che è andato giù ancora carico con 800 chilogrammi di combustibile di uranio esaurito. Un eventuale rilascio radioattivo da questo relitto sarebbe devastante non solo per l’industria della pesca norvegese, ma anche per quella russa.
Un progetto per recuperare i sottomarini, con un costo stimato di circa 300 milioni di euro, era stato preso in considerazione dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), insieme alla Norvegia e ad altre nazioni europee, che stavano sviluppando uno studio di fattibilità per questa complessa operazione. Tuttavia, con l’inizio della guerra e il congelamento delle attività della Bers, sono stati fatti pochi progressi da parte di Mosca. Questa situazione lascia l’ambiente dell’Artico russo in uno stato di incertezza, con conseguenze imprevedibili. Se Mosca continuerà a dare la priorità alla guerra anziché all’ambiente, non farà altro che prolungare una minaccia radioattiva che potrebbe essere risolta con il sostegno internazionale. Ciò che è chiaro è che la Russia non può affrontare questa sfida da sola.
«Serve un coordinamento globale»
Lara Ballurio, giornalista e analista esperta di Russia, come si potranno affrontare e mitigare i futuri rischi ambientali considerando l’attuale clima politico?
«L’impatto del nucleare sull’ambiente supera i confini geografici e politici, rendendo cruciale un intervento internazionale coordinato, indipendente dalle tensioni politiche come quelle tra Russia e Ucraina. È importante ripristinare gli accordi pre bellici siglati con il consorzio di Paesi occidentali o sviluppare nuovi trattati per una gestione nucleare sicura e responsabile. Il futuro della rimozione dell’eredità nucleare nell’Artico sarà probabilmente caratterizzato da politiche globali, investimenti in innovazione tecnologica per la decontaminazione radioattiva e la sicurezza nucleare, e collaborazione internazionale sotto rigoroso monitoraggio ambientale. Organizzazioni come l’Agenzia internazionale per l’energia Atomica, impegnata nel controllo della centrale di Zaporoj’e in Ucraina, sono essenziali per coordinare la valutazione dei rischi e la sicurezza dei siti».
Come si bilancia la gestione dell’eredità nucleare con le esigenze contemporanee della presenza militare russa nell’Artico?
«La gestione dell’eredità nucleare russa nell’Artico si svolge parallelamente a un’intensa attività militare per la quale la Russia investe ingenti somme di denaro. Il 24 maggio scorso, Rossijskaja Gazeta ha riportato la notizia che rappresentanti diplomatici e militari di vari Paesi, definiti “amici della Russia”, sono stati invitati dal ministero della Difesa della Federazione Russa a visitare la Flotta del Nord, dove hanno osservato le capacità militari moderne, inclusi la fregata Ammiraglio della flotta Kasatonov e il sottomarino nucleare Orel, equipaggiato con missili da crociera Kalibr. Queste dimostrazioni di forza, sebbene mostrino avanzamenti in termini di armamenti e strategia militare, sollevano questioni circa la capacità e la priorità data alla gestione dell’eredità nucleare più vetusta. Il sottomarino Orel, per esempio, rappresenta una dualità tra l’innovazione armamentistica e la gestione di tecnologie nucleari obsolete, essendo stato aggiornato per trasportare armamenti moderni ma senza chiari riferimenti alla bonifica o alla sicurezza delle vecchie tecnologie nucleari. Questo scenario evidenzia una possibile discrepanza tra la proiezione di potenza militare e l’effettiva gestione delle complesse sfide legate al nucleare ereditato, suggerendo che l’attenzione potrebbe essere prevalentemente focalizzata sul nuovo, trascurando aspetti critici del “vecchio”».
Oltre a Bellona Environmental Foundation, quali sono le organizzazioni che potrebbero giocare un ruolo importante?
«Una, ad esempio, è l’Arctic Council, un forum intergovernativo che promuove cooperazione e protezione ambientale nell’Artico, coinvolgendo anche i popoli indigeni. Segue il programma artico del Wwf, concentrato sulla conservazione naturale e l’impatto dei cambiamenti climatici, con un focus sullo sviluppo sostenibile. Inoltre, Greenpeace è attiva contro il trivellamento petrolifero e la pesca insostenibile, sensibilizzando anche sull’inquinamento da rifiuti nucleari. Anche l’Arctic Institute, un think tank indipendente, si dedica alle questioni di sicurezza, politica ed economia della zona, cercando soluzioni sostenibili alle sfide ambientali. Inoltre, queste organizzazioni, svolgendo ricerca, advocacy, sensibilizzazione e collaborazioni, risultano essenziali per mitigare i rischi ambientali nell’Artico».
Continua a leggereRiduci
La zona è una delle più inquinate e pericolose del pianeta. Fino al conflitto in Ucraina, Russia e Occidente collaboravano alla decontaminazione dei vecchi sottomarini nucleari sovietici. Ora le priorità sono cambiate.L’esperta Lara Ballurio: «È importante ripristinare gli accordi pre bellici oppure sviluppare nuovi trattati. Ci vogliono investimenti in tecnologia e nel monitoraggio ambientale».Lo speciale contiene due articoli.Le tragiche conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina avranno ripercussioni che si protrarranno per molte generazioni, lasciando un segno indelebile sul Paese. Ma oltre ai campi di battaglia, nel remoto nord-ovest della Russia, si profilano minacce radioattive che rimangono parzialmente contrastate e largamente ignorate. L’Artico russo è destinato a diventare uno dei luoghi più contaminati del pianeta, con vecchie basi dei sottomarini nucleari sovietici, cantieri di manutenzione a terra, reattori dismessi, rifiuti radioattivi e, in alcuni casi, interi sottomarini nucleari deliberatamente affondati in mare. Tuttavia, questa non era la destinazione prevista per la regione. Dopo il crollo dell’Urss, un consorzio di governi occidentali si era impegnato a contribuire alla decontaminazione dei resti della flotta di sottomarini nucleari sovietici, un tempo temuta. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo, sono stati smantellati in sicurezza 198 sottomarini arrugginiti e abbandonati, ancora carichi di combustibile a base di uranio esaurito, attraverso accordi di finanziamento bilaterali e scambi scientifici con i Paesi europei. Tuttavia, con l’entrata dei carri armati russi in Ucraina nel febbraio 2022, tale cooperazione è cessata. Nonostante le assicurazioni del Cremlino che sarebbe stato in grado di proseguire autonomamente la pulizia nucleare, la leadership di Mosca durante il conflitto ha mostrato di avere scarsa volontà, o scarse risorse finanziarie, per portare a termine il lavoro. La situazione nella baia di Andreyeva, un’ex area di manutenzione dei sottomarini situata a nord-ovest di Murmansk, nei pressi del confine norvegese, è estremamente allarmante. Nel corso degli anni, il sito è diventato una sorta di deposito per circa 22.000 gruppi di combustibile nucleare esausto provenienti da oltre 100 sottomarini. Molti di questi materiali sono stati conservati in contenitori arrugginiti all’aria aperta, con evidenti rischi per la sicurezza e l’ambiente. Le gravi carenze nella gestione dei materiali nucleari nella baia di Andreyeva sono emerse nel 1982, quando si verificò una fuga di 600.000 tonnellate di acqua contaminata nel Mare di Barents.Dopo anni di pressioni da parte di Bellona Environmental Foundation, nel 2017 è iniziata la pulizia della baia di Andreyeva. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, rimangono ancora numerose barre di combustibile danneggiate nel sito, conservate in edifici contaminati che richiedono anch’essi smantellamento e smaltimento. Inizialmente, il progetto, per il quale la sola Norvegia ha investito circa 30 milioni di euro (32,6 milioni di dollari), doveva essere completato entro il 2028. Tuttavia, a causa dell’inizio della guerra, Mosca ha posticipato la scadenza agli anni 2030, senza fornire prove dei progressi compiuti. Al di sotto della superficie oceanica, altre minacce attendono di essere affrontate. Il più recente piano di sviluppo dell’Artico di Mosca ha delineato gli sforzi per rimuovere una serie di rifiuti nucleari affondati dai sovietici nei mari di Barents e Kara, inclusi i sottomarini nucleari K-27 e K-159, entro il 2035. Questi sottomarini rappresentano una delle sfide più impegnative per l’operazione di pulizia, contenendo complessivamente un milione di curie di radiazioni, pari a circa un quarto di quelle rilasciate nel primo mese del disastro di Fukushima. Il K-27, varato nel 1962, subì una perdita di radiazioni in uno dei suoi reattori sperimentali raffreddati a metallo liquido dopo soli tre giorni in mare. Nonostante i tentativi della Marina sovietica di riparare o sostituire i reattori nei successivi anni, nel 1979 si arresero e decisero di dismettere il sottomarino. A causa del suo livello di radioattività troppo elevato per essere smantellato convenzionalmente, nel 1982 il K-27 fu rimorchiato nel poligono di test nucleari artici di Novaya Zemlya e affondato in uno dei fiordi dell’arcipelago. Affondare il K-27 a una profondità di soli 33 metri ha richiesto uno sforzo considerevole. Il sottomarino è stato pesantemente appesantito con asfalto per sigillare i reattori pieni di carburante, mentre è stato praticato un foro nel serbatoio di zavorra di poppa. Tuttavia, questa soluzione è temporanea. Il sigillante intorno al reattore è progettato per prevenire perdite di radiazioni fino al 2032, ma dopo tale data, il rischio di contaminazione potrebbe aumentare significativamente. L’altro sottomarino, il K-159, è stato classificato come uno dei sottomarini tossici nel 2003. Situato a nord di Murmansk, proprio nelle vicinanze di alcune delle zone di pesca più ricche del Mare di Barents e delle rotte di navigazione più trafficate, il K-159 è motivo di particolare preoccupazione. Questo gigante arrugginito lungo 305 piedi, già abbandonato da anni, affondò a 240 metri mentre veniva trainato verso un cantiere navale di Murmansk per il suo smantellamento, causando la perdita di nove marinai che erano a bordo per aiutare nel trasporto dell’acqua. A differenza del K-27, per il K-159 non furono adottate misure di sicurezza per proteggere i suoi due reattori prima dell’affondamento, il che significa che è andato giù ancora carico con 800 chilogrammi di combustibile di uranio esaurito. Un eventuale rilascio radioattivo da questo relitto sarebbe devastante non solo per l’industria della pesca norvegese, ma anche per quella russa.Un progetto per recuperare i sottomarini, con un costo stimato di circa 300 milioni di euro, era stato preso in considerazione dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), insieme alla Norvegia e ad altre nazioni europee, che stavano sviluppando uno studio di fattibilità per questa complessa operazione. Tuttavia, con l’inizio della guerra e il congelamento delle attività della Bers, sono stati fatti pochi progressi da parte di Mosca. Questa situazione lascia l’ambiente dell’Artico russo in uno stato di incertezza, con conseguenze imprevedibili. Se Mosca continuerà a dare la priorità alla guerra anziché all’ambiente, non farà altro che prolungare una minaccia radioattiva che potrebbe essere risolta con il sostegno internazionale. Ciò che è chiaro è che la Russia non può affrontare questa sfida da sola.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/guerra-rischio-fughe-radioattive-artico-2668439400.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="serve-un-coordinamento-globale" data-post-id="2668439400" data-published-at="1717344450" data-use-pagination="False"> «Serve un coordinamento globale» Lara Ballurio, giornalista e analista esperta di Russia, come si potranno affrontare e mitigare i futuri rischi ambientali considerando l’attuale clima politico? «L’impatto del nucleare sull’ambiente supera i confini geografici e politici, rendendo cruciale un intervento internazionale coordinato, indipendente dalle tensioni politiche come quelle tra Russia e Ucraina. È importante ripristinare gli accordi pre bellici siglati con il consorzio di Paesi occidentali o sviluppare nuovi trattati per una gestione nucleare sicura e responsabile. Il futuro della rimozione dell’eredità nucleare nell’Artico sarà probabilmente caratterizzato da politiche globali, investimenti in innovazione tecnologica per la decontaminazione radioattiva e la sicurezza nucleare, e collaborazione internazionale sotto rigoroso monitoraggio ambientale. Organizzazioni come l’Agenzia internazionale per l’energia Atomica, impegnata nel controllo della centrale di Zaporoj’e in Ucraina, sono essenziali per coordinare la valutazione dei rischi e la sicurezza dei siti». Come si bilancia la gestione dell’eredità nucleare con le esigenze contemporanee della presenza militare russa nell’Artico? «La gestione dell’eredità nucleare russa nell’Artico si svolge parallelamente a un’intensa attività militare per la quale la Russia investe ingenti somme di denaro. Il 24 maggio scorso, Rossijskaja Gazeta ha riportato la notizia che rappresentanti diplomatici e militari di vari Paesi, definiti “amici della Russia”, sono stati invitati dal ministero della Difesa della Federazione Russa a visitare la Flotta del Nord, dove hanno osservato le capacità militari moderne, inclusi la fregata Ammiraglio della flotta Kasatonov e il sottomarino nucleare Orel, equipaggiato con missili da crociera Kalibr. Queste dimostrazioni di forza, sebbene mostrino avanzamenti in termini di armamenti e strategia militare, sollevano questioni circa la capacità e la priorità data alla gestione dell’eredità nucleare più vetusta. Il sottomarino Orel, per esempio, rappresenta una dualità tra l’innovazione armamentistica e la gestione di tecnologie nucleari obsolete, essendo stato aggiornato per trasportare armamenti moderni ma senza chiari riferimenti alla bonifica o alla sicurezza delle vecchie tecnologie nucleari. Questo scenario evidenzia una possibile discrepanza tra la proiezione di potenza militare e l’effettiva gestione delle complesse sfide legate al nucleare ereditato, suggerendo che l’attenzione potrebbe essere prevalentemente focalizzata sul nuovo, trascurando aspetti critici del “vecchio”». Oltre a Bellona Environmental Foundation, quali sono le organizzazioni che potrebbero giocare un ruolo importante? «Una, ad esempio, è l’Arctic Council, un forum intergovernativo che promuove cooperazione e protezione ambientale nell’Artico, coinvolgendo anche i popoli indigeni. Segue il programma artico del Wwf, concentrato sulla conservazione naturale e l’impatto dei cambiamenti climatici, con un focus sullo sviluppo sostenibile. Inoltre, Greenpeace è attiva contro il trivellamento petrolifero e la pesca insostenibile, sensibilizzando anche sull’inquinamento da rifiuti nucleari. Anche l’Arctic Institute, un think tank indipendente, si dedica alle questioni di sicurezza, politica ed economia della zona, cercando soluzioni sostenibili alle sfide ambientali. Inoltre, queste organizzazioni, svolgendo ricerca, advocacy, sensibilizzazione e collaborazioni, risultano essenziali per mitigare i rischi ambientali nell’Artico».
Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 22 gennaio con Flaminia Camilletti
Dopo la chiusura con il proscioglimento della vicenda giudiziaria che ha riguardato la nota influencer, di buono resta solo lo storico dolce.
Piercamillo Davigo (Ansa)
La vicenda prende forma nel rapporto tra Paolo Storari, sostituto procuratore a Milano, e Piercamillo Davigo, allora consigliere del Csm. È con Storari che si consuma il primo snodo decisivo. Le motivazioni affermano che Davigo non si limita a ricevere informazioni, ma «rafforza e legittima» la scelta di Storari di consegnargli i verbali dell’avvocato Piero Amara, coperti da segreto investigativo. Lo fa prospettando una tesi giuridica che la Corte definisce esplicitamente «tutt’altro che fondata»: l’idea che il segreto non sia opponibile al Csm e, per estensione, al singolo consigliere. Una prospettazione che, secondo i giudici, ha avuto un ruolo causale diretto nella rivelazione, integrando il concorso «dell’extraneus nel reato proprio».
Qui la sentenza insiste su un punto che rende la condotta di Davigo particolarmente grave: la piena consapevolezza delle regole. I giudici ricordano che anche laddove il Csm abbia poteri di acquisizione, questi sono rigorosamente incanalati in procedure formali: soggetti legittimati, passaggi istituzionali, protocollazione, possibilità per l’autorità giudiziaria di opporre esigenze investigative. Nulla di tutto questo avviene. I verbali passano di mano in modo informale, in un incontro riservato, su una chiavetta Usb. Per la Corte non è un dettaglio, ma la prova che Davigo sceglie consapevolmente di porsi fuori dalle regole. Ottenuti gli atti, il comportamento contestato non si ferma. Le motivazioni ricordano che Davigo, «violando i doveri inerenti alle proprie funzioni ed abusando della sua qualità», riferisce l’esistenza di atti coperti da segreto a più soggetti, tra cui il primo presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio e il consigliere Sebastiano Ardita. La Corte è esplicita: Davigo non aveva alcuna legittimazione a divulgare quelle informazioni «al di fuori di una formale procedura». Ed è proprio questo passaggio che porta i giudici a sottolineare come l’ex magistrato abbia agito «ergendosi a paladino della legalità», ma senza titolo. Un aspetto centrale delle motivazioni riguarda gli effetti istituzionali di questa scelta. I giudici parlano di una diffusione selettiva della conoscenza, che genera tensioni, diffidenze e prese di distanza all’interno del Csm. La procedura, osserva la Corte, serve proprio a evitare che notizie delicate circolino in modo incontrollato. Davigo, scegliendo la via informale, accetta - o sottovaluta - questo rischio, contribuendo a un corto circuito istituzionale che nulla ha a che vedere con la tutela della legalità.
La sentenza respinge anche uno degli argomenti difensivi più ricorrenti nel dibattito pubblico: l’assoluzione di Storari non travolge la responsabilità di Davigo. La condanna a un anno e tre mesi di reclusione segna così una cesura netta nella parabola del dottor Sottile, il cui comportamento è descritto dai giudici come abusivo, consapevole e privo di legittimazione. Ottima pubblicità per il Sì al referendum.
Continua a leggereRiduci
Donald Trump (Ansa)
È stata una giornata di tensione, quella di ieri, tra le due sponde dell’Atlantico. Mentre l’Europarlamento sospendeva indefinitamente la ratifica dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Ue, Donald Trump è intervenuto al Forum di Davos, tenendo un intervento battagliero in cui ha criticato i Paesi europei su svariati fronti. «Certi luoghi in Europa, francamente, non sono più riconoscibili», ha dichiarato. «Vorrei che l’Europa andasse bene, ma non sta andando nella giusta direzione», ha aggiunto, citando «l’aumento della spesa pubblica, l’immigrazione di massa incontrollata e le importazioni straniere senza fine». «Qui in Europa abbiamo visto il destino che la sinistra radicale ha cercato di imporre all’America», ha anche affermato. Trump ha poi criticato il Vecchio continente sulla questione energetica. «Grazie alla mia vittoria elettorale a valanga, gli Stati Uniti hanno evitato il catastrofico collasso energetico che ha avuto luogo in ogni nazione europea, che ha perseguito il “Green new scam”: forse il più grande imbroglio della Storia», ha dichiarato, storpiando il nome del Green new deal («scam», in inglese, significa infatti «truffa»). Sotto questo aspetto, l’inquilino della Casa Bianca ha messo nel mirino l’energia eolica e ha sottolineato come il ricorso alla tecnologia green aumenti la dipendenza da Pechino. «Più turbine a vento ha un Paese, più ci perde. Gli stupidi le comprano, ma la Cina vince», ha detto. Trump è poi andato all’attacco della Danimarca sulla questione della Groenlandia («un pezzo di ghiaccio in cambio della pace»). «La Danimarca è caduta in mano alla Germania dopo appena sei ore di combattimenti ed è stata totalmente incapace di difendere sia sé stessa sia la Groenlandia. Quindi gli Stati Uniti sono stati costretti a farlo e lo abbiamo fatto», ha tuonato, riferendosi all’invasione della Danimarca da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. Il presidente americano ha inoltre bollato Copenaghen come «ingrata», ribadendo di aver bisogno della Groenlandia per una necessità di «sicurezza nazionale strategica». Al tempo stesso, Trump ha però escluso l’uso della forza per acquisire l’isola più grande del mondo. «Non devo usare la forza, non voglio usare la forza, non userò la forza. Tutto ciò che gli Stati Uniti chiedono è un posto chiamato Groenlandia», ha dichiarato, senza tuttavia rinunciare a mettere sotto pressione gli europei. «Potete dire di sì e vi saremo molto grati, oppure potete dire di no e ce ne ricorderemo», ha infatti affermato, riferendosi all’acquisizione dell’isola. In questo quadro, il presidente americano ne ha anche approfittato per dare una bacchettata alla Nato. «Gli Stati Uniti sono trattati in modo molto ingiusto dalla Nato. Diamo così tanto e riceviamo così poco in cambio». Insomma, Trump non ha risparmiato dure critiche agli alleati europei. Ma il presidente americano, ieri, si è occupato anche di vari dossier internazionali, a partire della crisi ucraina. «Credo che ora siano arrivati al punto in cui possono unirsi e raggiungere un accordo», ha affermato, parlando di Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. «Se non ci riescono», ha continuato, «sono stupidi. Questo vale per entrambi. E so che non sono stupidi. Ma se non ci riescono, sono stupidi». Ieri pomeriggio, la Cnn ha, in particolare, riferito che Trump dovrebbe incontrare oggi il presidente ucraino a Davos. Ma non è tutto. Oltre a sottolineare di avere un «ottimo rapporto» con il leader cinese, Xi Jinping, l’inquilino della Casa Bianca si è infatti espresso anche sul Medio Oriente, auspicando che Hamas proceda con il disarmo. «Se non lo faranno, saranno spazzati via. Molto rapidamente», ha affermato, per poi rivendicare gli attacchi statunitensi di giugno ai siti nucleari iraniani. «Erano molto vicini ad avere un’arma nucleare e li abbiamo colpiti duramente, e la distruzione è stata totale», ha detto. Tra l’altro, proprio ieri, il cardinal segretario di Stato, Pietro Parolin, ha reso noto che Trump ha invitato papa Leone XIV a entrare nel Board of peace per Gaza. Inoltre, sempre ieri, l’inquilino della Casa Bianca, a margine del Forum di Davos, ha avuto degli incontri con il presidente polacco, Karol Nawrocki, con quello egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, e con quello elvetico, Guy Parmelin, oltre che con il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte. Con quest’ultimo, Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo sulla Groenlandia che, se dovesse concretizzarsi, offrirebbe un’«ottima soluzione» per i Paesi della Nato e scongiurerebbe i nuovi dazi americani ai Paesi europei.Nel suo intervento in Svizzera, Trump ha parlato anche di questioni interne: ha definito Jerome Powell uno «stupido», rendendo noto che annuncerà presto la scelta del suo successore. La centralità è comunque spettata alla politica internazionale, con speciale riferimento, alle crescenti tensioni con gli alleati europei. In particolare, chi, nel Vecchio continente, sta tornando a premere per la linea dura nei confronti della Casa Bianca è Emmanuel Macron che, proprio ieri, Trump ha deriso per gli occhiali da sole con cui si era presentato martedì. Il presidente francese sta del resto cercando di spingere Bruxelles a ricorrere allo strumento anti coercizione: uno scenario che acuirebbe le fibrillazioni transatlantiche. Non dimentichiamo che il vicepremier cinese, He Lifeng, ha criticato i dazi statunitensi. E che l’inquilino dell’Eliseo ha rafforzato i legami con Pechino. In Svizzera sta, insomma, andando in scena uno scontro geopolitico particolarmente serrato. Tuttavia, spingendo sul pedale della linea dura con Washington - soprattutto su input francese - gli europei rischiano di finire tra le braccia della Cina. Il che non sarebbe uno scenario esattamente allettante.
Continua a leggereRiduci