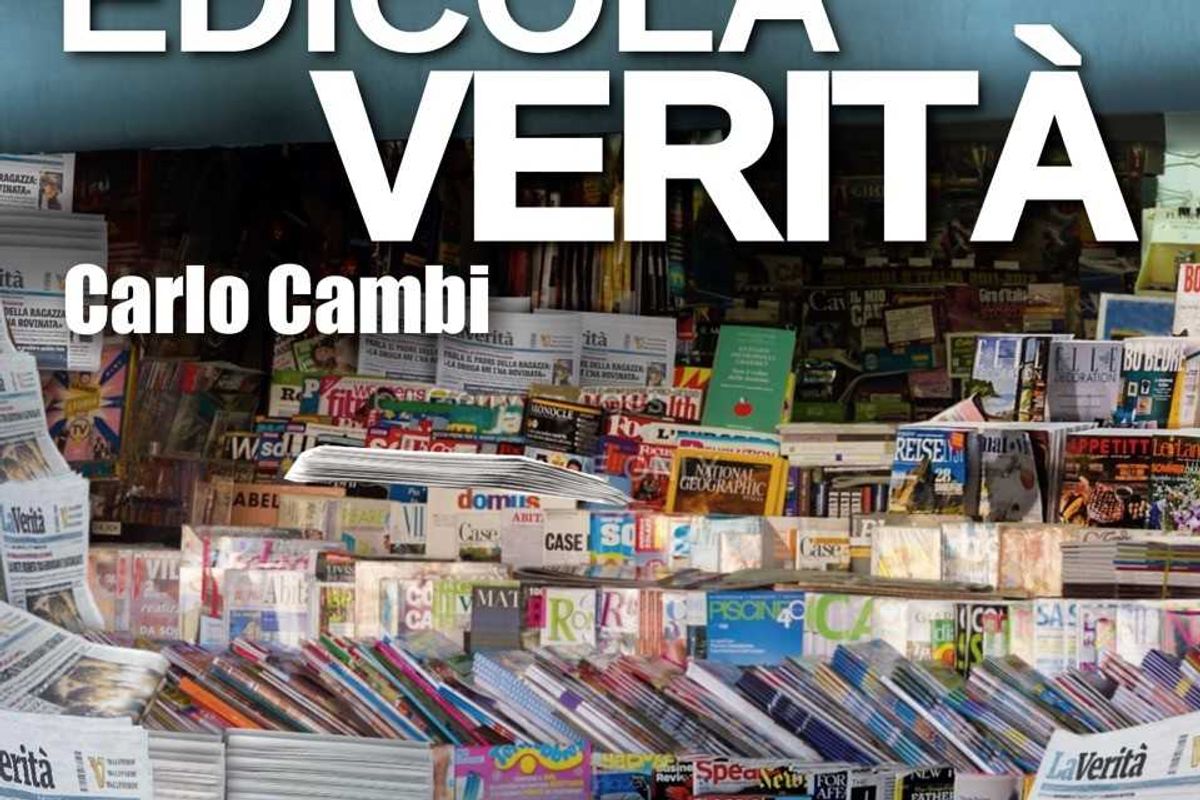Rimettersi in gioco prossimi al giro di boa della mezza età non è da tutti, ma con Gualtiero Marchesi la regola era «mai dire mai» ai sogni da far diventare realtà concreta, e se a tavola ancor meglio. Il 1977 è un anno importante. Assieme all’inaugurazione della sua creatura in via Bonvesin de la Riva esce anche il suo primo libro, La mia nuova grande cucina italiana, una specie di manifesto del Gualtier-pensiero a dimensione culinaria e non solo. Diventa in breve un centro di gravità permanente di chi sente che la cucina italiana è a un punto di svolta, con Marchesi apripista.
Quando il ristorante osservava, di lunedì, il turno di riposo, in realtà in cucina era tutto uno sfornellare idee, con i capo partita a proporre ognuno le proprie ricette sotto la supervisione del Maestro. Nasce poco dopo Altopalato, una sorta di cenacolo artistico a dimensione (anche) gourmet, in collaborazione con Toni Sarcina (storica gastropenna) ed Eugenio Medagliani, il «calderaio umanista», già al suo fianco dai tempi de Al mercato. Si discuteva di tutto un po’, abbinando cucina e duetti di musica rinascimentale.
Accanto a una clientela sempre più mirata che arrivava apposta per vivere in diretta le creazioni che uscivano dalla cucina, non potevano mancare le inevitabili note di colore. A un pranzo del fine settimana si presenta un nobile cavaliere con il suo destriero arrivati al trotto dal Piemonte. La biada è stata servita a parte, ovviamente, e in un garage vicino. Oppure quella sera che si presenta David Rockfeller, il re della finanza. Mentre il Divin Gualtiero gli illustrava i piccoli segreti del suo riso, oro e zafferano, arriva la moglie Antonietta, pianista talentuosa, reduce da un concerto alla Scala in cui, per ringraziare il giovane violinista che l’aveva fatta volare tra le stelle (del pentagramma), come premio lo aveva invitato a cena nel locale di famiglia. Inevitabile che al giovane emulo di Paganini venisse richiesto dal palato yankee di improvvisargli in diretta un po’ di Vivaldi per allietargli il dessert del buon ritorno.
Il seguito è un susseguirsi di meritati riconoscimenti per una cucina che vede in Marchesi ispirato direttore d’orchestra. Sua è la famosa frase: «La musica è l’altra parte della mia essenza. Ho rinunciato a suonare solo per la cucina». L’importante è arrivare alla meta e la terza stella, primo in Italia, premia il genio di Marchesi nel 1985. L’anno dopo Francesco Cossiga lo nomina Cavaliere della Repubblica cui seguirà, nel 1991, il riconoscimento di Commendatore, forse per fare il paio con Jack Lang, il ministro francese della Cultura che l’anno prima gli aveva consegnato la fascia di Cavaliere delle arti e delle lettere e, sapendo quanto i cugini d’Oltralpe abbiano il braccino corto nel concedere i massimi onori ai foresti, figurarsi in cucina, assume ulteriore valore aggiunto.
Nel frattempo aveva avviato un locale a Londra che si aggiudicò in breve tempo la stella conseguente, galeotto il «solito» riso zaffirodorato. I tempi cambiano, la Milano da bere non è più la stessa, Tangentopoli è dietro l’angolo. Gualtiero sbuffa, sempre più stretto tra quelle atmosfere urbane che progressivamente ne vanno frenando il suo desiderio di buono e bello, in sana armonia artistica con le diverse ispirazioni che gli arrivano dal confronto con i migliori artisti dell’epoca. Poco prima del Natale 1992 l’ultima cena, un banchetto di nozze, così da rendere felici i due novelli sposi a futura memoria. Ai giornalisti che gli chiedono come mai abbia voluto abbassare la serranda tristellata confessa: «Il mio ristorante non era stato concepito per essere una fabbrica di soldi, ma una sorta di laboratorio con uso di cucina dove il maestro opera, insegna e controlla quello che gli allievi eseguono». Con la soddisfazione conseguente dei clienti che, a fronte delle sue nuove e vulcaniche proposte, continuano a chiedere gli evergreen che via via li avevano fidelizzati.
Non c’è storia. «Cari signori, vado in campagna». Non torna certo nella nativa San Zenone Po dei genitori, ma lo zampino padano si manifesta nella figura del conterraneo Gianni Brera, con il quale si divertiva a condividere scappatelle fuori porta a suon di fette di formaggio e salame caserecci. Era stato lo stesso «Arcimatto» a segnalargli come, nella bresciana Franciacorta, «un certo» Vittorio Moretti aveva intenzione di aprire un locale di qualità per accompagnare le sue etichette che via via facevano concorrenza allo storico champagne.
L’Albereta viene inaugurata nel settembre del 1993. C’è qualche piccola difficoltà logistica. Antonietta, l’amata moglie e regina della cucina domestica, non ha la patente; alloggiare tra i colli dell’accogliente Franciacorta non è proprio la stessa cosa per chi ha vissuto da sempre in città, ma le buone tradizioni non mancano e, nel piccolo teatro locale, organizzeranno anche dei concerti … fuori carta dal menù. Gualtiero si sente più libero. Grazie anche a un viaggio in Giappone, alla scoperta della cucina kaiseki, riesce ancor meglio a realizzare la sua filosofia, cioè quella della «bellezza e armonia, legando il sapore del cibo all’estetica del piatto».
È un’altra eruzione vulcanica di creatività e talento. Affiancata da degni compagni d’avventura. Un vetraio di Murano, Nason Moretti, gli sdoppia i bicchieri dell’acqua, così che questa «sale di rango e si affianca al vino». Alti e stretti per la gasata, così da trattenere più a lungo le bollicine. Larghi e panciuti quelli dell’acqua normale. Broggi, un abile artigiano bresciano già fornitore di casa Savoia, dà forma alle sue intuizioni. L’attenzione delle posate si sposta, dal manico alla parte funzionale. Le forchette possono essere a quattro rebbi lunghi per arrotolare gli spaghetti, come a due, più corti, per inforcare la carne che verrà prima incisa (non tagliata) da un coltello a lama finissima «perché quello seghettato lo lasciamo alla pizza». E così via con altro corredo che il cliente goloso si vede servito al tavolo via via che scorre la comanda, consigliato da un maître di sala che deve essere pari «a un direttore d’orchestra gastronomica e non un semplice capostazione» che regola entrata e uscita dei piatti dalla cucina ai tavoli.
I labari si susseguono sulla casacca tristellata, come ad esempio la laurea honoris causa in Scienza dell’alimentazione assegnatagli nel 2001 dalla romana Universitas Sancti Cyrilli. Star dei fumetti disneyani, con Paperino che elogia il ricettario di Gualtiero Barchesi, ma anche nel cinematografico Ratatouille, dove è chiamato a dar voce a un ispettore un po’ impacciato che finisce in una cella frigorifera appeso come un salame. Per un uomo di cucina e cultura amante dell’arte ecco la statuina dedicata, omaggio di Libero Gozzini.
Per chi ha avuto l’occasione di aggirarsi tra le sale dell’Albereta non mancherà il ricordo delle pareti alle quali erano appese le eccellenze accademiche a fianco di queste citazioni più allegre e ironiche, a testimonianza di due dei maggiori tratti di Gualtiero Marchesi. Uno sconfinato amore per l’arte, abbinato a un’informale ironia, sempre pronta al sorriso, per primo su sé stesso, tanto che, quando un cronista gli chiese che piatto avrebbe voluto essere, l’immancabile risposta è stata: «Un pollo da spennare». Uno stile che non si smentisce mai.
Nel 2002 decide di sbarcare a Roma, per rilevare la storica Hostaria dell’Orso. Prima dell’inaugurazione del ristorante, «venne a trovare i colleghi più conosciuti per avvisarli in prima persona della sua nuova avventura», come ama ricordare il grande chef tristellato Heinz Beck.